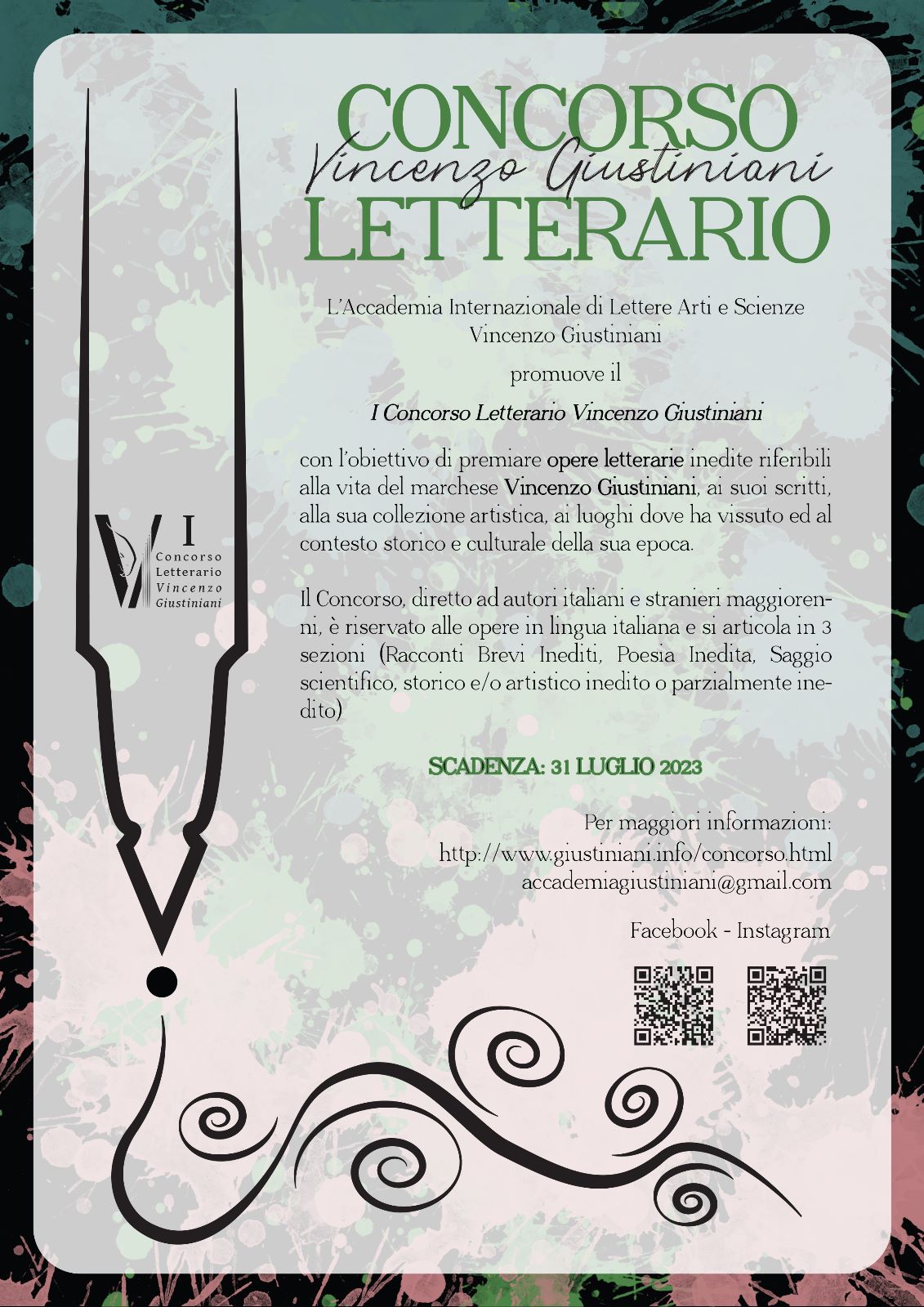LA COLLEZIONE GIUSTINIANI
La collezione di Giuseppe Giustiniani
Tra le prime opere entrate a far parte della collezione Giustiniani vi furono quelle del 1582 di Bernardo Castello, quindi l'Adorazione dei magi (oggi alla Walters Art Gallery di Baltimora) e la Predica di san Vincenzo Ferreri al Concilio di Costanza nella chiesa della Minerva. Specificatamente alla seconda opera, compaiono tra i committenti anche Giorgio (fratello del cardinale Vincenzo) e forse Benedetto Giustiniani, che richiesero la tela per la chiesa di Santa Costanza di Roma, al fine di onorare la morte dello zio cardinale Vincenzo avvenuta nello stesso anno (nella scena sono raffigurati anche i ritratti dei committenti, compresi i figli di Giuseppe e il cardinale defunto).
La Galleria Giustiniana appena nata comprendeva al tempo prevalentemente opere del Cinquecento italiano, quindi di Luca Cambiaso, Benvenuto Tisi da Garofalo, Bramantino, Lorenzo Lotto, Francesco Vecellio, Francesco Salviati, Bronzino, Paolo Veronese e altri. Successivamente la stessa si arricchirà anche delle opere collezionate autonomamente dai figli di Giuseppe, Benedetto e Vincenzo: per distinguere l'effettiva appartenenza delle tele, sul retro delle medesime erano i sigilli identificativi del committente, quindi "GG" per Giuseppe, "BG" per Benedetto e "VG" per Vincenzo.
Alla morte di Giuseppe Giustiniani, nel 1600, viene stilato il primo inventario in assoluto della collezione (composta all'epoca da 108 dipinti), la quale sarà interamente ereditata, con anche il palazzo, dal primogenito, il cardinale Benedetto. La collezione Giustiniani apparirà nel Seicento frutto di due distinte raccolte, ossia dei due figli di Giuseppe, seppur tutta conservata (almeno nella parte pittorica) entfo il palazzo Giustiniani di rappresentanza, dove avranno dimora sia Benedetto, i cui appartamenti privati occupavano la maggior parte dell'edificio, che Vincenzo, i cui appartamenti, una decina in totale (quattro sul piano nobile, altre quattro al secondo piano e due al piano terra), sono tutti rivolti sul lato posteriore che dà al Pantheon.
La collezione del Cardinale Benedetto Giustiniani
Il cardinale Benedetto era un collezionista d'arte interessato per lo più a opere a tema religioso-cattolico, richieste sia a Roma che Bologna, in quest'ultima città dove visse alcuni anni durante la carriera cardinalizia; nella sua attività sono frequenti anche commesse di opere pubbliche, come quelle della chiesa di Santa Prisca di Roma, dove fu lui stesso a commissionare le decorazioni della navata centrale con gli affreschi raffiguranti Apostoli, angeli e santi, realizzati dal pittore fiorentino Anastasio Fontebuoni nell'anno 1600, così come la pala dell'altare maggiore dello stesso anno, raffigurante San Pietro che battezza santa Prisca, opera del Passignano.
Stando a quanto scritto dal Carlo Cesare Malvasia su Benedetto, il cardinale era un amatore delle pitture di Francesco Francia, che compariva nella collezione con otto dipinti (tra cui la Madonna col Bambino e san Giovannino, oggi alla Gemäldegalerie di Berlino e l'Allegoria della Castità, oggi al Museo Lazaro Galdiano di Madrid) e Bernardo Castello, pittore genovese che sarà molto attivo in casa Giustiniani.
San Girolamo in meditazione, Caravaggio
La "Guardarobba" di Benedetto era collocata al terzo piano e in alcune sale del sottotetto di palazzo Giustiniani, mentre una parte della raccolta (43 dipinti in totale) erano conservati nella nota Galleria Giustiniana del piano nobile, tra cui: la Natività di Tiziano, la Madonna col Bambino e agnello di Ludovico Carracci (i Carracci erano presenti nell'inventario con cinque opere), il Cristo morto con due angeli di Paolo Veronese (nella Galleria Giustiniana), il San Carlo Borromeo in preghiera davanti al crocifisso di Giovanni Lanfranco, Maria Maddalena nel deserto di Giovanni Andrea Donducci, tre tele del Ribera, San Pietro, San Giacomo e la Maddalena in estasi, la cospicua serie di ritratti di Scipione Pulzone, quindi di Pio V, del cardinale Bessarione, di Gregorio XIII, di Sisto V, di Clemente VIII, del cardinale Montalto, del cardinale Aldobrandini, del cardinale Borromeo, ma anche opere di Barocci, del Cigoli, di cui un Cristo nel fiume Giordano (nella Galleria Giustiniana) e un San Francesco, del Bassano, di cui erano tre quadri con animali e paesaggi, di Jan Brueghel il Vecchio, di cui sei tele, del Caravaggio, che era presente con la Maddalena, il San Girolamo in meditazione (entrambi nella Galleria), il Cristo nell'orto, l'Incredulità di san Tommaso e il Ritratto di Benedetto, poi anche la Caduta di Lucifero (nella Galleria), nota in due versioni, una con l'Amore divino vestito con armatura e una con gamba scoperta) di Giovanni Baglione (presente nella collezione con cinque opere), il Giudizio, il Diluvio, il Paradiso, l'Inferno, l'Adorazione dei magi e l'Incendio di Troia, quattro nature morte di Francesco Zucchi, registrate nello studio privato di Benedetto, un San Giuseppe e la moglie di Putifarre dell'Orbetto, undici tele sugli Apostoli di Francesco Albani e altre ancora.
Nel 1621 Benedetto muore: gran parte della collezione (composta da 283 dipinti, e solo qualche sporadico reperto d'antichità collocato nei giardini della villa del Popolo) fu pertanto trasferita al fratello Vincenzo, quindi sia la raccolta ereditata dal padre così com'era (forse con solo qualche opera in meno rispetto al lascito originario) che le opere commissionate dal cardinale stesso, ad esclusione di quelle[13] destinate alla distribuzione agli amici fedeli, come al cardinale Ubaldini, cui andò un tondo con la Madonna col Bambino di Giulio Romano, o come al cardinale Alessandro Montalto, cui andò l'Annunziata del Parmigianino. La sepoltura avvenne dentro la cappella di famiglia intitolata a san Vincenzo, nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva a Roma, dov'erano già tumulati gli zii, il cardinale Vincenzo e Giorgio, il padre Giuseppe e i tre figli del marchese Vincenzo, morti prematuramente.
La collezione del Marchese Vincenzo Giustiniani
Vincenzo Giustiniani era un uomo colto, amante delle arti a 360 gradi, quindi della pittura, della scultura, dell'architettura, della letteratura teatrale e della musica, scopritore di talenti artistici nuovi e aperto a vedute stilistiche anche in controtendenza con quegli anni.
La sua collezione era disposta negli ambienti di sua pertinenza all'interno del palazzo Giustiniani, costituendo di fatto i luoghi più noti e menzionati dai viaggiatori circa la collezione di famiglia: nelle quattro sale al secondo piano il marchese aveva dimora abituale, al piano nobile era la famosa "Galleria Giustiniana", lunga sala verticale condivisa col fratello Benedetto dov'erano i pezzi più importanti della collezione (nella quale il marchese tuttavia esporrà solo 16 dipinti della sua collezione, undici dei quali ereditati a sua volta dal fratello cardinale), due al pian terreno, di cui una adibita alla conservazione di marmi e bassorilievi antichi, mentre circa le tre sale che costituivano le famose "stanze de' quadri antichi" non è chiara quale fosse l'ubicazione, di certo si sa che erano ambienti dov'erano opere esclusive del marchese.
Nel 1607 il marchese acquistò per 300 scudi sul mercato d'antiquariato di Roma la prima versione del Cristo portacroce (1514-1516) di Michelangelo, una statua non più in linea con gli orientamenti della Controriforma, e quindi rigettata dalla chiesa dove questa doveva insistere, Santa Maria sopra la Minerva, e reimmessa sul mercato d'arte privato. L'opera fu restaurata da un giovane Gian Lorenzo Bernini, scultore che sostanzialmente mancherà quasi del tutto nel catalogo Giustiniani, anche perché il marchese lo considerava eccessivamente oneroso.
Ritratto d'uomo (Sigismondo Laire?), Jusepe de Ribera
La collezione di opere di antichità, che con il marchese avrà il suo exploit, arrivando alla sua morte a contare 1.100 pezzi, era distribuita tra le varie proprietà immobiliari di famiglia. Questa fu frutto della svolta classicista del Seicento romano, negli anni dopo quelli '20, quando si è esaurita l'eco della pittura caravaggista in favore di quella di autori come Poussin o di scultori contemporanei come Francois Duquesnoy, i quali proprio a partire da quel momento iniziano a comparire negli inventari Giustiniani: dello scultore francese sono registrati impegni per una Madonna col Bambino e un Mercurio (non rintracciati), mentre del pittore giungeranno nella raccolta tre dipinti oggi sparsi in diversi musei. La collezione di antichità proveniva essenzialmente dai ritrovamenti dei reperti avvenuti durante gli scavi dei circondari su cui insistevano le proprietà immobiliari della famiglia, quindi a Bassano Romano, nei lotti circostanti ai palazzi romani, ma anche negli scavi per l'edificazione della chiesa di Santa Maria sopra Minerva, edificio di culto che risulterà centrale nella vita della famiglia, soprattutto grazie allo zio Vincenzo e al fratello Benedetto. Nella prima galleria del palazzo di rappresentanza, ampia 18×7 cm, erano sistemate almeno 247 opere, tra busti e sculture, disposte senza un ordinamento sistematico, in controtendenza rispetto ai gusti dell'epoca, che invece vedeva le sculture inserite in una cornice architettonica ad hoc (ad esempio entro delle nicchie, come accadeva per quelle della collezione Borghese o Ludovisi, tra le due più rilevanti in questo senso al tempo).
Vincenzo divenne unico proprietario del palazzo di rappresentanza alla morte nel 1621 del fratello Benedetto, così come di quello a porta del Popolo e della villa di Bassano Romano; egli iniziò a commissionare opere più laiche che religiose, anche a soggetto stoico, come la Morte di Seneca di Joachim von Sandrart, la Morte di Cicerone di Francois Perrier, la Morte di Socrate di Josse de Pape (alias Giustino Fiammingo). Nelle "stanze de' quadri antichi" di Vincenzo erano segnalate un numero particolarmente elevato di opere, tra cui alcune di Scipione Pulzone, di cui il San Vincenzo e il San Girolamo nel deserto, ben tredici tele di un giovane Jusepe de Ribera, quindici di Francesco Albani (di cui Gesù, Maria, San Giovanni Evangelista, un Apostolo e altre undici già del fratello cardinale), diverse di Giovanni Baglione, tra cui le due versioni dell'Amor sacro e l'amor profano (di cui una che nell'inventario di Benedetto era titolato come Caduta di Lucifero), undici dei Carracci e soprattutto alcune opere del Caravaggio, con cui il marchese instaurerà un rapporto lavorativo che fungerà, assieme a quello che il pittore lombardo ebbe col cardinale Francesco Maria Del Monte, quest'ultimo amico dello stesso Vincenzo, il più importante trampolino di lancio del Merisi sulla scena artistica romana del Seicento. Nelle stanze di cui sopra erano altresì esposti anche dodici busti di imperatori romani (i Cesari) del XVII secolo, già appartenuti a Benedetto, che saranno poi ricollocati nei secoli successivi entro la villa di Bassano Romano.
Le committenze Caravaggesche
«[...] tanta manifattura gli era a fare un quadro buono di fiori, come di figure.»
(Lettera di Vincenzo Giustiniani a Teodoro Amayden in cui parla di Caravaggio.)
Tra i sodalizi più riusciti e influenti nella storia dell'arte vi è senza dubbio quello avuto tra Vincenzo Giustiniani e Caravaggio, all'epoca già sotto la protezione del cardinale Francesco Maria Del Monte, che dai documenti di archivio risulta quasi sempre comparire il nome del marchese nei punti in cui è citato il pittore lombardo. Vincenzo riuscirà a conservare presso la propria collezione ben quindici opere, costituendo di fatto, assieme a quella Borghese e quella cardinale Del Monte, una di quelle con più opere del Merisi. La prima commissione al Merisi fu quella del 1595-1596 con il Suonatore di liuto (oggi all'Ermitage di San Pietroburgo), soggetto che sarà replicato l'anno seguente dallo stesso autore per la collezione del Del Monte, a cui poi seguitò nel 1597 il Ritratto della cortigiana Fillide (oggi perduto).
San Matteo e l'angelo (I versione), Caravaggio
I rapporti di interscambio culturale tra il marchese e il cardinal Del Monte, quest'ultimo che dimorava nel palazzo Madama sito di fronte al nobile genovese, si strinsero ancor di più dopo che il Giustiniani acquistò la prima versione del dipinto del San Matteo e l'Angelo di Caravaggio, realizzata nel 1602 dal pittore la cui commessa avvenne forse per intercessione proprio del Del Monte. La pala doveva adornare l'altare della cappella Contarelli nella chiesa di San Luigi dei Francesi, sita nella stessa strada dove avevano dimora i due illustri, tuttavia la tela fu immediatamente rifiutata dalla Chiesa per motivi di decoro, a causa dei piedi ignudi di san Matteo nonché di alcune ambiguità che si riscontrano sui gesti dei due personaggi ritratti (il santo e l'angelo), pertanto l'opera venne acquistata dal marchese Vincenzo ed entrò a far parte delle sue collezioni.
Al 1602 risale un'altra grande commessa avanzata al Merisi, ossia quella dell'Amor vincit omnia, pagato dal committente 300 scudi. Il quadro divenne subito, insieme al Suonatore di liuto, quello più bello e celebre della collezione Giustiniani, coperto dal marchese con una tenda di taffetà che veniva rimossa solo per illustri visitatori, tra i quali vi erano molti poeti gli dedicavarono epigrammi e madrigali, mentre Giovanni Baglione, rivale del Caravaggio, realizzerà su richiesta del cardinale Benedetto, nello stesso giro di anni, una propria (duplice) versione del soggetto dell'Amore divino, che era in contrapposizione con quello terrestre del Merisi (Amore terrestre).Tra le altre opere eseguite dal Merisi per i Giustiniani vi furono anche l'Incoronazione di spine del 1603, della quale è pressoché certa la paternità della commessa a Vincenzo, e un altro gruppo di tele che vengono invece assegnate alle volontà del cardinale Benedetto, quindi l'Incredulità di san Tommaso del 1600-1601, segnalata nella quadreria di Benedetto già durante i suoi anni a Bologna, il Cristo sul Monte degli Ulivi del 1604-1606, il San Girolamo in meditazione del 1605, un Sant'Agostino, la Maria Maddalena (in cui la santa è descritta nell'inventario del 1638 come «nuda, scapigliata e penitente») e il Ritratto del cardinale.
Il marchese, grazie ai meriti personali di intenditore d'arte, ma soprattutto al ruolo ecclesiastico raggiunto da Benedetto, entrava a far parte in soventi occasioni nelle commissioni di valutazione di opere pubbliche: in talune di queste circostanze, risulta quale valutatore anche di opere del Caravaggio, come nelle pale di Santa Maria del Popolo, o in quella di Sant'Agostino in Campo Marzio, o in Santa Maria della Scala, dov'è registrato in un pagamento in favore dello stesso pittore, di 50 scudi, a titolo di acconto, per il quale intercedette affinché questi completasse la realizzazione della Morte della Vergine, tela che verrà poi completata nel 1604 circa ma comunque rifiutata (anch'essa) dall'ordine religioso perché il tema affrontato non appariva in linea con l'iconografia classica.
Alla morte di Vincenzo, nel 1638, venne redatto un inventario dal quale risultava che a quel momento la collezione disponeva di ben quindici dipinti assegnati a Caravaggio, seppur ne sono stati identificati a oggi solo otto, tutti collocati nelle "Sale de' quadri antichi" di palazzo Giustiniani: il Suonatore di liuto, il San Girolamo in meditazione, l'Incoronazione di spine, il San Matteo e l'angelo, il Cristo nell'orto, il Ritratto di Fillide, l'Amor vincit omnia e l'Incredulità di san Tommaso, a cui si aggiungono il Ritratto del cardinale Benedetto Giustiniani, la Maddalena e il Sant'Agostino, un Ritratto di cortigiana questi ultimi quattro oggi non pervenuti, e altre due opere assegnate già all'epoca quali presunti dipinti di mano del Caravaggio, quindi il Ritratto di donna (Marsilia Sicca?) e il Ritratto d'uomo (avvocato Prospero Farinacci?), anche questi due non rintracciati.
L'inventario di Vincenzo Giustiniani del 1638
Gli inventari seicenteschi della collezione furono molteplici (oltre al primo, del 1600, vi furono poi uno nel 1608 e un altro nel 1621), tuttavia alla morte di Vincenzo Giustiniani, nel 1637, ne venne stilato un altro, datato 1638 che costituisce una delle risorse più importanti, da un punto di vista documentaristico e critico, sulla storia del collezionismo nella prima metà del Seicento, in quanto particolarmente dettagliato anche nella descrizione delle opere oltre che nelle assegnazioni delle medesime. Accanto all'inventario, fu redatto anche un primo fidecommesso che vincolava e teneva legata tutta la collezione alla famiglia.
A questa data la collezione Giustiniani aveva quasi triplicato in quantità quella di Benedetto, contando 632 dipinti (di cui 584 nel palazzo di rappresentanza, 8 nel palazzo di Porta del Popolo, 1 in quello del Laterano e 39 a Bassano Romano) e ben oltre le 1600 sculture di antichità, distribuite tra le varie residenze di famiglia, che rappresentano la vera peculiarità della sua collezione rispetto a quella di Benedetto, per le quali poco prima di morire il marchese si occupò di finanziare la realizzazione di un'opera a stampa in due volumi (di cui il primo curato da Joachim von Sandrart, che tra il 1629 e il 1635 fu incaricato di acquistare numerosi dell'antichità, circa 270 pezzi, per la collezione), "La Galleria Giustiniana", dov'erano 330 incisioni che riproducevano gli esemplari più importanti della sua raccolta archeologica.
Le proprietà della famiglia restavano il palazzo Giustiniani nei pressi di piazza Navona, la casina di piazza del Popolo, la villa di San Giovanni in Laterano e un'altra a Bassano Romano, per la quale il marchese incaricò di eseguire gli affreschi che decorano gli interni a diversi autori, tra cui Bernardo Castello, di cui le Storie di Amore e Psiche, il paesaggista Antonio Tempesta, che lavorò anche nell'edificio di rappresentanza a Roma, Paolo Guidotti, che compì cicli nella sala della Felicità eterna (1610), Francesco Albani, che nella Galleria eseguì le Storie di Fetonte (1609-1610) e infine il Domenichino, che nel camerino di Diana realizzò le Storie della dea sul soffitto (1609). Sempre per Bassano Romano, il marchese stilò dei dettami in merito alla costruzione del borgo che sarebbe dovuto sorgere intorno alla chiesa di famiglia di San Vincenzo Martire, stabilendo l'obbligo per il successore, il principe Andrea, di spendere almeno una somma pari a mille scudi l'anno per tale fine.
Villa Giustiniani, Bassano Romano
Morto il marchese Vincenzo, visto che i tre figli di questi avuti con Eugenia Spinola (Giovanni Gerolamo, Gerolama e Porzia) morirono anteriormente al padre, ancora in tenera età, mentre il cardinale fratello non ebbe prole, tutti i beni della famiglia passarono in eredità al pronipote Andrea Giustiniani, I principe di Bassano Romano. Andrea era imparentato con Vincenzo e Benedetto non in linea diretta, in quanto era figlio di Cassano, a sua volta figlio di cugini da parte della madre dei due fratelli, che ascese nella società nobiliare romana grazie anche alle nozze con Maria Pamphilj, figlia di Pamphilio Pamphilj e Olimpia Maidalchini, nonché nipote di papa Innocenzo X.
Dal subentro di Andrea, che si ritrovò subito a saldare alcuni pagamenti riferiti a commissioni già avviate da Vincenzo,ha inizio il vero e proprio ramo Giustiniani di Roma, che durò dalla seconda metà del Seicento, fino al 1826, con l'estinzione del casato in favore di quello Giustiniani Bandini, quest'ultimo ramo nato grazie alle nozze di Caterina Giustiniani con Pietro Antonio Bandini (ereditiere di una quota della Pietà Bandini di Michelangelo).
La collezione del Principe Andrea Giustiniani
Il lascito testamentario della collezione Giustiniani prevedeva un fidecommesso che vincolava la medesima ad Andrea, del ramo de Banca (mentre Vincenzo e Benedetto erano del Negro), pronipote da parte materna del marchese, senza la possibilità di cedere alcun pezzo della raccolta, pena il pagamento del doppio del prezzo ricavato dalla eventuale vendita. Nel 1644, dopo il completamento della chiesa-mausoleo di famiglia titolata a san Vincenzo di Bassano Romano, il principe Andrea trasferì lì, con apposito documento che lasciava comunque i pezzi alla proprietà del fidecommisso, il Cristo Portacroce di Michelangelo, già al piano terra del palazzo romano, il dipinto su San Vincenzo Martire di Timan Arentsz Cracht e la tela di Giustino Fiammingo della Madonna col Bambino e san Giovannino (copia da Francesco Vecellio).
Statua Giustiniano, pastiche dell'antichità voluto dal principe Andrea per la villa Giustiniani in Laterano. Si tratta dell'unica opera già in collezione rimasta tutt'oggi in situ.
Nel 1649 l'abate Michele Giustiniani ottiene licenza di esportare a Napoli 27 ritratti di uomini della collezione,[44] mentre il cardinale Orazio Giustiniani, confessore del marchese Vincenzo con un ruolo di rilievo all'interno della Congregazione di San Filippo Neri della chiesta della Vallicella, che si rivelò decisivo anche negli accordi matrimoniali tra il principe Andrea e Maria Pamphilj e che abitava il palazzo romano di famiglia almeno dal 1646, lasciava in eredità la sua modesta raccolta (di cui il pezzo più rilevante è l'Autoritratto con pennacchio di Nicolas Régnier, oggi a Claremont) al fratello Giuliano, per poi, alla morte di quest'ultimo nel 1654, confluire anche queste in quelle di Andrea.
Il principe intanto spostava le opere tra le residenze di proprietà: oltre a quelle a Bassano Romano, questi diede più dignità anche alla villa di San Giovanni in Laterano, dove vi furono collocate molte tele (alla data di morte di Vincenzo era ivi catalogata un solo dipinto sovraporta riprendente una Veduta di Genova), tra cui l'Autoritratto di Gerrit van Honthorst (oggi non più rintracciato), alcune di Antonio Tempesta, otto tele di Anthoine van Os, il Ritorno del figliol prodigo di Giovanni Lanfranco (oggi al Prado di Madrid) e diverse tele già negli appartamenti del cardinale Orazio, tra ci anche l'Autoritratto di Régnier.La collezione rimase superstite dei suoi pezzi fino al Settecento, senza neanche che questa fosse interessata da immissioni particolarmente prestigiose, se non talune opere di natura prettamente sacra, ma senza neanche subire particolari perdite, grazie anche ad un rinnovo del vincolo testamentario di Vincenzo, stilato alla morte del principe Andrea Giustiniani, nel 1676. Andrea si fece seppellire anch'egli come i suoi predecessori nella cappella di San Vincenzo della chiesa di Santa Maria sopra Minerva; la sua attività si concentrò per lo più verso le proprietà immobiliari della famiglia, abbellendo e rimodernando sia i palazzi-ville romani, che quello di Bassano. Alla sua morte l'inventario registrava "solo" 491 tele, probabilmente la differenza con le 632 del 1638 si deve al fatto che talune di queste furono portate alla villa di Bassano e quindi non inventariate in questa circostanza.
Alessandro Algardi, Busto di Innocenzo X
La collezione, quindi pressoché identica a quella inventariata nel 1638 alla morte di Vincenzo, venne affidata al figlio Carlo Benedetto Giustiniani, II principe di Bassano. Questi tuttavia morì prematuramente nel 1679, all'età di 30 anni, chiedendo di farsi seppellire a differenza di tutti i suoi predecessori, e come invece faranno i suoi successori, nella chiesa di San Vincenzo di Bassano, seppur nel 1723 le sue spoglie con anche quelle della moglie (Caterina Gonzaga) furono poi traslate nella chiesa della Minerva di Roma.
Successe nella tenuta della collezione dapprima la madre di Carlo Benedetto, quindi Maria Pamphilj, poi la moglie del principe, Caterina Gonzaga, dunque il figlio, il III principe di Bassano, Vincenzo, che acquisita la maggiore età, ereditò tutta la collezione Giustiniani, composta alla data del 1684 da 580 dipinti (probabilmente negli inventari furono ripristinati quelli di Bassano Romano, dove compare per la prima volta anche il busto in terracotta di Innocenzo X Pamphilj, opera dell'Algardi, donato dal cardinale Nicolò Ludovisi probabilmente a Maria Pamphilj, oggi nel palazzo Venezia a Roma) più gli innumerevoli marmi di antichità.
La collezione Giustiniani nel Settecento
Nonostante il fidecommisso del marchese Vincenzo, rinnovato anche dal principe Andrea alla sua morte, già nel Settecento si avviarono le prime vendite di pezzi della collezione (talune comunque non vincolate dalla disposizione testamentaria del 1638): al 1717 risale un primo atto di vendita riguardante un gruppo di sculture antiche al cardinale Albani, tra cui il bronzo dell'Ercole; al 1720 risalgono altre vendite di interi blocchi della collezione, di cui un grosso numero di sculture antiche era stato venduto a Thomas Herbert, VIII conte di Pembroke; intorno al 1750 un altro gruppo di opere fu ceduto invece a Lyde Browne per la sua casa di Wimbledon.
Nel 1754 Vincenzo Giustiniani, III principe di Bassano muore senza lasciare testamento; succede nelle eredità della raccolta Giustiniani il figlio di lui e Costanza Boncompagni Ludovisi, Gerolamo Vincenzo, che si impegnò a rispettare il vincolo fidecommissario del 1638 e che aggiunse a quello un altro istituito per i beni mobili e immobili aggiunti tra le proprietà della famiglia nel corso degli anni. Venuto a mancare già nel 1757, successe al principe il figlio di questi e Maria Ruspoli, Benedetto Giustiniani.
Sul finire del secolo si avviarono le fasi che porteranno, durante l'epoca napoleonica, allo smembramento totale del catalogo, allorché l'istituto giuridico del fidecommisso venne abolito per decreto. L'inventario del 1793, stilato alla morte del principe Benedetto Giustiniani, registra 822 pezzi, con l'aggiunta rispetto al passato di una biblioteca adorna di libri del XVIII secolo, principalmente di matrice francese. Questo inventario sarà di fatto l'ultima testimonianza della collezione riunita sotto al casato, dimostrando nel contempo che questa era comunque cresciuta rispetto all'inventario seicentesco, grazie soprattutto a diversi lasciti, dando anche prova del fatto che il vincolo fidecommissario sia risultato poi effettivamente utile nella salvaguardia dell'integrità della raccolta, seppur la perdita di qualche pezzo sia poi avvenuto già nel XVIII secolo. La collezione, con anche le proprietà della famiglia, furono ereditate dal figlio di Benedetto, Vincenzo junior Giustiniani.
Nel 1797, per fronteggiare ai debiti accumulati dalla famiglia, furono venduti gioielli al Monte di Pietà per 8.819 scudi, i quali già dal 1638 restavano estranei da qualsiasi vincolo fidecommissario.
La collezione Giustiniani nell'Ottocento
La crisi finanziaria che colpì le famiglie romane nel corso dell'Ottocento, a seguito delle restrizioni napoleoniche, non esentò quella Giustiniani di cadere nella medesima sofferenza economica di cui furono investite tutte le altre (dai Borghese, ai Pamphilj). Per questi motivi i tre fratelli, il principe Vincenzo junior, Lorenzo e il cardinale Giacomo, per far fronte ai debiti insorti, furono obbligati anche loro a procedere in questo senso, e quindi a dismettere le raccolte pittoriche e scultoree collezionate fino a quel momento.
Agli inizi dell'Ottocento furono cedute alcune proprietà immobiliari, come la villa su piazza San Giovanni in Laterano più altri fabbricati contigui che furono dati (per 75.000 scudi) alla famiglia Massimo, il palazzo a San Salvatore alle Coppelle (già di Giorgio Giustiniani, poi ereditato da Andrea e venduto per 4.000 scudi), le case al Pozzo delle Cornacchie e infine la casina Giustiniani di porta del Popolo (venduta ai marchesi Del Drago per 2.592 scudi).
Nel 1802 vi fu un altro inventario ancora, stilato per ottemperare al chirografo di Pio VII che chiese alle famiglie romane di presentare una lista dei loro beni, con lo scopo di frenare l'esportazione delle opere d'arte. L'elenco Giustiniani questa volta riportava 685 dipinti, circa 150 pezzi in meno rispetto ad appena dieci anni prima circa, a testimonianza del fatto che ebbe inizio l'attività di dismissione delle opere della collezione Giustiniani.
Ferdinando di Borbone, assieme al suo emissario per le arti Domenico Venuti, tentò nei primi anni del secolo di acquistare la collezione pittorica; tuttavia a causa di un mancato accordo sulle modalità di pagamento, che vedeva il re di Napoli assolvere al debito mediante una parte in contanti e un'altra con concessione di fondi terrieri, la trattativa non andò in porto. Successivamente a questi fatti, la collezione fu portata a Parigi e le opere che la compongono messe tutte all'asta; in questa occasione il principe Vincenzo portò le avances verso Lucien Bonaparte (che acquistò 6 dipinti, tra cui la Strage degli innocenti di Nicolas Poussin, 3 sculture oltre ad alcune proprietà alle porte di Roma) e gli inglesi William Buchanan e James Irvine, i quali acquisirono 158 opere.
La cessione in blocco alle dinastie Germaniche
Se le scelte degli acquirenti stranieri del Settecento vertevano tutte verso pitture del Cinquecento, in quanto non era ancora entrata in voga quella barocca, in particolare quella di Caravaggio, già ai primi dell'Ottocento questa tendenza risulterà totalmente invertita. Tra le prime grandi pitture a lasciare la collezione vi fu infatti il Suonatore di liuto (oggi all'Ermitage di San Pietroburgo) del Merisi, acquistato nel 1808.
Nel 1810 ancora un altro dipinto di Michelangelo lasciò la collezione, toccò questa volta all'Incoronazione di spine, che fu acquistato da Ludwing von Lebzeltern, ambasciatore imperiale per la corona austriaca presso la Santa Sede, nonché consulente per gli acquisti di opere artistiche; nel 1811 il granduca Federico IV di Sassonia-Gotha acquista invece dodici dipinti della collezione, in parte confluiti nello Schloss Friedenstein di Gotha.
Tra il 1812 e il 1815 avvennero altre cessioni in favore del re di Prussia Federico Guglielmo III, che acquistò più di 155 dipinti della collezione, i cui pezzi più importanti andranno poi a riempire i musei del palazzo di Sanssouci di Potsdam e della Gemäldegalerie di Berlino (dove restano custoditi in quest'ultimo edificio 43 quadri provenienti dal catalogo Giustiniani). Tra questi vi erano opere di Luca Cambiaso (La Castità), di Annibale Carracci (Paesaggio fluviale con castello e ponte), di Ludovico Mazzolino (Disputa di Cristo nel tempio), di Caravaggio (San Matteo e l'angelo, Cristo nell'orto, Ritratto di Fillide, Amor vincit omnia, Incredulità di san Tommaso), di Tiziano (la Natività), di Jusepe de Ribera, di Ludovico Carracci (Madonna col Bambino e agnello), della scuola di Francesco Francia (Allegoria della Castità, poi passata al Museo Galdiano di Madrid).
Lo smembramento della collezione di antichità
Tra le cessioni di opere antiche più rilevanti avvenute nei primi anni dell'Ottocento vi furono quelle verso Antonio Canova, che acquistò molti reperti, tra cui 6 vasi marmorei, 86 cippi (già nella casina del Popolo e poi ricollocati alla villa di San Giovanni) e 2 sarcofagi romani, tutti successivamente donati dallo scultore ai Musei Vaticani, mentre ancora altri pezzi sono oggi nei musei di Dresda.
Nel 1819 avvenne la cessione a titolo di garanzia di un debito che la famiglia Giustiniani aveva nei confronti dei Torlonia, pari a circa 33.600 scudi. Furono circa 267 le opere di antichità trasferite a Giovanni Torlonia, che però per vicissitudini burocratiche saranno consegnate ad Alessandro Torlonia solo intorno al 1856. Gran parte dei pezzi di antichità confluirono nelle raccolte della famiglia franco-romana, tra cui alcuni dei più rilevanti del catalogo delle antichità, come la Minerva Giustiniani, l'Hestia Giustiniani, l'Apollo con la pelle di Marsia, il busto del Satiro ebbro, quello di Eutidemo di Battriana e altri ancora. Dei pezzi già Giustiniani finiti nella collezione Torlonia, oggi ne rimangono supersiti 175.
Nel 1826 il principe Vincenzo junior morì, quindi iniziò la contesa giudiziaria tra i fratelli del defunto, Lorenzo e il cardinale Giacomo, e tre fratelli di Genova, Lorenzo, Gaspare e Leonardo Benedetto Giustiniani, che rivendicarono la titolarità della raccolta in quanto, seppur "lontani" di parentela con il marchese Vincenzo, appartenevano comunque al suo medesimo ramo, quello del Negro (mentre dal 1638, con la successione del principe Andrea Giustiniani, il ramo familiare titolare della collezione divenne quello de Banca). La battaglia la vinse la dinastia di Genova, pertanto prima Leonardo Benedetto e poi, nel 1857, alla morte di questi, il parente più prossimo nel lato materno, Pantaleo Vincenzo Giustiniani Recanelli, ereditarono la collezione. Quest'ultimo esponente, assieme al figlio Alessandro, una volta entrato in possesso della collezione inventariò ciò che restava della stessa (sia pitture che sculture) con una stima economica dei pezzi che la componevano, così da avere una quantificazione di ciò che potevano incassare da una loro eventuale cessione.
Nel 1854 avvenne la vendita del dominio di Bassano Romano agli Odescalchi, quindi sia la villa Giustiniani che la chiesa di San Vincenzo Martire che altri edifici di culto; la serie di dodici busti di imperatori romani disposti nel palazzo furono successivamente ricollocati nel castello di Bracciano, dove sono tuttora. Con questo trasferimento, si completò sostanzialmente lo smembramento della collezione Giustiniani e delle proprietà di famiglia.
La collezione Giustiniani nel Novecento
Già frazionata del tutto la collezione, alcuni pezzi hanno trovato destini diversi da quelli originariamente prefigurati: Il San Girolamo in meditazione del Caravaggio fu ad esempio acquistato con attribuzione a Ribera dal monastero di Montserrat nel 1915, poi restituito al Merisi da Roberto Longhi solo nel 1943. Altre opere già nei musei di Berlino, come il San Matteo e l'angelo, il Cristo nell'orto e il Ritratto di Fillide dello stesso pittore lombardo, o come la Morte di Seneca di Sandrart, invece, si perderanno assieme a numerose altre opere nell'incendio del deposito di Friedrichshain del 1945, durante la seconda guerra mondiale.
Nel 1979 alcuni ritratti di famiglia del XVIII e XIX secolo confluiti agli eredi Giustiniani, furono donati da Maria Sofia Giustiniani Bandini al Museo di Roma di palazzo Braschi.
LE INCISIONI DALLA GALLERIA GIUSTINIANI DI CHARLES PAUL LONDON
CATALOGUE FIGURE Des Tableaux de cette célèbre Galerie, transportée d'Italie en France; accompagné d'Observations critiques et historiques, et de soixante - douze Planches gravées au trait , contenant environ
cent cinquante sujets; Rédigé par C. P. LANDON , Peintre , ancien pensionnaire de l'Académie de France à Rome
Mentre la pubblicazione della raccolta delle incisioni tratte dai marmi antichi di proprietà Giustiniani, produsse larga risonanza in tutta Europa come testimonia l’apprezzamento di Rubens, venendo a costituire uno tra i primi cataloghi
grafici organici che, ancora oggi, costituisce una fonte sostanziale circa il Museo non più accorpato delle antiche sculture. Nelle riproduzioni della Galleria cartacea non figura la quadreria della collezione, ma la presenza di otto tavole con riproduzioni dei dipinti trovate nelle
edizioni settecentesche, lascia facilmente ipotizzare il progetto di altri volumi purtroppo mai realizzato a causa della dispersione del patrimonio originario.
Nel 1812 la pubblicazione curata dal pittore, editore e raffinato conoscitore d’arte, Charles Paul Landon, contenente 155 incisioni di traduzione dai dipinti della collezione Giustiniani, offre un dato sensibile riguardo all’alienazione di parte dei beni della famiglia genovese avvenuta a Parigi.
Questa selezione di incisioni intitolata "Galerie Giustiniani, ou catalogue figuré des Tableaux de cette
célèbre Galerie, transportée d’Italie en France" rappresenta un vero e proprio
catalogo di vendita; inoltre, come riportato nella sezione introduttiva del testo,
le opere al tempo della stampa erano già state comprate in blocco. L’acquisto
fu probabilmente condotto dal pittore e mercante d’arte Féreol Bonnemaison
per conto di un ricco acquirente straniero – per il quale fu stampato il catalogo illustrato – e da questi successivamente venduto al re di Prussia Federico
Guglielmo III. Costui, intenzionato a impreziosire la scarna collezione reale
d’arte e i musei di Berlino, non comparabili con la maestosità e ricchezza del
Musée Napoleon, acquisì nel 1815 l’intero blocco dei dipinti Giustiniani presenti nella capitale francese.
Il catalogo prospettato da Landon diviene per tale motivo parte imprescindibile di questa vicenda artistica e testimonianza di una congiuntura storica
ove la conoscenza e la diffusione delle opere italiane è alla base della realizzazione dei Musei europei.
Come chiarisce Landon nel suo Avertissement iniziale, l’opera ha valore essendo la prima trasposizione figurata su carta dell’insieme dei dipinti Giustiniani, antica e prestigiosa collezione meritevole, agli occhi del critico francese,
di essere conosciuta in tutta Europa.
tratto da: Caravaggio: le incisioni dalla Galerie Giustiniani
di Charles Paul Landon di Stefania Macioce, Michela Gianfranceschi in "dal Razionalismo al Rinascimento per i quaranta anni di studi di Silvia Danesi Squarzina" - Campisano Editori (2011)
L'elenco parziale delle opere:
La collezione archeologica
- Afrodite accovacciata (tipo Doidalsas), I secolo d.C., marmo,
collezione Torlonia,
Roma
- Apollo con la spoglia di Marsia, I secolo d.C., marmo pentelico,
bianco,
collezione Torlonia,
Roma
-
Atena Giustiniani, età antonina, V-IV secolo a.C., marmo,
Musei Vaticani,
Città del Vaticano
- Bacco, marmo, h 160 cm con la base,
collezione Torlonia,
Roma
- Busto di Plautilla, III secolo d.C., marmo lunense,
collezione Torlonia,
Roma
- Dionisio seduto su pantera, II secolo d.C., marmo,
Metropolitan Museum of Art,
New York
- Ercole Giustiniani, età flavia, 68–98 d.C., marmo,
Metropolitan Museum of Art,
New York
- Ercole, bronzo, h 64,5 cm con la base,
collezione Torlonia (villa
Albani), Roma
- Fauno Giustiniani (×2), I secolo d.C., marmo bianco,
collezione Torlonia,
Roma
- Gruppo di Afrodite ed Eros con mostro marino, II secolo d.C.,
marmo bianco,
collezione Torlonia,
Roma
- Gruppo di due coniugi, II secolo d.C., marmo lunense con
integrazioni in bardiglio,
collezione Torlonia,
Roma
-
Hestia Giustiniani, 120–140 d.C. ca., marmo pario,
collezione Torlonia,
Roma
- Marsia scorticato, I secolo d.C., marmo,
collezione Torlonia,
Roma
- Medusa tipo Rondanini, su trapezoforo a testa di grifo, II secolo
d.C., marmo bianco,
collezione Torlonia,
Roma
- Medusa tipo Rondanini su trapezoforo a testa di leone, XVII
secolo, marmo bianco,
collezione Torlonia,
Roma
- Musa seduta, marmo,
Metropolitan Museum of Art,
New York
- Poeta tragico con testa Euripide,
Museo Chiaramonti,
Città del Vaticano
- Pseudo-Corbulo, I secolo d.C., marmo,
Centrale Montemartini,
Roma
- Fanciullo con l’oca, II secolo d.C., marmo greco, grigiastro e
bianco,
collezione Torlonia,
Roma
- Rilievo con cavaliere, ambiente fidiaco, marmo di tespire, 70×58
cm,
Musei Vaticani,
Città del Vaticano
- Rilievo con scena di bottega, II secolo d.C., marmo proconnesio,
collezione Torlonia,
Roma
- Rilievo funebre con cavaliere romano, 170 d.C., marmo,
Altes Museum,
Berlino
- Ritratto colossale di Claudio, I secolo d.C., marmo greco e
italico,
collezione Torlonia,
Roma
- Ritratto di Antonino Pio, 138–161 d.C. ca., marmo pentelico e
marmo lunense,
collezione Torlonia,
Roma
- Ritratto di Antonino Pio, 150–160 d.C., marmo bianco,
collezione Torlonia,
Roma
- Ritratto di Augusto, I secolo d.C., marmo pentelico e lunense,
collezione Torlonia,
Roma
- Ritratto di Flavia Domitilla (detta Messalinafine), del I secolo
d.C., marmo bianco,
collezione Torlonia,
Roma
- Ritratto di giovane principe (detto Romolo Augustolo), 140–150
d.C. ca., marmo greco,
collezione Torlonia,
Roma
- Ritratto di Severo Alessandro, 220–230 d.C., marmo bianco,
collezione Torlonia,
Roma
- Ritratto di Traiano, II secolo d.C., marmo lunense,
collezione Torlonia,
Roma
- Ritratto femminile (detto Giulia di Tito), I secolo d.C. marmo
bianco,
collezione Torlonia,
Roma
- Ritratto maschile su busto antico(detto Cesare), I secolo a.C.,
marmo bianco,
collezione Torlonia,
Roma
- Ritratto maschile, detto Eutidemo di Battriana, III-II secolo
a.C., marmo,
collezione Torlonia,
Roma
- Satiro ebbro (tipo Ercolano), I secolo d.C., marmo docimium,
collezione Torlonia,
Roma
- Statua di Afrodite accovacciata, replica del tipo Doidalsas, I
secolo d.C., marmo greco,
collezione Torlonia,
Roma
- Statua di Afrodite accovacciata, replica del tipo Doidalsas, I
secolo d.C., marmo bianco,
collezione Torlonia,
Roma (con
testa moderna attribuita a
Pietro Bernini)
- Statua di Atena (tipo Giustiniani), 140–180 d.C., marmo greco
insulare e marmo italico,
collezione Torlonia,
Roma
- Statua di caprone, I secolo d.C., marmo bianco,
collezione Torlonia,
Roma (con
testa attribuita a
Gian Lorenzo Bernini)
- Statua di Ercole con pelle di leone e pomi delle Esperidi (pastiche),
marmo pentelico, marmo lunense e proconnesio,
collezione Torlonia,
Roma
- Statua di guerriero, età imperiale-II secolo d.C., marmo bianco,
collezione Torlonia,
Roma
- Statua di Iside Pelagia restaurata come Cerere, III secolo d.C.,
marmo bigio morato e marmo pentelico,
collezione Torlonia,
Roma
- Statua di Iside restaurata come Cerere, III secolo d.C., marmo
bigio morato e marmo bianco,
collezione Torlonia,
Roma
- Statua di Meleagro, I secolo d.C. corpo, età imperiale torso,
marmo microasiatico, marmo di Thasos, marmo bianco,
collezione Torlonia,
Roma
- Statua di Satiro in riposo, 110 d.C., marmo bianco,
collezione Torlonia,
Roma
- Statua di Satiro in riposo, 150 d.C., marmo pentelico,
collezione Torlonia,
Roma
- Statua di Sileno tipo Cesi, I secolo d.C., marmo greco e lunense,
collezione Torlonia,
Roma
- Statua Giustiniano, I secolo d.C., marmo,
villa Giustiniani Massimo,
Roma
- Statuetta di Artemide Efesia, II secolo d.C.,
collezione Torlonia,
Roma
- Torso antico di statuetta restaurato come Marsia scuoiato, I–II
secolo d.C., marmo bianco,
collezione Torlonia,
Roma
Scultura
-
Alessandro Algardi, Busto di Innocenzo X, terracotta dipinta di
bianco, h 22,5 cm,
Museo nazionale di palazzo Venezia,
Roma
- Busto-ritratto moderno detto di Scipione, 1610 ca., basanite e
porfido,
collezione Torlonia,
Roma
-
François Duquesnoy, Mercurio,bronzo, non rintracciata
- Ignoto, Ganimede è l'aquila, inizi XVII secolo, marmo, h 50 cm,
Musei Vaticani, Città del Vaticano
- Ignoti, Busti di imperatori romani (×12), XVII secolo, marmo
bianco e peperino,
castello Odescalchi,
Bracciano
-
Michelangelo,
Cristo portacroce (I versione), 1514-1516 circa, marmo, h 250 cm,
Monastero di San Vincenzo,
Bassano Romano
- Ritratto moderno di Lucio Vero, 1610 ca., marmo nero antico e
alabastro,
collezione Torlonia,
Roma
- Ritratto moderno di Marco Aurelio Cesare, 1610 ca., marmo nero
antico e portasanta,
collezione Torlonia,
Roma
- Ritratto moderno di Tiberio, 1610 ca., basanite e serpentino,
collezione Torlonia,
Roma
- Ritratto moderno di Vitellio, 1610 ca., marmo lunense,
collezione Torlonia,
Roma
Pittura
-
Francesco Albani, Apostolo (×12), 1609-1610, olio su tela, 136×98
cm,
Saint Moritzkirche,
Naumburg
-
Francesco Albani, Cristo e la samaritana, olio su tela, 261×178
cm,
Kunsthistorisches Museum,
Vienna
-
Francesco Albani, Gesù, 1609-1610, olio su tela, 136×95 cm,
Moritzkirche,
Naumburg
-
Francesco Albani, Maria, 1609-1610, olio su tela, 136×95 cm,
Moritzkirche,
Naumburg
-
Francesco Albani, San Giovanni Evangelista, 1609-1610, olio su
tela, 136×95 cm,
Moritzkirche,
Naumburg
-
Francesco Albani (?), Sant'Agnese, olio su tela, 77×60,5 cm,
Neues Palais,
Potsdam
-
Alessandro Allori (attribuito), Maddalena dinanzi al sepolcro,
Schloss Hirschgangflugel,
Bad Homburg vor der Höhe
-
Giovanni Baglione, Amor sacro e amor profano (versione scoperta),
1602, olio su tela, 240×143 cm,
Galleria nazionale d'arte antica di palazzo Barberini,
Roma
-
Giovanni Baglione, Amor sacro e amor profano (versione vestita),
1602, olio su tela, 183,4×121,4 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Giovanni Baglione, Madonna col Bambino e san Giuseppe, venduto
tra il 1816 e il 1824 (ubicazione ignota)
-
Dirck van Baburen, Lavanda dei piedi, 1614-1624, olio su tela,
199×297 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
- Backereel (ignoto quale sia il nome), Paesaggio con l'angelo e Tobia,
XVII secolo, nel 1662 alla villa di San Giovanni in Laterano (non più
rintracciato)
- Backereel (ignoto quale sia il nome), Paesaggio con cacciatore e lago,
XVII secolo, nel 1662 alla villa di San Giovanni in Laterano (non più
rintracciato)
-
Jacopo o
Francesco Bassano, Paesaggio con animali e umani, già a
palazzo Giustiniani,
Roma (disperso
dal 1859)
-
Jacopo o
Francesco Bassano, Paesaggio con animali e umani, già a
palazzo Giustiniani,
Roma (disperso
dal 1859)
-
Jacopo o
Francesco Bassano, Paesaggio con animali e umani, già a
palazzo Giustiniani,
Roma (disperso
dal 1859)
-
Giovanni Francesco Bezzi, Annunziata, olio su tavola, 107,3×79
cm,
The Art Museum,
Princeton
-
Trophime Bigot, Sacra Famiglia, olio su tela, 123×172 cm, già
Herzoglichen Gemäldegalerie,
Gotha
(disperso dal 1945)
-
Pietro Paolo Bonzi, Giovane con un melone in mano, olio su tela,
74×61 cm, già
Kaiser Friedrich Museum,
Berlino
(disperso)
-
Orazio Borgianni, Ritratto della madre del pittore, olio su tela,
65×45 cm, dispersa
-
Valentin de Boulogne, Sacra Famiglia con San Giovannino, 1626
ca., olio su tela, 140×186 cm,
Galleria Spada,
Roma
-
Bramantino (copia da), Deposizione, olio su tela, 150×102,4 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Jan Brueghel il Vecchio, Adorazione dei magi, olio su rame,
disperso già dal 1638
-
Jan Brueghel il Vecchio, Incendio di Troia, olio su rame,
disperso già dal 1638
-
Jan Brueghel il Vecchio, Paradiso, olio su rame, disperso già dal
1638
-
Jan Brueghel il Vecchio, Inferno, olio su rame, disperso già dal
1638
-
Luca Cambiaso, La Carità, 1570 ca., olio su tela, 141×109,5 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Luca Cambiaso, Cristo dinanzi a Caifa, 1570, olio su tela,
188×138 cm,
Accademia Linguistica di Belle Arti,
Genova (in
deposito da
palazzo Bianco)
-
Dionisio Calvaert (?), Battesimo di Cristo, olio su tela, 160×122
cm,
Museo Lazaro Galdiano,
Madrid
-
Caravaggio,
Suonatore di liuto, 1595-1596, olio su tela, 94×119 cm,
Museo dell'Ermitage,
San Pietroburgo
-
Caravaggio,
San Girolamo in meditazione, 1605 circa, olio su tela, 118×81 cm,
Monastero di Santa Maria,
Montserrat
-
Caravaggio,
Incoronazione di spine,1603, olio su tela, 127×165 cm,
Kunsthistorisches Museum,
Vienna
-
Caravaggio,
San Matteo e l'angelo (I versione), 1602, olio su tela, già
Kaiser Friedrich Museum,
Berlino
(distrutto nel 1945)
-
Caravaggio,
Cristo nell'orto, 1604-1606 circa, olio su tela, 154×222 cm, già
Kaiser Friedrich Museum,
Berlino
(distrutto nel 1945)
-
Caravaggio,
Ritratto di Fillide, 1597 circa, olio su tela, 66×53 cm, già
Kaiser Friedrich Museum,
Berlino
(distrutto nel 1945)
-
Caravaggio,
Amor vincit omnia, 1602-1603, olio su tela, 156×113 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Caravaggio,
Incredulità di san Tommaso, 1600-1601, olio su tela, 107×146 cm,
Bildergalerie del
castello Sanssouci,
Potsdam
-
Caravaggio, Ritratto del cardinale Benedetto Giustiniani, non
rintracciato
-
Caravaggio, Ritratto di cortigiana, non rintracciato
-
Caravaggio, Sant'Agostino, non rintracciato
-
Caravaggio, Maria Maddalena, non rintracciato
-
Caravaggio ?, Ritratto di donna (Marsilia Sicca?), non
rintracciato
-
Caravaggio ?, Ritratto d'uomo (avvocato Prospero Farinacci?), non
rintracciato
-
Carillo, Madonna col Bambino, XV secolo, olio su tavola, 37×27
cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Angelo Caroselli, Preghiera del figliol prodigo, olio su tela,
176×208 cm,
palazzo Spada (proprietà del
Consiglio di Stato),
Roma
-
Angelo Caroselli, Galatea e Pigmalione, olio su tela, 97×134 cm,
già al
Neues Palais,
Potsdam
opera dispersa)
-
Annibale Carracci, Paesaggio fluviale con castello e ponte, olio
su tela, 73×143 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Annibale Carracci, Crocifissione con la Madonna, due Marie e san
Giovanni, 1594, olio su tela, 33,8×23,4 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Annibale Carracci, Cristo con la canna, 1596 circa, olio su tela,
51x41 cm, già nella
Gemäldegalerie,
Berlino
(non più rintracciato dal 1844)
-
Annibale Carracci (copia da?), Madonna delle Ciliegie, olio su
tela, 100×80 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Annibale Carracci (copia da), Venere che abbraccia Amore, olio su
tela, 63×47 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Agostino Carracci, Madonna col Bambino e i santi Giovanni e
Elisabetta, 85,4×62,8 cm, già al
Neues Palais,
Potsdam
(requisito dalle truppe sovietiche nel 1946, da allora non più rintracciato)
-
Agostino Carracci, Tributo della moneta, olio su tela, 109×140
cm,
Bomann-Museum,
Celle
-
Ludovico Carracci, Cristo con gli strumenti della passione,
1606-1607, olio su rame, 18×14,5 cm, collezione privata,
Roma
-
Ludovico Carracci, Madonna col Bambino e agnello, olio su tela,
39×29 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Ludovico Carracci, Madonna col Bambino e santi, 1607, olio su
rame, 29,1×23,1 cm, collezione privata,
Woodbridge,
New
Jersey
-
Bernardo Castello, Natività, 1602, olio su tela, 97,7×71,7 cm,
Walters Art Gallery,
Baltimora
-
Cavalier d'Arpino, Testa di Cristo, olio su tela, 43,4×34,7 cm,
Neues Palais,
Potsdam
-
Cecco del Caravaggio, Cacciata dei mercanti dal tempio, olio su
tela, 129,5×174 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Gian Domenico Cerrini, Sacra Famiglia con santa Elisabetta e san
Giovannino, olio su tela, 131×165 cm,
Bildergalerie del
castello Sanssouci,
Potsdam
-
Cigoli (o il
Passignano ?), San Francesco in orazione, olio su tela, 155×120
cm,
Galleria nazionale d'arte antica di palazzo Barberini,
Roma
-
Cigoli (o
Orazio Samacchini ?), Battesimo di Cristo, olio su tela, 160×122
cm,
Museo Lazaro Galdiano,
Madrid
-
Cigoli, Sogno di Giacobbe, olio su tela, 151×129 cm, collezione
Burghley House,
Stamford
-
François Clouet (scuola di), Ritratto di Enrico II, olio su
tavola, 44×34,7 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Correggio (scuola di?), Cristo, olio su tavola, 31,4×26 cm, già
Neues Palais,
Potsdam
(requisito dalle truppe sovietiche nel 1946, da allora non più rintracciato)
-
Correggio (scuola di?), Madonna col Bambino, olio su tavola,
75,6×60 cm, già nel
castello di Berlino (disperso dal 1829)
-
Timan Arentsz Cracht, San Vincenzo incoronato da un angelo,
tempera su tela, 221×118 cm, chiesa di San Vincenzo Martire,
Bassano Romano
-
Juan Pantoja de la Cruz, Ritratto di Filippo III in abiti del gran
maestro del Toson d'Oro,
Musée
Goya d'Art Hispamnique,
Castres (in prestito dal
Louvre di
Parigi)
-
David de Haen, Deposizione, olio su tela, 280×211 cm, già
Kaiser Friedrich,
Berlino
(opera perduta)
-
Domenichino, San Giovanni Evangelista, 1624-1629, olio su tela,
259×199 cm,
National Gallery,
Londra (in
prestito dalla collezione John Christie Trust,
Glyndebourne)
-
Giovanni Andrea Donducci ?, Didone e Anna, olio su tela incollata
su tavola, 31×23 cm,
Neues Palais,
Potsdam
-
Giovanni Andrea Donducci, Maddalena nel deserto, olio su tavola,
62×40 cm, collezione privata,
Bologna
-
Giovanni Andrea Donducci, Riposo durante la fuga in Egitto, olio
su tavola, 62×40 cm, collezione privata,
Bologna
-
Giovanni Andrea Donducci, Sansone e Dalila, olio su tavola,
203×170 cm, collezione privata,
Bologna
-
Giovanni Andrea Donducci, Offerta di Abigail e David, olio su
tela, 203×170 cm, collezione privata,
Bologna
-
Dosso Dossi, Madonna col Bambino e i santi Giuseppe e Francesco,
1520 ca., olio su tavola, 63×48 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Dosso Dossi (copia da?), San Girolamo scrivente, olio su tavola,
62,5×52,5 cm,
Neues Palais,
Potsdam
-
Dosso Dossi (o Battista) (?), Ritratto del Petrarca, olio su
tavola, 30×26 cm, già nel
castello di Berlino (disperso dal 1926)
-
Battista Dossi, Venere e amorini, olio su tavola, 65×47 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Evert van Aelst (?), Natura morta con pernici, anatra e zigolo giallo,
olio su tela, 61,5×51,8 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Gaudenzio Ferrari da Varallo (copia da?), Autoritratto, olio su
tela, 67×52 cm,
Neues Palais,
Potsdam
-
Giusto Fiammingo, Morte di Socrate, olio su tela, 174×243 cm, già
Kaiser Friedrich,
Berlino
(opera perduta)
-
Giusto Fiammingo, Presa di Cristo con la fuga del giovane nudo,
olio su tela, 200×280 cm, collezione privata,
Roma
-
Domenico Fiasella, Cristo resuscita il figlio della vedova di Naim,
olio su tela, 269,2×175,2 cm,
Ringling Museum,
Sarasota
-
Domenico Fiasella, Cristo risana il cieco nato, olio su tela,
278,4×182,5 cm,
Ringling Museum,
Sarasota
-
Francesco Francia (scuola di), Allegoria della Castità,
Museo Lazaro Galdiano,
Madrid
-
Francesco Francia (scuola di), Allegoria della Castità, olio su
tavola, 79×58 cm,
Kaiser Friedrich,
Berlino
-
Francesco Francia (bottega di), Madonna col Bambino e san Giovannino,
olio su tavola, 73,2×56,2 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Francesco Francia, Madonna col Bambino e san Giovannino,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Francesco Francia (?), Madonna col Bambino, olio su tavola,
47×36,6 cm, già allo
Schloss,
Berlino (disperso dal 1854)
-
Francesco Francia, Madonna col Bambino e i santi Girolamo e Francesco,
olio su tavola, 76×59 cm, già nel
castello di Königsberg (disperso dal 1945)
-
Benvenuto Tisi da Garofalo (bottega di?), Annunziata, olio su
tavola, 32,5×26,5 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Benvenuto Tisi da Garofalo, Imperatore Augusto e la Sibilla Tiburtina,
1537, olio su tavola, 65,5×41,7 cm,
Wallraf-Richartz Museum,
Colonia
-
Artemisia Gentileschi, David con la testa di Golia, non
rintracciato
-
Ghirlandaio, Giuditta e Abra con la testa di Oloferne, 1489, olio
su tavola, 44,5×31,3 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Antiveduto Grammatica (?), David con la testa di Golia, nel 1662
alla villa di San Giovanni in Laterano (non più rintracciato)
-
Guercino, Madonna, Museo nazionale,
Magdeburgo
-
Guercino, Madonna col Bambino, olio su tela, 77×60 cm, già
Kaiser Friedrich,
Berlino
(opera perduta)
-
Gerrit van Honthorst,
Cristo davanti a Caifa, olio su tela, 272×183 cm,
National Gallery,
Londra
-
Gerrit van Honthorst, Liberazione di san Pietro, olio su tela,
131×181 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
- Ignoto, Madonna, mosaico, 77×67 cm,
Museo Puskin,
Mosca (frammento dall'antica basilica di San Pietro, Roma)
- Ignoto, San Giuseppe, mosaico, 77×67 cm,
Museo Puskin,
Mosca (frammento dall'antica basilica di San Pietro, Roma)
- Ignoto, Carlo III duca di Lorena, XVII secolo, olio su lavagna,
43,3×32,5 cm,
Neues Palais,
Potsdam
- Ignoto, Cristo Bambino, mosaico, 77×67 cm,
Museo Puskin,
Mosca (frammento dall'antica basilica di San Pietro, Roma)
- Ignoto, Ecce Homo, olio su tavola, 75,5×61,5 cm,
Neues Palais,
Potsdam
- Ignoto, Ratto di Ganimede, XVI secolo, olio su tela incollata su
tavola, 89×75 cm,
Neues Palais,
Potsdam
- Ignoto, Ritratto d'uomo con guanto, 1550, olio su tela, 71×63 cm,
Neues Palais,
Potsdam
- Ignoto, Ritratto della duchessa Maria Giustiniani sposa di Sforza
Sforza Cesarini, XVIII secolo, olio su tela, 99×74 cm,
Museo di Roma a palazzo Braschi,
Roma
- Ignoto, Ritratto del principe Benedetto Giustiniani, XVIII
secolo, olio su tela, 75×61 cm,
Museo di Roma a palazzo Braschi,
Roma
- Ignoto, Ritratto di Carlo Giustiniani con armatura, elmo e bandana
dell'Ordine Gerosolimitano, XVIII secolo, olio su tela, 99×73 cm,
Museo di Roma a palazzo Braschi,
Roma
- Ignoto, Ritratto di monsignor Andrea Giustiniani, XVIII secolo,
olio su tela, 100×73 cm,
Museo di Roma a palazzo Braschi,
Roma
- Ignoto, Ritratto del principe Vincenzo Giustiniani, XVIII secolo,
olio su tela, 101×76 cm,
Museo di Roma a palazzo Braschi,
Roma
- Ignoto, Ritratto del principe Vincenzo Giustiniani, XVIII secolo,
olio su tela, 99×73,5 cm,
Museo di Roma a palazzo Braschi,
Roma
- Ignoto, Ritratto del principe Vincenzo Giustiniani, XVIII secolo,
olio su tela, 100×74 cm,
Museo di Roma a palazzo Braschi,
Roma
- Ignoto, Ritratto di Carlo Giustiniani con armatura e medaglia
dell'Ordine Gerosolimitano, XVIII secolo, olio su tela, 98,5×74 cm,
Museo di Roma a palazzo Braschi,
Roma
- Ignoto, Ritratto di una dama Giustiniani con ventaglio, XVIII
secolo, olio su tela, 100×73 cm,
Museo di Roma a palazzo Braschi,
Roma
- Ignoto, Ritratto del principe Vincenzo Giustiniani, XVIII secolo,
olio su tela, 98×73 cm,
Museo di Roma a palazzo Braschi,
Roma
- Ignoto, Testa di bambino, XVI secolo, olio su tela incollata su
tavola, 21,5 cm diametro,
Bildergalerie del
castello Sanssouci,
Potsdam
- Ignoto, Vecchia con panno bianco in testa, XVII secolo, olio su
tela, 64×48,5 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
- Ignoto, Venere e amorino, XVI secolo, olio su tela, 93×73 cm,
Bomann-Museum,
Celle
-
Innocenzo da Imola, Madonna col Bambino e san Giuseppe, già
Neues Palais,
Potsdam
(requisito dalle truppe sovietiche nel 1946, da allora non più rintracciato)
-
Innocenzo da Imola, Madonna col Bambino e i santi Caterina, Giuseppe
e Giovannino, olio su tavola, 76×63 cm,
Museo dell'Ermitage,
San Pietroburgo
-
Giovanni Lanfranco, Ritorno del figliol prodigo, 1600-1647, olio
su tela, 112×147 cm,
Museo del Prado,
Madrid
-
Giovanni Lanfranco, Sant'Andrea, olio su tela, 193,6×141 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Giovanni Lanfranco, San Carlo Borromeo in preghiera davanti al
crocifisso, olio su tela, 180,4×117,6 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Bernardino Licinio, Ritratto d'uomo, olio su tela, 74,5×67 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Claude Lorrain, Paesaggio con Cefalo, Procri e Diana, olio su
tela, 142×178,7 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Lorenzo Lotto,
Ritratto di giovane, 1526, olio su tela, 47×38 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Lorenzo Lotto, Ritratto d'uomo con compasso e pergamena (Sebastiano
Serlio?), olio su tela, 105×82 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Lorenzo Lotto, Ritratto d'uomo con un uffiziolo in mano, olio su
tela, 50,7×43,8 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Lorenzo Lotto, San Vincenzo, (smarrito l'anno 1648)
-
Bartolomeo Manfredi, Apparizione di Cristo risorto alla Madonna,
olio su tela, 257×178 cm,
Museo civico Ala Ponzone,
Cremona
-
Girolamo Marchesi, Sposalizio della Vergine, 1522-1523, olio su
tavola, 78×60 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Girolamo Marchesi, Madonna col Bambino e san Giuseppe, olio su
tavola, 57,5×51,5 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Ludovico Mazzolino, Disputa di Cristo nel tempio, olio su tavola,
44×30 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Michelangelo (?), Cattura di Cristo, già
villa Giustiniani,
Bassano Romano (disperso dal 1812)
-
Nicolò Musso, Cristo porta la croce al Calvario, olio su tela,
265×177 cm,
Galleria Sabauda,
Torino
-
Nicolò Musso, Natività, olio su tela, 225×166 cm, collezione
Banco di Roma,
Roma
-
Luca d'Olanda (?) (copia da
Albrecht Durer), Cristo dinanzi a Pilato, olio su tavola, 79,1×55
cm,
Neues Palais,
Potsdam
-
Jacopo Palma il Vecchio, Riposo durante la fuga in Egitto, olio
su tavola, 61×51 cm,
Gemäldegalaerie,
Berlino
-
Jacopo Palma il Vecchio, Madonna col Bambino e i santi Pietro,
Girolamo e il committente, olio su tavola
trasportato su tela, 89×137 cm,
Musée Condé,
Chantilly
-
Jacopo Palma il Vecchio, Natività, olio su tavola,
Gemäldegalaerie,
Berlino
-
Marco Palmezzano, Cristo portacroce, 1503, olio su tavola,
60,5×49,5 cm,
Gemäldegalaerie,
Berlino
-
Parmigianino (?), Madonna col Bambino, olio su tavola, 116×89 cm,
già nella
Bildergalerie del
castello Sanssouci,
Potsdam
(non più rintracciato)
-
Parmigianino (copia da), Dettaglio dalla Madonna dal collo lungo,
olio su tavola, olio su tela, 64,5×52 cm,
Neues Palais,
Potsdam
-
Francois Perrier, Morte di Cicerone, olio su tela, 176×243 cm,
Schloss Hirschgangflugel,
Bad Homburg vor der Höhe
-
Perugino, Madonna col Bambino, non rintracciato
-
Perugino, Madonna col Bambino, olio su tavola, 43×35 cm, già
Neues Palais,
Potsdam
(dal 1945 non più rintracciato)
-
Baldassarre Peruzzi (?), Adorazione dei magi, olio su tavola,
66×49 cm, già
Neues Palais,
Potsdam
(requisito dalle truppe sovietiche nel 1946, da allora non più rintracciato)
- Il
Pordenone, Presa di Cristo, olio su tavola, 73×148 cm, Schloss
Friedenstein,
Gotha
-
Nicolas Poussin, Assunzione della Vergine, olio su tela, 134,5×98
cm,
National Gallery of Art,
Washington
-
Nicolas Poussin, Paesaggio con Giunone e Argo, olio su tela,
122,5×198,5 cm,
Gemäldegalaerie,
Berlino
-
Nicolas Poussin, Strage degli innocenti, olio su tela,
148,5×174,5 cm,
Musée Condé,
Chantilly
-
Scipione Pulzone, Ritratto di Pio V, olio su tavola, 62,8×47 cm,
opera dispersa (una copia di formato leggermente più piccolo è al
Museo Puskin di
Mosca)
-
Scipione Pulzone, Madonna col Bambino e san Giovannino, già nella
Bildergalerie del
castello Sanssouci,
Potsdam
(disperso dal 1926)
-
Raffaellino da Reggio (seguace di?), Maddalena al sepolcro di Cristo,
olio su tela, 163×134 cm,
Schloss Hirschgangflugel,
Bad Homburg vor der Höhe
-
Raffaello (copia da), Ritratto di Giulio II, olio su tela,
95,5×82,5 cm,
Gemäldegalaerie,
Berlino
-
Nicolas Regnier, Ritratto di Vincenzo Giustiniani, 1630 ca., olio
su tela, 131,5×95,3 cm, collezione privata,
Londra
-
Nicolas Regnier, Autoritratto con cappello ornato di pennacchiera,
olio su tela, 64,7×48,9 cm,
Pomona College Museum of Art,
Claremont
-
Nicolas Regnier, Omero cieco che suona il violino, olio su tela,
119×95 cm, mercato d'antiquario,
Parigi
-
Nicolas Regnier, Bacco, olio su tela, 128×103 cm, già nella
Bildergalerie del
castello Sanssouci,
Potsdam
(disperso)
-
Nicolas Regnier, Cena in Emmaus, olio su tela, 282×222 cm,
Bildergalerie del
castello Sanssouci,
Potsdam
-
Nicolas Regnier, San Giovanni Battista nel deserto, olio su tela,
254×192 cm, già in collezione privata,
Napoli
(non più rintracciato)
-
Guido Reni (?) (copia da
Innocenzo da Imola ?), San Giovanni Evangelista con l'aquila, in
origine 239×179 cm (poi mutilato nella parte inferiore),
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Guido Reni, Sant'Antonio e san Paolo, olio su tela, 290×187 cm,
già al
Kaiser Friedrich,
Berlino
(opera perduta)
-
Jusepe de Ribera, Cristo fra i dottori, 1613 ca. 188×267 cm,
chiesa di Saint Martin,
Langres
-
Jusepe de Ribera, Geografo sorridente (Democrito?), 1615-1616,
olio su tela, 120×90 cm, collezione privata,
Lugano
-
Jusepe de Ribera, Origene, olio su tela, 123,5×95,5 cm,
Galleria nazionale delle Marche,
Urbino
-
Jusepe de Ribera, Maddalena penitente, non rintracciata
-
Jusepe de Ribera, Ritratto d'uomo (Signismondo Laire?),
1613-1615, olio su tela, 76×63,5 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Jusepe de Ribera, San Francesco, olio su tela, 137×96,5 cm,
Bildergalerie del
castello Sanssouci,
Potsdam
-
Jusepe de Ribera, San Giacomo, olio su tela, 125×97 cm, già
Herzoglichen Gemäldegalerie,
Gotha
(perduto)
-
Jusepe de Ribera, San Gregorio Magno, 1614 circa, olio su tela,
102×73 cm,
Galleria nazionale d'arte antica di palazzo Barberini,
Roma
-
Jusepe de Ribera, San Pietro, già
Herzoglichen Gemäldegalerie,
Gotha
(perduto)
-
Giovan Francesco Romanelli (?), Madonna col Bambino e san Giuseppe al
tempio di Salomone, già alla
villa Giustiniani,
Bassano Romano (non più rintracciato)
-
Giovanni Battista Ruggieri, Natività, olio su tela, 134×89 cm,
collezione Odescalchi,
Roma
-
Giovanni Battista Ruggieri, Mosè davanti al Faraone, olio su
tela, 126×174 cm,
Neues Palais,
Potsdam
-
Francesco Salviati, Testa della Vergine, olio su tela, 31,5×26,5
cm,
Neues Palais,
Potsdam
-
Joachim von Sandrart, Morte di Seneca, già al
Kaiser Friedrich,
Berlino
(distrutto nel 1945)
-
Andrea del Sarto, Madonna col Bambino e san Giovannino, olio su
tavola, 109,5×86,5 cm, Museo di Belle Arti,
Perm
-
Andrea del Sarto (?), Madonna col Bambino e san Giovannino, olio
su tavola, 84,3×68, cm, già nel
castello di Berlino (dal 1945 non più rintracciato)
- Il
Sassoferrato, Vergine in preghiera, olio su tela, 86×56 cm,
Schloss Friedenstein,
Gotha
-
Bartolomeo Schedoni, San Giovanni Battista, olio su tavola,
31,4×23,4 cm, già nel
castello di Berlino (dal 1945 non più rintracciato)
-
Cornelis Schut, Strage degli innocenti, olio su tela, 310×217 cm,
chiesa della Santissima Trinità,
Caen
-
Cornelis Schut, Adorazione dei magi, olio su tela, 318×217 cm,
chiesa della Santissima Trinità,
Caen
-
Giampietro Silvio, Cristo e l'adultera, olio su tela, 102×144 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
- Il Sodoma
(?), Ecce Homo, (disperso dal 1945)
- Lo
Spadarino, Resurrezione di Cristo, già al
palazzo Giustiniani,
Roma (dal 1859
non più rintracciato)
-
Carel Philips Spierinck, Agar consolata dall'angelo, olio su
tela, 145,5×170 cm,
Neues Palais,
Potsdam
-
Herman van Swanevelt, Paesaggio con fiume del mito di Latona,
olio su tela, 130,3×199,5 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Herman van Swanevelt, Paesaggio con storie di Diana Castore e Polluce
che converte i contadini in ranocchie, olio su tela, 130,3×199,5 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Antonio Tempesta, Visione di sant'Eustachio, olio su tela,
205×270, già in
villa Giustiniani,
Bassano Romano (disperso)
-
Pietro Testa, Mosè fa scaturire l'acqua dalla roccia, olio su
tela, 132×169 cm,
Bildergalerie del
castello Sanssouci,
Potsdam
-
Pietro Testa, Labano cerca gli idoli, olio su tela, 135,5×178 cm,
Bildergalerie del
castello Sanssouci,
Potsdam
-
Pellegrino Tibaldi, Madonna col Bambino, san Giuseppe, santa
Elisabetta e san Giovannino, olio su tavola, 84×69,8 cm, già
Neues Palais,
Potsdam
(requisito dalle truppe sovietiche nel 1946, da allora non più rintracciato)
-
Tintoretto, Ritratto di procuratore veneziano, olio su tela,
105×83 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Tiziano, Natività,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Tiziano (copia da, già assegnato a
Giorgione), Sibilla, olio su tela, 94×83 cm,
Neues Palais,
Potsdam
-
Tiziano (scuola di?), Ecce Homo, olio su tavola, 75,5×61,5 cm,
Neues Palais,
Potsdam
-
Tiziano (maniera di?), Maddalena, olio su tela, 105×86 cm,
Bomann-Museum,
Celle
-
Tiziano (scuola di), Ritratto di Andrea Navagero, 1526, olio su
tela, 70×51,5 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Tiziano (scuola di?), Ritratto d'uomo (Andrea Palladio?), olio su
tela, 44×30 cm, già
Kaiser Friedrich,
Berlino
(opera perduta)
-
Tiziano (copia da), Venere allo specchio, olio su tela, 120×105
cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Alessandro Turchi, San Giuseppe e la moglie di Putifarre,
disperso dal 1642
-
Perin del Vaga (?), San Giovanni nel deserto, segnalato tra gli
acquisti
Odescalchi assieme a
villa Giustiniani di
Bassano Romano (disperso dal 1854)
-
Francesco Vecellio, Madonna in gloria col Bambino e san Giovannino,
olio su tela, 81,3×94 cm, collezione Lansdowne,
Calne
Wiltshire
-
Marcello Venusti, Pietà, olio su tavola, 48×60 cm, Schloss
Friedenstein,
Gotha
-
Claude-Joseph Vernet, Tempio della Sibilla a Tivoli, olio su
tela, 73×98 cm, già
Kaiser Friedrich,
Berlino
(opera perduta)
-
Giuseppe Vermiglio, Moltiplicazione dei pani e dei pesci, olio su
tela, 262×180 cm, già
Kaiser Friedrich,
Berlino
(opera perduta)
-
Paolo Veronese, Adamo ed Eva, (probabilmente) collezione privata,
Dresda
-
Paolo Veronese, Cristo morto con due angeli, 1587-1589, olio su
tela, 110×94 cm,
Gemäldegalerie,
Berlino
-
Claude Vignon, Nozze di Canna, olio su tela, 214×291 cm, già
Neues Palais,
Potsdam
(disperso)
-
Claude Vignon (?), Santa Caterina martire, olio su tela, 125×90
cm, già in
villa Giustiniani,
Bassano Romano (disperso)
-
Giovanni Battista Viola, Paesaggio con comitiva a caccia, olio su
tela, 96,6×135,3 cm,
National Gallery,
Londra
-
Giovanni Battista Viola, Paesaggio fluviale con barche, olio su
tela, 95,3×132,1 cm,
National Gallery,
Londra
-
Giovanni Battista Viola, Paesaggio con San Giovanni Battista che
impartisce il battesimo sul fiume Giordano, olio su tela, 112×156 cm,
Fitzwilliam Museum,
Cambridge
-
Giovanni Battista Viola, Paesaggio con San Giovanni Battista che
predica alla folla, olio su tela, 113×155,6 cm, collezione privata,
New York
-
Giovanni Battista Viola, Paesaggio con la fuga in Egitto, olio su
tela, 117×148,5 cm, collezione privata,
Isola di Bute
-
Simon Vouet, Annunciazione, olio su tela, 290×193 cm, già
Kaiser Friedrich,
Berlino
(opera perduta)
-
Federico Zuccari (?), Ritratto di uno dei figli di Federico Zuccari,
olio su tela incollata su tavola, 32×28 cm,
Neues Palais,
Potsdam
-
Taddeo Zuccari, Ritratto di donna di casa Colonna (Lucrezia Vannozzi?),
olio su tela, 120,2×102 cm,
Museo dell'Ermitage,
San Pietroburgo
L'antica collezione Giustiniani
Podcast audio de "Il Sole 24 ore" del 3 dicembre 2022
Alla scoperta delle meraviglie artistiche dell'antica collezione Giustiniani, tra sculture antiche, bassorilievi, molte opere di Caravaggio oggi disseminate per mezzo mondo.
Vite che non sono la tua: il marchese Vincenzo Giustiniani
Podcast audio de "Rai play sound" del 1 giugno 2019 (di Costantino D'Orazio)
LA COLLEZIONE GIUSTINIANI: IL PROGETTO DELLA MOSTRA
Caravaggio e i Giustiniani – toccar con mano una collezione del Seicento
Roma, Palazzo Giustiniani, 25 gennaio – 15 maggio 2001
In un luogo ristretto come piazza de’ Galli, quello era il nome del
breve spazio che tuttora divide palazzo Giustiniani dalla chiesa di S. Luigi dei Francesi,
si verificarono accadimenti che gli studi di storia dell’arte considerano epocali.
Le grandi tele di Caravaggio per la cappella Contarelli, la prima versione del S. Matteo
con l’angelo acquistata dal marchese Vincenzo Giustiniani per la sua collezione,
l’Amore vincitore e l’Incredulità di S. Tommaso appesi nella prima "stanza
dei quadri antichi" del palazzo della famiglia genovese, simbolici delle due anime,
una umanistica e l’altra religiosa, della collezione, suscitarono "rumori"
in tutta la città papale, ancora centro culturale dell’Europa.
Nell'arco di tempo fra il 1600 e il 1638 veniva accumulandosi la collezione Giustiniani.
Eccezionale per il suo carattere innovativo, imponente per la rilevanza quantitativa
(oltre seicento dipinti e più di milleottocento pezzi antichi), documentata da numerosi
inventari (in particolare quelli del 1600, 1621, 1638, 1793) essa ci mostra il rapporto
anticipatore e privilegiato che i due fratelli Giustiniani instaurarono con Caravaggio:
quindici sue opere risultano nell'inventario del 1638.
Una massa enorme di documenti ci consente di ricostruire la vita quotidiana della
famiglia, le sue relazioni sociali, il confronto dialettico con le idee del tempo.
Vivo è l'interesse che suscitano le due figure dei committenti e mecenati: il cardinale
Benedetto, immerso nel ruolo attivo che la parte migliore della Chiesa militante cercò di
avere verso i ceti diseredati, ma anche sensibile collezionista, vicino all'arte e agli
artisti, importante nesso con il mutare del linguaggio artistico.
Al suo fianco il marchese Vincenzo, il cui fascino intellettuale ci giunge intatto,
attraverso i suoi scritti sull'arte frutto di una esperienza quotidiana e concreta;
citazioni tratte dalle sue pagine fanno da filo conduttore dell'intera mostra, nei brevi
pannelli didattici.
Vincenzo Giustiniani dimostrò vaste competenze architettoniche, una puntigliosa
conoscenza della scultura - di materiali e tecniche -, nonché un raffinato gusto
nell’ideare giardini, fra calibrate geometrie del verde e suggestioni letterarie.
L’affascinante complessità di questo "incomparabile ingegno" traspare
appieno dagli acuti e brillanti "Discorsi" sull’architettura, la pittura e
la scultura (recentemente ripubblicati nelle edizioni Città del Silenzio con una
prefazione di Lauro Magnani). Essi denotano una grande conoscenza della pittura,
della scultura, della musica e delle costruzioni civili. (preliminari all'edizione critica del
Discorso sopra la musica de' suoi tempi di Vincenzo Giustiniani (1628)
a cura di
Gennaro Tallini).
Nel 2021 grazie al lavoro delle professoresse Silvia
Danesi Squarzina e Luisa Capoduro, sono stati portati alla luce altri "discorsi"
del del marchese Vincenzo non ancora conosciuti, pubblicati per la Tipografia della Biblioteca Apostolica Vaticana
SCRITTI EDITI E INEDITI.
I "Discorsi" di Vincenzo sono di fondamentale importanza, non soltanto per la
comprensione del suo gusto artistico ma anche per le molte informazioni che se
ne possono trarre.
Il punto di partenza della collezione è circa l'anno 1600: la collezione cresce nel tempo e subisce numerose
modificazioni. Alla data del 1638, la più rilevante per noi, i dipinti e le statue
avevano invaso ogni spazio disponibile del palazzo e delle altre dimore.
Nelle "tre stanze dei quadri antichi" poste al piano nobile sul fronte verso S.
Luigi dei Francesi erano conservate le opere dei pittori del passato, ma anche di
contemporanei come Caravaggio che riceverà dalla significativa collocazione una sorta di
consacrazione.
Specchio di questo impegno ed interesse per le arti, che in Vincenzo Giustiniani si
trasforma in colta passione (come documentano le sue lettere sulla pittura, scultura e
architettura ) è la collezione di dipinti e di sculture raccolta dai due fratelli tra la
fine del Cinquecento e il quarto decennio del seicento nel palazzo Giustiniani, nella
villa del Laterano, in quella a Porta del Popolo, nonché nel Palazzo di Bassano Romano,
già Bassano di Sutri. Grazie ai primi studi di Luigi Salerno (1960) e alle recenti e più
approfondite ricerche svolte dalla Prof. Silvia Danesi Squarzina (1994-2000) (Il progetto Giove sulla
Collezione Giustiniani di Silvia Danesi Squarzina) è oggi possibile ricostruire
nella sua interezza lo straordinario patrimonio artistico raccolto da Benedetto e Vincenzo
Giustiniani. Si tratta di una collezione unica nel suo genere e nel suo tempo, capace di
documentare un gusto per l'arte attento ai valori estetici dei diversi stili allora
correnti, portatrice di una visione "moderna" del fatto artistico e pertanto
testimone di un passaggio molto delicato della storia della ricezione dell'arte. La fama
di questa raccolta di capolavori fu tale da trasmettersi nello spazio e nel tempo grazie
alle testimonianze scritte dei viaggiatori che annotarono meticolosamente l'eccezionalità
dei suoi capolavori, ma anche grazie alle testimonianze figurative di artisti e di amatori
che non mancarono di eseguire copie e varianti delle opere ammirate nel Palazzo romano, o
semplicemente di schizzare sui loro taccuini disegni tratti dalle tele e dalle statue.
Il progetto della mostra "Caravaggio e i Giustiniani – toccar con mano una collezione del Seicento
Roma", Palazzo Giustiniani
La mostra ha consentito di riportare per la prima volta nella sua sede originaria, il
Palazzo Giustiniani di Roma, attuale sede della Presidenza del Senato, capolavori assoluti
della storia dell'arte come il celebre Amore Vittorioso di Caravaggio (Berlino,
Gemäldegalerie), tanto amato da Vincenzo Giustiniani da essere coperto con un drappo
verde affinché non offuscasse, con la sua bellezza incomparabile, gli altri dipinti della
raccolta, o come il Suonatore di Liuto di San Pietroburgo, così ammirato da indurre un
raffinato collezionista come il Cardinal del Monte a chiedere al Caravaggio di eseguirne
un'altra versione per il proprio palazzo. Tele importantissime del Caravaggismo olandese
sono state esposte a Roma per la prima volta: l'amatissimo Gherardo delle Notti (Gerrit
van Honthorst), uno dei pittori prediletti dai Giustiniani, sarà rappresentato da tre
opere di eccezionale interesse. Importanti dipinti del Rinascimento italiano giungeranno a
Roma dai Musei tedeschi, hanno consentito ai visitatori di ammirare opere dei principali
esponenti della pittura del Cinquecento, come Lorenzo Lotto, Dosso Dossi, Paolo Veronese.
L'esposizione ha consentito non soltanto di ammirare lo splendore di queste opere ignote
al pubblico italiano, ma anche di rivivere l'atmosfera della Collezione, frutto del gusto
e dell'erudizione più evoluti del Seicento italiano. Accanto ai dipinti, sono stati
esposti statue, incisioni, disegni, libri ed oggetti che aiutano a comprendere lo spirito
che animò la nascita e l'accrescimento della raccolta. In occasione dell'esposizione è
stata presentata, inoltre, una nuova scoperta scientifica di eccezionale importanza ha
costituito un elemento di forte attrazione per il pubblico e di grande interesse per la
stampa divulgativa e di settore. Si tratta delle prima versione del Cristo di Santa Maria
sopra Minerva eseguita da Michelangelo e rimasta incompiuto a causa di un difetto nel
marmo, una macchia sul viso emersa durante la esecuzione. I risultati della ricerca,
vagliata da un comitato di esperti di Michelangelo, sono pubblicati su The Burlington
Magazine, dicembre 2000.
Grazie ad un progetto di Renato Passacantando per la Rai è nato il progetto "mostre
impossibili",un ricco apparato didascalico: multivisioni, documentari, film,
audio-video guide personalizzate a raggi infrarossi, musiche attinenti ai dipinti, DVD,
cataloghi, libri scritti ad hoc, siti Internet, rappresentazioni teatrali, programmi
televisivi ecc. su grandi artisti Italiani, online quello sul Caravaggio:
Tutta l'opera del Caravaggio: una mostra
impossibile
La rilevanza internazionale dell'evento
Dopo l'esposizione presso il Palazzo Giustiniani di Roma, la mostra è passata a Berlino,
dove è stata ospitata nel celebre Altes Museum, capolavoro architettonico dello Karl
Friedrich Schinkel. Qui, l'allestimento ha adottato un principio completamente diverso da
quello romano, poiché ha seguito fedelmente la disposizione ivi data ai dipinti dopo che,
nel 1815, il Re di Prussia decise di acquistare la parte più pregevole della Collezione,
messa all'asta a Parigi dai successori della Famiglia già nel 1812. Il proseguimento
della manifestazione in Germania ha consentito di conseguire due risultati importanti:
- il conferirmento alla mostra una dimensione internazionale, che avrà tanto più
successo proprio in virtù del carattere cosmopolita assunto specialmente negli ultimi
anni dalla città di Berlino, considerata una delle capitali europei intellettualmente
più vivaci;
- estendere i risultati scientifici dell'esposizione, che nel suo iter complessivo sarà
in grado di ripercorrere l'intera vicenda che vide la nascita, l'ampliamento e quindi la
dispersione di una delle Collezioni d'arte più celebri del passato.
L'attenzione suscitata all'estero dalla mostra è altresì confermata dall'altissimo
livello del comitato scientifico, composto da alcuni dei più stimati e autorevoli storici
dell'arte, italiani e stranieri, del settore.
Altri progetti connessi
A latere dell'esposizione non mancheranno di susseguirsi manifestazioni ed eventi ad essa
correlati. Dopo il primo convegno internazionale di studi tenutosi a Berlino alla fine del
Giugno 2000, ne seguiranno uno a Roma, in concomitanza con la mostra, ed uno a Vienna,
presso il Kunsthistorisches Museum. La pubblicazione di due volumi, uno concernente gli
inventari della collezione ed uno costituito da saggi critici su particolari aspetti della
raccolta o della storia della famiglia, accompagnerà quella del catalogo della mostra. Si
prevede, inoltre, una nuova edizione degli scritti di Vincenzo Giustiniani sulla Musica,
sulla Pittura, sulla Scultura e sull'Architettura.
Qui di seguito le opere presentate la descrizione delle opere presentate alla mostra
Gli oggetti e i quadri di famiglia
I quadri antichi
La scuola Bolognese
Caravaggio e i Caravaggeschi
Annibale Carracci
Gli oggetti della collezione
neoclassica
La memoria dei
Giustiniani articoli sulla collezione artistica dei Giustiniani da "La
Repubblica" a firma di Paolo Vagheggi, Antonio Pinelli, Claudio Strinati e Ludovico
Pratesi
Sulla mostra Mostra: Caravaggio e i Giustiniani – toccar con mano una collezione del Seicento
Roma, Palazzo Giustiniani, 25 gennaio – 15 maggio 2001 articolo di Marco Bona Castellotti per il Centro Culturale di Milano
Pratesi
Vanta questa Casa di havere
quaranta quadri grandi per Altari. Sulla collezione Giustiniani
di Stefano Pierguidi, sulle pale d'altare della Collezione Giustiniani in "Studi Romani" Anno LIX - NN. 1-4 Gennaio-Dicembre 2011
Tra le pitture pregiatissime vanta questa Casa di havere quaranta quadri grandi per
Altari, ove sia la Vergine Santissima, ed altri Santi tutti originali di pittori primarii
(P. de’ Sebastiani, Viaggio curioso de’ Palazzi e Ville più notabili di Roma, Roma 1683,
p. 32)
LE AVVENTURE DEL
“GLADIATORE-MITRA”
GIUSTINIANI di Rita Paris,
Claudia Valeri
Cortine e tavolini articolo di Serenella Rolfi sull'inventario della Collezione Giustiniani del 1638 e le collezioni seicentesche
Dal sito della Professoressa Danesi Squarzina, il database qui presentato utilizza gli
inventari del cardinale Benedetto Giustiniani, rinvenuti da Silvia Danesi Squarzina:
l’inventario ‘Entrata della Guardarobba’, redatto progressivamente fra il
1600 e il 1611 (Archivio di Stato di Roma, fondo Giustiniani, b. 15) e l’inventario post
mortem, redatto nel marzo 1621 (Archivio di Stato di Roma, Notai del tribunale AC,
uff. 8, Vol. 1302, Rainaldo Buratti).Sono stati aggiunti inoltre, per una parte dei
dipinti, i riferimenti all’inventario post mortem di Vincenzo Giustiniani,
redatto nel 1638 (Archivio di Stato di Roma, fondo Giustiniani, busta 16) rinvenuto da
Luigi Salerno. I due inventari di Benedetto Giustiniani forniscono solo in piccola parte i
nomi degli autori dei dipinti, ma attraverso la collazione con l’inventario (1638)
del fratello minore, suo erede, Vincenzo Giustiniani, sono state identificate numerose
altre opere. Questo lavoro di incrocio dei dati inventariali, pubblicato nel 1997-98
(Danesi Squarzina S., “The collections of Cardinal Benedetto Giustiniani. Part
1”, Documents for the History of Collecting. Published with assistance from the
Provenance Index of the Getty Information Institute in The Burlington Magazine,
1136, CXXXIX, November 1997, pp. 766-791.Danesi Squarzina S.., “The collections of
Cardinal Benedetto Giustiniani. Part II”, Documents for the History of Collecting,
Published with assistance from the Provenance Index of the Getty Information Institute, in
The Burlington Magazine 1139, CXL, February 1998, pp. 102-118) è stato
utilizzato per il database.
E’ da sottolineare il valore sperimentale del database ideato da Irene Baldriga,
esso vuole costituire uno strumento agile e duttile, particolarmente adatto a indagini
sistematiche all’interno di inventari diversi, redatti in varie epoche per una stessa
collezione.La collezione Giustiniani si prestava molto bene a questo tipo di indagine;
essa costituisce un unicum in quanto l’inventario più vasto e importante,
quello del 1638, venne redatto da un conoscitore, e pertanto, grazie alla alta qualità
della collezione, esso ci offre un repertorio impareggiabile per la conoscenza della
pittura del Seicento europeo.
Per una esauriente bibliografia vedi Danesi Squarzina S.., a cura di, Caravaggio e
i Giustiniani, toccar con mano una collezione del Seicento, Catalogo della Mostra,
Roma, Palazzo Giustiniani, Gennaio - Maggio 2001, Berlino, Altes Museum, Giugno -
Settembre 2001, Milano 2001 (ed. in lingua tedesca, Milano 2001).
L'opera completa è stata pubblicata nel 2003 per Einaudi dalla stessa Danesi Squarzina
S., La
collezione Giustiniani: Inventari I, Inventari II, Documenti. La
pubblicazione degli inventari e delle carte d’archivio Giustiniani è un contributo
critico monumentale, una messe di dati che non solo permette di definire le linee-guida
del gusto dei Giustiniani (ai quali, come è noto, spetta il merito di essere stati fra i
primi e più attenti collezionisti di Caravaggio, dato che negli inventari figurano 14
dipinti), ma anche di meglio delineare la metodologia degli studi sul collezionismo, qui
intesa a usare i documenti per il ritrovamento di opere disperse e per la loro corretta
attribuzione: il significato culturale dell’operazione condotta da Silvia Danesi
Squarzina non si esaurisce nella registrazione di dati e documenti.
Visita virtuale a Palazzo
Giustiniani dal sito del Senato un video-audio
con la spiegazione di alcune sale dell’edificio.
 Caravaggio e i Genovesi. Committenti, collezionisti, pittori
Caravaggio e i Genovesi. Committenti, collezionisti, pittori
a cura di Anna Orlando dal 14 Febbraio 2019 al 24 Giugno 2019 - Genova Palazzo della Meridiana
La nuova mostra promossa e organizzata dall’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana e curata da Anna Orlando si prefigge di sviluppare un altro capitolo estremamente importante per la cultura figurativa genovese che, visto il calibro dei protagonisti coinvolti, diventa di portata internazionale. I primi trent’anni del Seicento sono indiscutibilmente un momento magico per la città: il potere economico e finanziario delle famiglie leader della Repubblica Aristocratica Ligure, un numero assi più cospicuo di quante se ne possano immaginare, rendono Genova e il suo porto, un centro baricentrico per l’Europa del tempo. Qui si sono accumulati decenni di benessere, ricchezze, argenti, opere d’arte. Quello che gli storici dell’economia definiscono Il secolo dei genovesi, un centinaio d’anni a cavallo tra il Cinquecento e il Seicento, è per la storia dell’arte genovese un glorioso periodo aureo.
Chi sono i protagonisti, insieme alle famiglie con i lori condottieri, dogi, mercanti e finanzieri?
Gli artisti locali e “forestieri” sono coloro che ci consentono ancora oggi di visualizzare tanta ricchezza. E tanta bellezza.
Caravaggio e i suoi seguaci costituiscono un capitolo importante della storia dell’arte genovese, che in questo momento può dirsi a tutti gli effetti europea, e dunque occidentale.
Palazzo della Meridiana, Salita San Francesco 4, Genova
Telefono: +39 010 2541996 E-Mail info: mostre@palazzodellamerdiana.it
Sito ufficiale: http://www.palazzodellameridiana.it
Calendario a petali
incisione del XVII secolo di Carlo Giustiniani
Amor vincit omnia articolo di Silvia
Castagnino sul quadro di Caravaggio chiamato per fama "Cupido di Caravaggio"
Alcune immagini della "Galleria
Giustiniana" tratta dalla mia collezione personale.
The Giustiniani medicine chest articolo
di J Burnet in inglese su Medical History 1982 July; 26(3): 325–333.
LA GALLERIA GIUSTINIANA
PROGETTO DIGITALIZZAZIONE “SUPERBA ANTIQUA”
(Testo tratto dal sito della Biblioteca
Universitaria di Genova)
Il progetto Superba antiqua della Biblioteca Universitaria di Genova si propone
di valorizzare le testimonianze del gusto e della cultura antiquaria nel territorio
genovese. Ha come scopo la creazione di un itinerario virtuale che illustri i percorsi
storici dell’antiquaria genovese nella cultura libraria, nelle espressioni artistiche
sul territorio (temi iconografici della decorazione architettonica, portali, statue e
busti antichi o all’antica) e nel collezionismo. Nell’ambito di questo progetto
si è proceduto alla digitalizzazione di immagini e parti testuali di alcune opere a
soggetto antichistico-archeologico conservate nella Biblioteca Universitaria di Genova,
con data di edizione compresa fra i secoli XVI e XVII, di cui si consentirà
l’utilizzo multimediale attraverso il sito della Biblioteca. L’informatizzazione
di questi esemplari ha anche lo scopo di garantire la tutela e la conservazione di un bene
culturale ad alta deperibilità, quale quello dei libri antichi, e di permettere,
attraverso la successiva messa in rete, la fruizione ad un pubblico più vasto di testi
rari e di non sempre facile reperimento. I criteri di scelta dei testi e delle immagini
digitalizzate sono stati determinati dalle finalità del progetto stesso, pertanto sono
state scelte opere che, pur significative nella storia degli studi archeologici e delle
metodologie, presentano anche attinenza con la cultura antiquaria locale nei secoli
considerati, in particolare con i temi decorativi di gusto antiquario più diffusi nelle
espressioni artistiche genovesi e liguri, e con il collezionismo di manufatti antichi o
all’antica. Responsabili del progetto : il progetto è frutto della collaborazione
tra gli insegnamenti di Storia dell’Archeologia (Luigina Quartino) e Iconografia
Antica (Alba Bettini) della Sezione di Archeologia del D.AR.FI.CL.ET “Francesco Della
Corte”dell’Università degli Studi di Genova, Alberta Bedocchi studiosa di
Storia dell’Archeologia ed Antiquaria e per la Biblioteca Universitaria di Genova
Oriana Cartaregia e Maria Teresa Sanguineti. La ripresa fotografica e la parte
multimediale sono state realizzate da Raffaella Vancheri con l’aiuto di Giorgia
Rodino (Conservazione Beni Culturali). La messa in linea è riportata su questo sito, è
curata da Oriana Cartaregia sul sito della Biblioteca Universitaria di Genova.
Galleria Giustiniana del marchese Vincenzo Giustiniani,
(Parte prima) - seconda, [Genova, Carlo Losi , 1757 ?]
(Testo tratto dal sito della Biblioteca
Universitaria di Genova)
Raccolta di incisioni delle sculture più importanti
della collezione di antichità di Vincenzo Giustiniani (Chios 1564-Roma 1637).
Disegni e lastre furono realizzati fra il 1631 e il 1637 da un gruppo
di trentacinque artisti, italiani e stranieri, alcuni dei quali lavorarono nello
stesso palazzo Giustiniani a Roma. Tra i nomi più noti si ricordano Joachim von
Sandrart, François Duquesnoy, Charles Audran, Claude Mellan, Theodor Matham, Cornelis
Bloemaert, François Perrier. Le prima serie di stampe fu impressa dalla bottega di
Giuseppe De Rossi intorno al 1635. Per disposizione di Vincenzo Giustiniani le
matrici della Galleria Giustiniana furono successivamente ereditate dall'albergo
Giustiniani di Genova affinché i ricavi delle tirature fossero investiti in Monti
camerali inalienabili, a beneficio dei membri bisognosi dell'albergo. I rami giunsero a
Genova in data imprecisata, fra il 1638 e il 1678, ma la nuova impressione vide la luce
solo nel 1757 a cura di Carlo Losi e probabilmente non fu seguita da altre edizioni.
Dimenticate fra le carte d'archivio della famiglia Giustiniani e a lungo ritenute
disperse, 280 lastre incise della Galleria sono state individuate nel 1983
dalla Soprintendenza Archivistica della Liguria. Restaurati a cura dell'Istituto Nazionale
per la Grafica di Roma, il 25 marzo 2010 i rami sono tornati a Genova custoditi dall'Accademia Ligustica di Belle arti, antica istituzione di cui tra l’altro nel 1773 fu «principe» proprio Luca Giustiniani, grazie anche all’intervento dei Lions club genovesi Santa Caterina, Capo Santa Chiara e Alta Valpolcevera. .
Le incisioni sono riunite in due tomi e distinte per soggetto e tipologia di scultura. Il
primo tomo contiene statue di divinità, eroi e viri illustres; il secondo busti
o ritratti, teste ideali, erme di filosofi e divinità, rilievi, sarcofagi e are. Le
incisioni comprendono anche alcuni ritratti dei membri della famiglia, una serie di
vedute delle proprietà Giustiniani e otto riproduzioni di dipinti con soggetto di
Madonne.
Le tavole con le sculture antiche sono prive di didascalie identificative. La riproduzione
non tiene conto del supporto, specialmente per i rilievi, né dello stato originale dei
reperti, rappresentati sempre in condizione di restauro.
Gli stretti rapporti che il marchese Vincenzo Giustiniani mantenne con la patria di
origine (fu ascritto alla nobiltà di Genova nel 1577 ed ebbe per moglie la genovese
Eugenia, figlia di Gio Battista Spinola principe di Vergagni e di Porzia Centurione), il
ruolo, ereditato dal padre, di banchiere e mediatore finanziario fra gli investitori
genovesi e la Curia romana, il prestigio paradigmatico della sua collezione di antichità
avvalorano l'importanza della Galleria Giustiniana in relazione
alla cultura antiquaria e al collezionismo genovese del XVII secolo. Non sembra da
trascurare che fra gli artisti che lavorarono alla Galleria Giustiniana
vi fu anche il disegnatore genovese Giovanni Andrea Podestà (Genova 1608-post 1674),
allievo di Giovan Battista Paggi e Domenico Fiasella. E' interessante ricordare che
il suocero di Vincenzo, Gio Battista Spinola, fu il committente di uno dei prestigiosi
palazzi di Strada Nuova (Palazzo Doria), decorato con sculture antiche e
all'antica.
Per queste motivazioni si è ritenuto opportuno inserire nella sezione digitale del
progetto Superba antiqua questo esemplare della Galleria Giustiniana,
entrato di recente nelle raccolte della Biblioteca Universitaria di Genova in sostituzione
della copia scomparsa nella seconda metà del XIX secolo, già segnata nel Catalogo del
1785-1787 (Bibliothecae Universitatis Genuensis Catalogus secundum Auctorum cognomina
ordine alphabetico dispositus - 1785-1787).
NOTA
Nell'Indice (Parte I-II) la colonna 'SOGGETTO' indica le
didascalie desunte dalle fonti seicentesche e dalla soggettazione manoscritta
sull'esemplare presso la Biblioteca Alessandrina, rielaborate nella 'Tavola di
concordanza', in G. Fusconi (a cura di), I Giustiniani e l'Antico,
Catalogo della Mostra. Genova, Museo dell'Accademia Ligustica di Belle Arti, 15 giugno -
28 luglio 2002. La colonna IDENTIFICAZIONI riporta i soggetti secondo la moderna
terminologia, con riferimento al reperto antico o al suo modello.
La collocazione attuale delle sculture individuate è stata segnalata in parentesi tonda.
Sono state distinte con simboli diversi, rispettivamente: le sculture pubblicate nel
Catalogo I Giustiniani e l'Antico, le sculture identificate in altri studi,
quelle individuate nel corso di questa ricerca e suggerite come probabili, e quelle non
ancora rintracciate o scomparse.
E' stato redatto un elenco separato delle sculture Giustiniani individuate nelle
raccolte Torlonia secondo lo studio di C. Gasparri (con la collaborazione di I. Caruso), Materiali
per servire allo studio del Museo Torlonia di scultura antica in "Atti della
Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie. Classe di Scienze morali, storiche e
filologiche", XXIV, 1980, pp. 37-239. Non è stato possibile verificare direttamente
i materiali conservati in questa raccolta perchè attualmente non accessibile.
La Bibliografia è relativa alle sculture identificate.
Indice tavole Parte I
Indice tavole Parte II
 I Marmi Torlonia. Collezionare Capolavori
I Marmi Torlonia. Collezionare Capolavori
Roma - Musei Capitolini,
Villa Caffarelli (dal 14 ottobre 2020 al 9 gennaio 2022)
Dopo anni di oblio,
è stata finalmente esposta al pubblico fino al 21 giugno 2021 a Roma
a Palazzo Caffarelli (Musei Capitolini) la “collezione Torlonia” di arte classica è la più importante collezione privata di opere antiche. La mostra è il risultato di un’intesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con la Fondazione Torlonia; e nello specifico, per il Ministero, della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con la Soprintendenza Speciale di Roma. Il progetto scientifico di studio e valorizzazione della collezione è di Salvatore Settis e Carlo Gasparri, curatori della mostra.
La mostra ha proposto circa 60 opere tra cui l'Hestia Giustiniani, la Fanciulla Torlonia, l’Atleta di Mirone ed il Diadumeno di Policleto.
L'accordo per la valorizzazione della collezione Torlonia, è stato firmato
tra l'amministratore della Fondazione Torlonia e il Ministero dei Beni Culturali. La Fondazione sosterrà le spese per il restauro dei reperti, mentre il Ministero, tramite la Soprintendenza Speciale Archeologica di Roma, provvederà a realizzare la mostra.
La collezione Torlonia, composta da: busti, ritratti, rilievi, con capolavori come le pitture parietali della tomba François di Vulci, considerate fra gli esempi più alti dell'arte etrusca, testimonianza della storia dei Tarquini e della nascita di Roma, è formata da 620 sculture greche e romane provenienti in parte dalle collezioni private dei Caetani-Ruspoli, dei Carpi, dei Cesarini e di Bartolomeo Cavaceppi ed in gran parte da quella dei Giustiniani (ben 115 sculture, in pratica i migliori pezzi), venduta ai Torlonia nel XIX secolo. Opere acquistate dalle grandi famiglie romane decadute, tutte indebitate con i Torlonia, che spesso saldavano i debiti svendendo le loro collezioni d’arte.
Altri capolavori della collezione invece provengono dagli scavi archeologici nei terreni degli stessi Torlonia, tra cui la Villa dei Quintili e la Villa di Massenzio sull’Appia antica. In particolare venne saccheggiata la "Villa dei Quintili", la più grande villa del suburbio romano, che lo Stato Italiano ha acquistato solo nel 1985. Era conosciuta come "Statuario", per la ricchezza delle opere d'arte, o anche come "Roma Vecchia", perché era talmente grande che le rovine monumentali richiamavano un'antica città.
Fin dal 1948 palazzo Torlonia che conteneva il nucleo principale della collezione, è stato sottoposto a vincolo, ma all’inizio degli anni ottanta il principe Alessandro ottiene l'autorizzazione a restaurare il palazzo e trasformarlo in 93 miniappartamenti, mentre le sculture vengono imballate e trasferite in tre stanzoni del Palazzo in via della Lungara.
Da quel momento è cominciata una vera guerra legale tra lo Stato italiano e il principe
 Alessandro, ma senza trovare nessuna soluzione soddisfacente per tutti.
Alessandro, ma senza trovare nessuna soluzione soddisfacente per tutti.
Una collezione che ha rischiato più volte di disperdersi o di essere venduta, che finalmente sarà raccolta e catalogata per il grande pubblico. Una collezione in un certo senso fantasma, in quanto essendo privata , gli eredi Torlonia ne disponevano eventuali visite a loro assoluta discrezione, tanto è che si narra che il grande archeologo Ranuccio Bianchi Bandinelli nel 1947 si travestì da spazzino per poterla ammirare di nascosto.
Pezzo forte della mostra è stata la Hestia Giustiniani, appartenuta alla collezione del marchese Vincenzo Giustiniani sin dai primi anni Trenta del XVII secolo, in cui viene descritta nel suo inventario come una "vergine vestale vestita, di marmo greco tutta antica alta palmi 9 inc.a". La statua costituisce l'unica replica intera, di grandi dimensioni, di un originale in bronzo databile agli anni 470-460 a.C., di mano di un maestro di scuola peloponnesiaca. Alcuni critici hanno proposto di riconoscervi la mano di Kalamis, autore della celebre Sosandra, altri ad un artista argivo o addirittura il maestro attico Alkamenes.
La statua è di grande importanza per l'evoluzione della figura muliebre nella scultura greca. Rappresenta una dea a figura intera, con il braccio sinistro piegato e la mano volta verso l'alto ed il volto ombreggiato da ciocche dense e pesanti sotto il velo. Un panneggio avvolge il corpo senza mortificarlo ma ne esalta le forme vigorose. Lo scettro appare funzionale non soltanto alla statica della figura, ma anche all'equilibrio interno e strutturale della medesima: ne assesta la leggera torsione verso destra del busto, giustificandone l'asimmetria dei seni, in accordo col gesto del braccio flesso dalla mano poggiata col dorso sul fianco.
La grande statua di Hestia passò dai Giustiniani ai Torlonia nel corso dell'Ottocento; portata nel palazzo alla Lungara dove fu allestito il celebre museo di scultura descritto dal Visconti, vi rimase fino a quando nella seconda metà del XX secolo fu trasferita nella Villa Albani, da dove uscì nei primi anni Novanta per essere collocata nel cortile del palazzo di famiglia, ex Giraud, su via della Conciliazione.

 Nella raccolta di antichità Giustiniani
ora confluita nella Collezione Torlonia anche il "Ritratto maschile, detto
Eutidemo di Battriana". Questo ritratto raffigurante un uomo dall’espressione severa, segnato da un fervido realismo, compariva come “servo pileato”, ovvero recante il pileo, berretto comunemente indossato da individui di umile estrazione. Prediligendo una diversa lettura del copricapo, simile alla kausia macedone, considerata con il diadema insegna regale e simbolo di potere a partire da Alessandro Magno, la figura
Nella raccolta di antichità Giustiniani
ora confluita nella Collezione Torlonia anche il "Ritratto maschile, detto
Eutidemo di Battriana". Questo ritratto raffigurante un uomo dall’espressione severa, segnato da un fervido realismo, compariva come “servo pileato”, ovvero recante il pileo, berretto comunemente indossato da individui di umile estrazione. Prediligendo una diversa lettura del copricapo, simile alla kausia macedone, considerata con il diadema insegna regale e simbolo di potere a partire da Alessandro Magno, la figura
 virile ritratta è stata tradizionalmente identificata con Eutidemo I, dinasta ellenistico che ha regnato sulla Battriana, terra anticamente parte dell’impero di Alessandro Magno.
virile ritratta è stata tradizionalmente identificata con Eutidemo I, dinasta ellenistico che ha regnato sulla Battriana, terra anticamente parte dell’impero di Alessandro Magno.
Altro pezzo della collezione Giustiniani in mostra "il Caprone di Gian Lorenzo Bernini"
Le zampe distese, la testa leggermente inclinata a sinistra, il morbido modellato delle ciocche frutto di un mirabile intervento seicentesco, che i restauri moderni hanno permesso di ricondurre alla prodigiosa mano di Gian Lorenzo Bernini.
Nella Sala 8 la Statua di caprone dalla collezione Giustiniani ha incantato con il suo sguardo decisamente umano. Accanto a lui, la statuetta di Artemide Efesia (II secolo d.C.), con la testa e le mani moderne in marmo nero o la Statua di Afrodite accovacciata, replica degli inizi del I secolo d.C. da originale della metà del II secolo a.C., con testa moderna attribuita a Pietro Bernini. Forse la scultura di questo possente animale, risalente all’età imperiale, avrebbe dovuto arredare una dimora romana.
Il Marchese Vincenzo Giustiniani l’acquistò per la celeberrima Galleria di Palazzo Giustiniani, edificio frequentato sin da giovane da Bernini, profondo conoscitore della statuaria romana ed ellenistica. Fu lui a dedicarsi con estrema perizia al restauro dei marmi presenti nella raccolta di antichità voluta dal marchese, che sarebbe confluita più tardi nella Collezione Torlonia
Dal 22 settembre al 31 dicembre 2018, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio,
si sono svolte due importi mostre a Genova
all'Accademia Ligustica
e alla Biblioteca Universitaria che hanno visto esposti degli esemplari della "Galleria Giustiniana"
ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI DI GENOVA -
"L'ANTICO COME MODELLO"
 Presso le sale del Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova è
stata allestita la mostra “L’antico come modello”, a cura di Giulio Sommariva e Mariangela Bruno, proposta al pubblico nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, in collaborazione con la Biblioteca Universitaria di Genova. Sono
stati esposti marmi, gessi, matrici in rame e preziose stampe conservati nel patrimonio dell’Accademia Ligustica, in sostanza gli antichi strumenti di riproduzione di opere d’arte agli albori della riproducibilità tecnica.
I calchi in gesso, insieme con incisioni di riproduzione, costituivano infatti modelli e repertori indispensabili per una didattica improntata allo studio del “bello antico” e al confronto con le opere dei grandi maestri attraverso la pratica della copia
Al centro della mostra le 42 stampe e alcune matrici in rame della “Galleria Giustiniana”:
un vero e proprio catalogo illustrato in due tomi che rappresentò il primo
esempio di un preciso programma editoriale indirizzato, da un lato, a illustrare
sculture antiche, dall’altro a magnificare la cultura e la ricchezza del
collezionista-committente.
Presso le sale del Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova è
stata allestita la mostra “L’antico come modello”, a cura di Giulio Sommariva e Mariangela Bruno, proposta al pubblico nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, in collaborazione con la Biblioteca Universitaria di Genova. Sono
stati esposti marmi, gessi, matrici in rame e preziose stampe conservati nel patrimonio dell’Accademia Ligustica, in sostanza gli antichi strumenti di riproduzione di opere d’arte agli albori della riproducibilità tecnica.
I calchi in gesso, insieme con incisioni di riproduzione, costituivano infatti modelli e repertori indispensabili per una didattica improntata allo studio del “bello antico” e al confronto con le opere dei grandi maestri attraverso la pratica della copia
Al centro della mostra le 42 stampe e alcune matrici in rame della “Galleria Giustiniana”:
un vero e proprio catalogo illustrato in due tomi che rappresentò il primo
esempio di un preciso programma editoriale indirizzato, da un lato, a illustrare
sculture antiche, dall’altro a magnificare la cultura e la ricchezza del
collezionista-committente.
La mostra è stata un’occasione unica per ammirare una parte delle stampe della “Galleria Giustiniana” di cui i due volumi furono donati da Luca Giustiniani nel 1778: per motivi di conservazione le stampe possono essere esposte per massimo 3 mesi e bisognerà attendere anni prima di poterle vedere nuovamente.
L’Accademia Ligustica in cui è tutt’ora attivissima una Scuola di Incisione di antica tradizione è depositaria inoltre dal 2002 delle “matrici Giustiniani” per volontà degli eredi della Famiglia Giustiniani e d’intesa con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, in quanto istituzione che ne può garantire la tutela e la valorizzazione. Normalmente conservate nella sala dei depositi del museo e visitabili su richiesta, alcune delle lastre in rame sono eccezionalmente esposte per l’occasione.
Ulteriori esempi dell’arte della copia cui è dedicata la mostra sono opere in gesso conservate nella gipsoteca, fondata insieme all’Accademia Ligustica fin dalla sua origine nel 1751. Si tratta di riproduzioni delle opere monumentali più prestigiose della classicità – dall’Antinoo Capitolino al Gladiatore Borghese, accanto ai capolavori del Rinascimento e del Neoclassicismo, dalle figure del Crepuscolo e dell’Aurora delle Tombe Medicee di Michelangelo fino alla Ebe di Canova ed al Mercurio di Thorvaldsen. Sono inoltre messe in evidenza per il pubblico due statue in marmo: la Testa dello pseudio Vitellio, o Vitellio Durazzo, opera di uno sconosciuto scultore del XVII secolo (a lungo erroneamente ritenuta di epoca romana) e l’antica Torso di satiro del II secolo d. C.
Accademia Ligustica di Belle Arti
Palazzo dell'Accademia
Largo Pertini 4 (Piazza De Ferrari), 16121 Genova
 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA - "FACCE DI MARMO,
PERCORSI DI CULTURA ANTIQUARIA"
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA - "FACCE DI MARMO,
PERCORSI DI CULTURA ANTIQUARIA"
Attraverso alcuni dei volumi del fondo antico della Biblioteca Universitaria di Genova, pubblicati tra il XVI e il XVIII secolo,
è stato possibile riflettere sulla cultura antiquariale, che tanto appassionò gli eruditi e i sovrani d’Europa a partire dal XV secolo.
Tale tematica attraversa diversi generi letterari (spaziando dalle biografie degli imperatori romani, ai repertori di monete e gemme,
alle raccolte di statue) e si diffuse grazie ad un’intensa produzione editoriale che mise in relazione centri geografici distanti tra loro, creando dialoghi e scambi.
Tra i volumi un ricco apparato iconografico è presentato dalla Galleria Giustiniana: il formidabile catalogo dei marmi antichi del marchese Vincenzo Giustiniani, di cui la Biblioteca Universitaria possiede un esemplare del 1757.
La mostra è stata curata da Alberta Bedocchi, Mariangela Bruno, Oriana Cartaregia e Valentina Sonzini.
La mostra si articola dopo un introduzione su Ciriaco d’Ancona e la scoperta dell’antica Grecia, in cinque sezioni: 1) “Roma quanta fuit, ipsa ruina docet”. 2) Impossessarsi dell’antico: raccolte di epigrafi, monete e gemme.
3) la scienza antiquaria: la sistematizzazione di un sapere. Osservare, catalogare e divulgare, 5) Nobilia opera. Statue e busti. 6) Le collezioni, Cultura antiquaria a Genova.
Biblioteca Universitaria di Genova
Via Cesare Balbi 40, 16121 Genova
Mistero napoletano (passando da Londra). Spunta un Caravaggio
Un gruppo di studiosi attribuisce al maestro un'opera inedita: un "San
Girolamo" del 1607
ilgiornale.it di Andrea Dusio
È questo il titolo del saggio di Mario Marubbi che annuncia il rinvenimento di un dipinto inedito, che si presume - con una fitta rete di indizi convergenti - autografo di Michelangelo Merisi.  La tela, che raffigura il monaco autore della Vulgata in atteggiamento penitenziale, dal 2012 è entrata in una collezione privata vicina al nostro Paese, ed è stata restaurata da Valeria Merlini e Daniela Storti, sino a venir pubblicato nelle prossime settimane in un volume a più mani di Skira: Caravaggio.
Si trovava precedentemente a Londra, dove tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento figurava tra le proprietà dell'incisore, gioielliere, tipografo e libraio Garnet Terry, come si desume dalla scritta «Mr. G. Terry by 20», riportata a matita sul verso della tela. Calvinista, Garnet Terry è noto soprattutto per la pubblicazione di mappe geografiche e stradali. Vicino alle posizioni millenariste espresse nelle immagini di William Blake, non era un collezionista d'arte, ma la tolleranza religiosa di San Girolamo può averlo spinto ad acquistare un dipinto raffigurante il presbitero, la cui immagine all'epoca in Inghilterra era molto conosciuta anche in ragione della circolazione di una stampa di Hamilton che riproduce un dipinto di Guido Reni ora alla National Gallery.
Il dipinto ora attribuito a Caravaggio raffigura il santo in piedi, visibile dalle ginocchia in su, mentre si appoggia con la mano sinistra a un libro, su di un altare improvvisato. Un altro libro, forse la stessa Vulgata, è poggiato a fianco, e un terzo fa da supporto a un crocifisso, su cui Girolamo è piegato in atto di contrizione, mentre si percuote il petto con una pietra. Di fronte al mistero della morte di Cristo per lo studioso anche l'esercizio intellettuale non è altro che Vanitas: libro e crocifisso sono appoggiati a un teschio. È una sorta di estrema raffinazione dell'iconografia gerominiana in chiave ascetica. Non siamo ancora sul terreno dei Girolamo visionari e allampanati di Ribera: il tono è infatti quello delle cupe meditazioni a cui Caravaggio si abbandona nell'estate del 1606, dopo la fuga da Roma per l'assassinio in duello di Ranuccio Tommasoni. Spiega Mario Marubbi, che firma l'attribuzione: «La stesura veloce lascia supporre una datazione quanto meno successiva all'abbandono di Roma. Le stesure di colore mi ricordano il San Francesco in Meditazione della Pinacoteca Ala Ponzone di Cremona. Ci sono affinità sia con il periodo napoletano che con l'attività a Malta e addirittura si colgono elementi di continuità con l'opera estrema. Tuttavia la pastosità della materia cromatica e il colore ancora squillante fanno propendere per una datazione leggermente precedente. Occorre ricordare che siamo soliti suddividere l'attività del Merisi a seconda delle sue dislocazioni, ma in realtà tra una fase e l'altra dal punto di vista cronologico intercorrono pochi mesi. Per esempio ci sono rapporti molto stretti tra questo San Girolamo e La negazione di Pietro, che è ritenuta del 1609, con l'Adorazione dei Pastori di Messina, ma anche con il primo periodo napoletano».
Le evidenze tecniche sono numerosissime: dalle incisioni a definire la collocazione del braccio sinistro, simili a quelle del San Giovannino Corsini, alla resa dei panneggi a fitte pieghe che virano dal bianco luminoso al bianco cenere, come nella già citata Negazione di Pietro, sino all'uso di una preparazione rosso-brunastra funzionale alla pittura a risparmio e a sorprendenti pentimenti, come sottolineato nel contributo di Claudio Falcucci. Sul piano stilistico, il particolare più sorprendente è forse la modalità esecutiva del chiodo infisso nel palmo della mano del crocifisso, che è dotato di una larga testa piramidale, esattamente come nel San Girolamo dipinto a Malta per Ippolito Malaspina.
Il primo effetto di quest'inedito è di far finalmente giustizia dell'identificazione del San Girolamo segnalato negli inventari Giustiniani con il dipinto presente nel Museo di Montserrat. Sulla scorta dell'attribuzione fatta a suo tempo da Maurizio Marini del 1973, che lo collegò alla collezione della famiglia romana, il quadro del monastero spagnolo è stato introdotto anche nel catalogo ristretto degli autografi certi alla mostra milanese Dentro Caravaggio del 2017. Gli stessi studiosi che avevano lavorato a quella monografica ammisero che la tela presentava diversi problemi (non ultimo che il santo fosse in meditazione e non in preghiera), ora conclamati dalla emersione di un dipinto che si adatta per iconografia in maniera molto più stringente alla descrizione che l'abate Silos ci ha lasciato nel 1673 del dipinto Giustiniani: «Sua prima occupazione è quella di estinguere l'ira divina/ con la penitenza, battendosi il petto con una pesante pietra». Marini riportava le misure del dipinto spagnolo in 110x81, mentre esse sono in realtà 140x101,5 cm (ben eccedenti quelle segnalate nell'inventario). Trenta centimetri di differenza che hanno prodotto un errore di 46 anni: il nuovo San Girolamo è giudicato incompatibile (per uno scarto di misure assai minore) con quello Giustiniani, ma ci riporta sulla strada giusta, perché è probabilmente una seconda versione di quello, dipinta a Napoli per la famiglia Mastrillo dei duchi di San Marzano. Abbiamo infatti un documento di pagamento del figlio del marchese, Gerolamo Juniore, che il 28 aprile 1607 versa al Caravaggio 30 ducati del Banco dello Spirito Santo «a compimento di un quadro con l'Imagine di San Geronimo che li ha fatto e consegnato atteso il remanente con(tanti) e per lui a Gio. Battista Caracciolo».
Com'è arrivato poi questo dipinto a Londra? La collezione Mastrillo confluì in quella dei Ceva Grimaldi, in cui il pittore Giuseppe Bonito ci segnala la presenza di ben tre San Girolamo, due inediti e uno di Ludovico Carracci. È lui stesso a rilevare il quadro, per 25 ducati, la stessa cifra pagata per una Historia del Buon Samaritano ritenuta del Caravaggio. Bonito deve poi aver ceduto l'opera sul mercato, in tempi vicini al suo passaggio in Inghilterra, e di qui nella raccolta dell'incisore Terry
La tela, che raffigura il monaco autore della Vulgata in atteggiamento penitenziale, dal 2012 è entrata in una collezione privata vicina al nostro Paese, ed è stata restaurata da Valeria Merlini e Daniela Storti, sino a venir pubblicato nelle prossime settimane in un volume a più mani di Skira: Caravaggio.
Si trovava precedentemente a Londra, dove tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento figurava tra le proprietà dell'incisore, gioielliere, tipografo e libraio Garnet Terry, come si desume dalla scritta «Mr. G. Terry by 20», riportata a matita sul verso della tela. Calvinista, Garnet Terry è noto soprattutto per la pubblicazione di mappe geografiche e stradali. Vicino alle posizioni millenariste espresse nelle immagini di William Blake, non era un collezionista d'arte, ma la tolleranza religiosa di San Girolamo può averlo spinto ad acquistare un dipinto raffigurante il presbitero, la cui immagine all'epoca in Inghilterra era molto conosciuta anche in ragione della circolazione di una stampa di Hamilton che riproduce un dipinto di Guido Reni ora alla National Gallery.
Il dipinto ora attribuito a Caravaggio raffigura il santo in piedi, visibile dalle ginocchia in su, mentre si appoggia con la mano sinistra a un libro, su di un altare improvvisato. Un altro libro, forse la stessa Vulgata, è poggiato a fianco, e un terzo fa da supporto a un crocifisso, su cui Girolamo è piegato in atto di contrizione, mentre si percuote il petto con una pietra. Di fronte al mistero della morte di Cristo per lo studioso anche l'esercizio intellettuale non è altro che Vanitas: libro e crocifisso sono appoggiati a un teschio. È una sorta di estrema raffinazione dell'iconografia gerominiana in chiave ascetica. Non siamo ancora sul terreno dei Girolamo visionari e allampanati di Ribera: il tono è infatti quello delle cupe meditazioni a cui Caravaggio si abbandona nell'estate del 1606, dopo la fuga da Roma per l'assassinio in duello di Ranuccio Tommasoni. Spiega Mario Marubbi, che firma l'attribuzione: «La stesura veloce lascia supporre una datazione quanto meno successiva all'abbandono di Roma. Le stesure di colore mi ricordano il San Francesco in Meditazione della Pinacoteca Ala Ponzone di Cremona. Ci sono affinità sia con il periodo napoletano che con l'attività a Malta e addirittura si colgono elementi di continuità con l'opera estrema. Tuttavia la pastosità della materia cromatica e il colore ancora squillante fanno propendere per una datazione leggermente precedente. Occorre ricordare che siamo soliti suddividere l'attività del Merisi a seconda delle sue dislocazioni, ma in realtà tra una fase e l'altra dal punto di vista cronologico intercorrono pochi mesi. Per esempio ci sono rapporti molto stretti tra questo San Girolamo e La negazione di Pietro, che è ritenuta del 1609, con l'Adorazione dei Pastori di Messina, ma anche con il primo periodo napoletano».
Le evidenze tecniche sono numerosissime: dalle incisioni a definire la collocazione del braccio sinistro, simili a quelle del San Giovannino Corsini, alla resa dei panneggi a fitte pieghe che virano dal bianco luminoso al bianco cenere, come nella già citata Negazione di Pietro, sino all'uso di una preparazione rosso-brunastra funzionale alla pittura a risparmio e a sorprendenti pentimenti, come sottolineato nel contributo di Claudio Falcucci. Sul piano stilistico, il particolare più sorprendente è forse la modalità esecutiva del chiodo infisso nel palmo della mano del crocifisso, che è dotato di una larga testa piramidale, esattamente come nel San Girolamo dipinto a Malta per Ippolito Malaspina.
Il primo effetto di quest'inedito è di far finalmente giustizia dell'identificazione del San Girolamo segnalato negli inventari Giustiniani con il dipinto presente nel Museo di Montserrat. Sulla scorta dell'attribuzione fatta a suo tempo da Maurizio Marini del 1973, che lo collegò alla collezione della famiglia romana, il quadro del monastero spagnolo è stato introdotto anche nel catalogo ristretto degli autografi certi alla mostra milanese Dentro Caravaggio del 2017. Gli stessi studiosi che avevano lavorato a quella monografica ammisero che la tela presentava diversi problemi (non ultimo che il santo fosse in meditazione e non in preghiera), ora conclamati dalla emersione di un dipinto che si adatta per iconografia in maniera molto più stringente alla descrizione che l'abate Silos ci ha lasciato nel 1673 del dipinto Giustiniani: «Sua prima occupazione è quella di estinguere l'ira divina/ con la penitenza, battendosi il petto con una pesante pietra». Marini riportava le misure del dipinto spagnolo in 110x81, mentre esse sono in realtà 140x101,5 cm (ben eccedenti quelle segnalate nell'inventario). Trenta centimetri di differenza che hanno prodotto un errore di 46 anni: il nuovo San Girolamo è giudicato incompatibile (per uno scarto di misure assai minore) con quello Giustiniani, ma ci riporta sulla strada giusta, perché è probabilmente una seconda versione di quello, dipinta a Napoli per la famiglia Mastrillo dei duchi di San Marzano. Abbiamo infatti un documento di pagamento del figlio del marchese, Gerolamo Juniore, che il 28 aprile 1607 versa al Caravaggio 30 ducati del Banco dello Spirito Santo «a compimento di un quadro con l'Imagine di San Geronimo che li ha fatto e consegnato atteso il remanente con(tanti) e per lui a Gio. Battista Caracciolo».
Com'è arrivato poi questo dipinto a Londra? La collezione Mastrillo confluì in quella dei Ceva Grimaldi, in cui il pittore Giuseppe Bonito ci segnala la presenza di ben tre San Girolamo, due inediti e uno di Ludovico Carracci. È lui stesso a rilevare il quadro, per 25 ducati, la stessa cifra pagata per una Historia del Buon Samaritano ritenuta del Caravaggio. Bonito deve poi aver ceduto l'opera sul mercato, in tempi vicini al suo passaggio in Inghilterra, e di qui nella raccolta dell'incisore Terry
RITROVATO "UN CARAVAGGIO" DELLA COLLEZIONE GIUSTINIANI ... O NUOVA BUFALA?
Di seguito alcuni articoli su questo link la rassegna stampa completa:
Caravaggio 400 - di Michele Cuppone
Trovato il Sant'Agostino di Caravaggio dipinto per Vincenzo Giustiniani
(di Marco Carminati, Il Sole24ore del 12 giugno 2011)
 Passeggiando nei giardini del Quirinale, in occasione della celebrazione della ricorrenza del 2 giugno, rievocavo con il consigliere di Stato Damiano Nocilla, già segretario generale del Senato, il successo della mostra «Caravaggio e i Giustiniani» che si inaugurò nel gennaio 2001 a Palazzo Giustiniani con una coda di folla che arrivava fino al Pantheon. Io stessa, che avevo dedicato alle ricerche necessarie alcuni anni della mia vita, ero incredula e, certo, felice. Il padrone di casa era il presidente del Senato di allora, Nicola Mancino. L'esposizione riportava nella sede originaria capolavori dell'antica collezione Giustiniani dispersi in vari musei del mondo. La qualità delle opere riunite – e non mancarono le scoperte, come una statua di Michelangelo inedita nota solo attraverso le fonti – rivelava il gusto raffinato e colto di Benedetto e Vincenzo Giustiniani. Cercai di lasciar parlare i due collezionisti, e di ricostruire quella magica commistione, evidente nella prima e nella seconda stanza dei quadri antichi (descritte dagli inventari), fra artisti del '400 e del '500, e pittori viventi, scelti con estremo rigore qualitativo.
Michelangelo Merisi detto Caravaggio era ammesso interamente nell'Olimpo voluto e pensato dal marchese Vincenzo. I suoi dipinti sono elencati in questo prestigioso contesto: per i Giustiniani il maestro aveva dipinto capolavori come L'amore vincitore (Berlino, Gemälde Galerie) o L'incredulità di S. Tommaso (Potsdam, Bildergalerie von Sanssouci). I Caravaggio dei Giustiniani erano ben quindici, ma ce ne sono pervenuti solo cinque. Altri tre (S. Matteo con l'angelo, Cristo nell'orto, Fillide) sono stati distrutti (oppure sono spariti) a Berlino alla fine della Seconda guerra mondiale, e li conosciamo solo in fotografia. I rimanenti quadri sono un autentico chiodo fisso per noi studiosi: non muore mai la speranza che improvvisamente riaffiorino da qualche parte.
Oltre un anno fa, nel maggio 2010, mi venne sottoposto un dipinto inedito, raffigurante S. Agostino, emerso da una collezione privata spagnola. Mi resi conto che si trattava dell'opera di Caravaggio descritta negli inventari redatti personalmente da Vincenzo Giustiniani e trascritti dal notaio nel 1638: «Un quadro d'una mezza figura di Sant'Agostino depinto in tela alta palmi 5. e 1/2 e larga 4. 1/2 incirca di mano di Michelangelo da Caravaggio con sua cornice negra» conservato nella prima stanza dei quadri antichi. Questo quadro rimase nella collezione Giustiniani per secoli, menzionato in tutti gli inventari successivi fino alla vendita, avvenuta fra il 1857 e il 1862.
Sovente vengono compiute attribuzioni e identificazioni attraverso il confronto con inventari di antiche collezioni. Ma il nesso è spesso molto aleatorio. Non in questo caso. Un'etichetta in pergamena posta sul retro del telaio costituisce una connessione inequivocabile. La scritta su di essa non era di immediata comprensione, ma per fortuna il secondo dei tre volumi da me pubblicati nel 2003 presso Einaudi, contenenti tutti gli inventari della collezione e redatti in varie epoche, mi ha offerto la spiegazione. Le parole scritte sull'etichetta forse dalla mano del collezionista spagnolo che acquistò il S. Agostino sono precisamente queste: «Procedencia del Marqués Recanelli en la calle del gobierno». Si tratta del marchese Pantaleo Vincenzo Giustiniani Recanelli, il quale nel 1857 era divenuto, dopo una lunga causa, l'erede legale dei resti della collezione Giustiniani (la parte maggiore era già stata venduta nel 1815 al re di Prussia) e si era insediato nell'antico palazzo. Il termine spagnolo «calle del gobierno» è la traduzione di Via del Governo, ossia l'indirizzo di allora (al n. 38) di Palazzo Giustiniani (la strada ha cambiato nome, e oggi si chiama via della Dogana vecchia). L'indirizzo «Via del Governo» compare nell'avviso a stampa della pubblica asta «di quadri antichi appartenenti alla Galleria dell'ecc.mo Patrimonio Giustiniani», datato 13 aprile 1859.
Dunque è fuor di dubbio che questo quadro provenga direttamente dall'antica collezione dei Giustiniani. Ma dopo aver descritto il percorso documentario, vorrei parlare del dipinto, quale esso ci appare, dopo una pulitura resa necessaria da ossidazioni e da una patina scura che velava la superficie. Questa velatura mi fece sospettare che ci fosse lo zampino di Margherita Bernini, una restauratrice che – presentata dal pittore Pietro Angeletti, autore dell'inventario della collezione Giustiniani del 1793 – attorno al 1788 aveva trattato molti quadri della collezione Giustiniani con quella che lei chiamava la «magica manteca», ossia un beverone a base di chiara d'uovo da spennellare sulla tela, che lasciava una traccia non priva di colature e che sarebbe assai ingiallita negli anni. Il 1788 era il momento della polemica condotta da Filippo Hackert sul «Giornale delle Belle Arti» contro l'uso della vernice sulle pitture, e in quell'occasione la Bernini fece i suoi esperimenti. Il suo "trattamento" l'avevo già rilevato, ad esempio, nella serie degli Apostoli di Francesco Albani, proveniente dalla collezione Giustiniani (che ritrovai nella Moritzkirche di Naumburg, lì esiliati da Wilhelm von Bode, direttore dei Musei di Berlino), e quindi mi saltò immediatamente agli occhi nell'atto di esaminare il S. Agostino prima della sua pulitura. Le radiografie e riflettografie, eseguite nel 2010 dallo Hamilton Kerr Institute di Cambridge, hanno altresì rivelato numerosi, piccoli pentimenti, fra cui uno assai tipico di Caravaggio, lo spostamento dell'orecchio di un centimetro più a sinistra. Si nota la tecnica di Caravaggio nel lasciar affiorare la preparazione bruna fra campiture di colore diverse, come scrive il Bellori: «Lasciò in mezze tinte l'imprimitura della tela». Il restauro ci ha restituito dei colori delicatissimi, caratteristici delle opere del Merisi anteriori al 1600, un'estrema precisione nelle masse e nei contorni e una sapiente orchestrazione dei piani spaziali e dei valori ottici.
Passeggiando nei giardini del Quirinale, in occasione della celebrazione della ricorrenza del 2 giugno, rievocavo con il consigliere di Stato Damiano Nocilla, già segretario generale del Senato, il successo della mostra «Caravaggio e i Giustiniani» che si inaugurò nel gennaio 2001 a Palazzo Giustiniani con una coda di folla che arrivava fino al Pantheon. Io stessa, che avevo dedicato alle ricerche necessarie alcuni anni della mia vita, ero incredula e, certo, felice. Il padrone di casa era il presidente del Senato di allora, Nicola Mancino. L'esposizione riportava nella sede originaria capolavori dell'antica collezione Giustiniani dispersi in vari musei del mondo. La qualità delle opere riunite – e non mancarono le scoperte, come una statua di Michelangelo inedita nota solo attraverso le fonti – rivelava il gusto raffinato e colto di Benedetto e Vincenzo Giustiniani. Cercai di lasciar parlare i due collezionisti, e di ricostruire quella magica commistione, evidente nella prima e nella seconda stanza dei quadri antichi (descritte dagli inventari), fra artisti del '400 e del '500, e pittori viventi, scelti con estremo rigore qualitativo.
Michelangelo Merisi detto Caravaggio era ammesso interamente nell'Olimpo voluto e pensato dal marchese Vincenzo. I suoi dipinti sono elencati in questo prestigioso contesto: per i Giustiniani il maestro aveva dipinto capolavori come L'amore vincitore (Berlino, Gemälde Galerie) o L'incredulità di S. Tommaso (Potsdam, Bildergalerie von Sanssouci). I Caravaggio dei Giustiniani erano ben quindici, ma ce ne sono pervenuti solo cinque. Altri tre (S. Matteo con l'angelo, Cristo nell'orto, Fillide) sono stati distrutti (oppure sono spariti) a Berlino alla fine della Seconda guerra mondiale, e li conosciamo solo in fotografia. I rimanenti quadri sono un autentico chiodo fisso per noi studiosi: non muore mai la speranza che improvvisamente riaffiorino da qualche parte.
Oltre un anno fa, nel maggio 2010, mi venne sottoposto un dipinto inedito, raffigurante S. Agostino, emerso da una collezione privata spagnola. Mi resi conto che si trattava dell'opera di Caravaggio descritta negli inventari redatti personalmente da Vincenzo Giustiniani e trascritti dal notaio nel 1638: «Un quadro d'una mezza figura di Sant'Agostino depinto in tela alta palmi 5. e 1/2 e larga 4. 1/2 incirca di mano di Michelangelo da Caravaggio con sua cornice negra» conservato nella prima stanza dei quadri antichi. Questo quadro rimase nella collezione Giustiniani per secoli, menzionato in tutti gli inventari successivi fino alla vendita, avvenuta fra il 1857 e il 1862.
Sovente vengono compiute attribuzioni e identificazioni attraverso il confronto con inventari di antiche collezioni. Ma il nesso è spesso molto aleatorio. Non in questo caso. Un'etichetta in pergamena posta sul retro del telaio costituisce una connessione inequivocabile. La scritta su di essa non era di immediata comprensione, ma per fortuna il secondo dei tre volumi da me pubblicati nel 2003 presso Einaudi, contenenti tutti gli inventari della collezione e redatti in varie epoche, mi ha offerto la spiegazione. Le parole scritte sull'etichetta forse dalla mano del collezionista spagnolo che acquistò il S. Agostino sono precisamente queste: «Procedencia del Marqués Recanelli en la calle del gobierno». Si tratta del marchese Pantaleo Vincenzo Giustiniani Recanelli, il quale nel 1857 era divenuto, dopo una lunga causa, l'erede legale dei resti della collezione Giustiniani (la parte maggiore era già stata venduta nel 1815 al re di Prussia) e si era insediato nell'antico palazzo. Il termine spagnolo «calle del gobierno» è la traduzione di Via del Governo, ossia l'indirizzo di allora (al n. 38) di Palazzo Giustiniani (la strada ha cambiato nome, e oggi si chiama via della Dogana vecchia). L'indirizzo «Via del Governo» compare nell'avviso a stampa della pubblica asta «di quadri antichi appartenenti alla Galleria dell'ecc.mo Patrimonio Giustiniani», datato 13 aprile 1859.
Dunque è fuor di dubbio che questo quadro provenga direttamente dall'antica collezione dei Giustiniani. Ma dopo aver descritto il percorso documentario, vorrei parlare del dipinto, quale esso ci appare, dopo una pulitura resa necessaria da ossidazioni e da una patina scura che velava la superficie. Questa velatura mi fece sospettare che ci fosse lo zampino di Margherita Bernini, una restauratrice che – presentata dal pittore Pietro Angeletti, autore dell'inventario della collezione Giustiniani del 1793 – attorno al 1788 aveva trattato molti quadri della collezione Giustiniani con quella che lei chiamava la «magica manteca», ossia un beverone a base di chiara d'uovo da spennellare sulla tela, che lasciava una traccia non priva di colature e che sarebbe assai ingiallita negli anni. Il 1788 era il momento della polemica condotta da Filippo Hackert sul «Giornale delle Belle Arti» contro l'uso della vernice sulle pitture, e in quell'occasione la Bernini fece i suoi esperimenti. Il suo "trattamento" l'avevo già rilevato, ad esempio, nella serie degli Apostoli di Francesco Albani, proveniente dalla collezione Giustiniani (che ritrovai nella Moritzkirche di Naumburg, lì esiliati da Wilhelm von Bode, direttore dei Musei di Berlino), e quindi mi saltò immediatamente agli occhi nell'atto di esaminare il S. Agostino prima della sua pulitura. Le radiografie e riflettografie, eseguite nel 2010 dallo Hamilton Kerr Institute di Cambridge, hanno altresì rivelato numerosi, piccoli pentimenti, fra cui uno assai tipico di Caravaggio, lo spostamento dell'orecchio di un centimetro più a sinistra. Si nota la tecnica di Caravaggio nel lasciar affiorare la preparazione bruna fra campiture di colore diverse, come scrive il Bellori: «Lasciò in mezze tinte l'imprimitura della tela». Il restauro ci ha restituito dei colori delicatissimi, caratteristici delle opere del Merisi anteriori al 1600, un'estrema precisione nelle masse e nei contorni e una sapiente orchestrazione dei piani spaziali e dei valori ottici.
Troppe cose non vanno in quel "Sant'Agostino". Lo dicono i documenti (di Andrea Dusio "Il Giornale" 14 giugno 2011)
Ogni quattro mesi spunta un nuovo quadro di Merisi. Quasi mai con le carte in regola. Come in questo caso. Il dipinto scoperto in Spagna faceva "pendant" con un San Gerolamo.
Era dal 28 settembre dell’anno scorso
(2010) che esperti ed appassionati del Caravaggio attendevano di vedere il Sant’Agostino scoperto in collezione privata spagnola dalla professoressa Silvia Danesi Squarzina. La storica dell’arte ne aveva parlato alla Galleria Borghese, alludendo a un legame dell’inedito con la Collezione Giustiniani. E tutti, sapendo che proprio la pubblicazione per Einaudi degli inventari della famiglia di origine genovese è l’opera che ha occupato tanti anni della vita della studiosa, hanno pensato, ancor prima di vedere il dipinto, che la nuova attribuzione fosse inattaccabile. Ora che l’immagine è stata resa nota, e con essa la debolezza e la qualità incerta del quadro (rimarcata ieri su queste pagine da Vittorio Sgarbi), occorre riprendere in mano i documenti, che ci raccontano alcune cose che la Danesi Squarzina si è curiosamente dimenticata di riportare.
È vero che un Sant’Agostino compare nell’inventario del marchese Giustiniani del 1638. Per la precisione, viene annotata la presenza di «Un quadro d’una mezza figura di Sant’Agostino depinto in tela alta palmi 5.1/2. Larga 4.1/2 in circa (di mano di Michelangelo da Caravaggio) con sua cornice negra». Subito dopo però viene citato: «Un altro quadro Simile di mezza figura di San Girolamo dipinto in tela alta palmi 5.1/2. Larga 4.1/2 in circa (di mano di Michelangelo da Caravaggio) con sua cornice negra». Le due descrizioni sono perciò identiche, per misura, autore, supporto e persino impaginazione (mezza figura). È allora il caso di soffermarsi sul senso di quel «Simile». Il suo significato non rimanda a una somiglianza generica, ma alla presenza di due opere che costituiscono un pendant, ossia una coppia di opere di identica fattura e formato, commissionate assieme. Tanto più se, come sostiene la Danesi Squarzina, a compilare una prima stesura dell’inventario è stato in prima persona Vincenzo Giustiniani, raffinatissimo collezionista, che arrivò (record assoluto) a possedere certamente più di dieci opere di Caravaggio, e che non avrebbe mai potuto scambiare per una coppia due dipinti che avessero solo una qualche somiglianza.
Se è vero infatti che il presunto Sant’Agostino riemerge solo adesso, il San Gerolamo è stato identificato nel 1974 da Maurizio Marini in un dipinto conservato nel museo del monastero catalano di Montserrat. Il problema è che i due quadri in questione non costituiscono affatto una coppia. Sulle dimensioni potremmo anche esserci, perché il Sant’Agostino misura 120x99, mentre il San Gerolamo è 118x81, però potrebbe essere stato decurtato. Ma la tela di Montserrat è una sorta di punto mediano tra il San Giovanni Battista di Kansas City, di cui riprende la postura, e il San Gerolamo della Galleria Borghese, due dipinti collocati unanimemente dalla critica nel 1605. Il Sant’Agostino invece, se mai fosse di Caravaggio, per questioni stilistiche non potrebbe superare il 1600, come ammette la stessa Danesi Squarzina. Che razza di pendant sarebbe allora, quello composto da due dipinti di epoca diversa, in cui la postura dei personaggi è differente, e differenti sono gli attributi (Sant’Agostino ha a lato il cappello cardinalizio, San Girolamo no, l’uno ha i libri e l'altro è senza Vulgata)? E che dire poi, per tornare allo stile, dell’incompatibilità della tavolozza, del modellato, della resa prospettica, e soprattutto del trattamento della luce? Con tutta evidenza uno dei due quadri è un «intruso». Ma il San Gerolamo, proprio per la sua evidente tangenza alle opere certe dell’ultimo periodo romano del Caravaggio, resta infinitamente più convincente.
Naufraga così l’ennesimo tentativo di arricchire il catalogo del Merisi, in nome di quella Caravaggite imperante che, in presenza di due o tre elementi fissi (la luce che piove in un ambiente buio e disadorno, i tratti veristi dei personaggi, una vaga compatibilità con la tecnica dei suoi seguaci) vede spuntare nuovi presunti autografi ogni tre/quattro mesi, molto spesso sostenuti da firme di grandi studiosi. Ciascun esperto di Caravaggio ha ormai almeno un dipinto a suo dire assolutamente autentico, che tutti gli altri in pubblico - noblesse oblige - approvano, salvo poi smentire seccamente se interrogati in separata sede. La realtà è che, al di là degli entusiasmi domenicali, le «belle scoperte» latitano. E a ingrossarsi è solo il numero delle cantonate accademiche.
Sant’ Agostino: secondo Vittorio Sgarbi non si tratta di un Caravaggio
È stato ritrovato lo scorso anno(sebbene presunte certezze circa l’autenticità dell’opera siano giunte solo ora), all’interno di una collezione privata, un quadro che potrebbe benissimo essere stato dipinto dalla mano di Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio. La professoressa universitaria e storica d’arte Silvia Danesi Squarzina parla con entusiasmo di tale opera, che raffigurerebbe Sant’Agostino. La donna ha raccontato su Il Sole 24 Ore della propria esperienza con tale meraviglioso dipinto. La critica d’arte parla del quadro come si parlerebbe d’un uomo che si ama: dice di essersi resa conto subito del fatto che si trattasse di un Caravaggio. Come fece? Ricordò che il Marchese e collezionista d’arte Vincenzo Giustiniani, aveva annotato all’interno dei propri inventari alcune informazioni circa “Un quadro d'una mezza figura di Sant'Agostino depinto in tela alta palmi 5. e 1/2 e larga 4. 1/2 incirca di mano di Michelangelo da Caravaggio con sua cornice negra”.
Silvia Danesi Squarzina non si è fermata a tale informazione per tentare di capire se si trattasse, effettivamente, di un Caravaggio. Varie ricerche sono state compiute sull’opera al fine di valutarne autore e provenienza. Un’etichetta in pergamena, rinvenuta sul retro del telaio, ha fatto sì che l’opera potesse essere direttamente ricondotta alla collezione Giustiniani e che, quindi, l’ipotesi della storica dell’arte acquisisse ancor più validità. Le radiografie e le riflettografie dello scorso anno hanno contribuito a rinfocolare l’ipotesi di Silvia Danesi Squarzina; anche il restauro ha messo in luce elementi tipici del Caravaggio. Il confronto con altre opere del Caravaggio, oltre che il ritrovamento all’interno di quest’opera di elementi simili a quelli rinvenibili in celebri dipinti del Merisi, sono stati fatti decisivi per stabilire se si trattasse o meno di un quadro “d’autore”. Si suppone che l’opera sia databile prima del milleseicento.
Le argomentazioni portate da Silvia Danesi Squarzina, al fine di dimostrare l’autenticità dell’opera, hanno convinto molti, ma non Vittorio Sgarbi. Secondo lui si tratta di un quadro troppo moscio e privo d’energia per essere del Caravaggio. Vittorio Sgarbi ha parlato di una “bufala”: << Dall’ambientazione in una biblioteca al cappello cardinalizio, al volto pateticamente inespressivo, tutto nel dipinto parla di un pittore molto diverso da Caravaggio e operoso alcuni decenni dopo.>>, scrive il critico d’arte. Che ne è di tutte le prove portate dalla Danesi Squarzina? A parere di Sgarbi si tratta di suggestive coincidenze. Anche le dimensioni del quadro non corrispondo, a suo parere, a quelle specificate da Vincenzo Giustiniani. Vittorio Sgarbi propone, sul Giornale, di chiamare in causa esperti del settore, certo che ci saranno sorprese per Silvia Danesi Squarzina. È difficile stabilire da che parte di trovi la ragione, ma bisogna dire che l’idea di un dibattito non sembra essere del tutto malvagia.
I documenti, le prove e chi parla senza aver visto la tela di Marco Carminati e Silvia Danesi Squarzina
(Il Sole24ore 14 giugno 2011)
Abbiamo gettato il sasso nello stagno e Vittorio Sgarbi lo ha colto al volo. È impossibile non condividere quanto scrive il critico d'arte sulle pagine de «Il Giornale» sull'importanza che l'inserto domenicale del Sole 24 Ore riveste per gli storici dell'arte. Si tratta di una sede la cui obiettività e serietà non sono mai state discusse e – di solito – chi viene ospitato (assumendosi la responsabilità delle proprie proposte) è spesso grato e onorato di farlo.
Veniamo ai fatti. Un importante dipinto raffigurante «Sant'Agostino», accompagnato da impressionanti dati documentari che lo attribuiscono a Caravaggio e lo dicono proveniente dalla Collezione Giustiniani di Roma sta per essere presentato in una grande mostra alla National Gallery di Ottawa, curata da rinomati studiosi come David Franklin e Sebastian Schütze (autore, quest'ultimo, di una recente applauditissima monografia su Caravaggio). Nel catalogo di Ottawa il commento al «Sant'Agostino» è stato affidato a Francesca Cappelletti, non solo autrice di importantissime scoperte sul Merisi (trovò a Recanati i documenti di pagamento della «Cattura di Cristo» di Dublino) ma anche autrice di un'incisiva monografia. La studiosa – tra le poche che hanno potuto vedere e rivedere il quadro – non ha dubbi: si tratta di un quadro problematico ma che ha tutte le carte in regola per essere assimilato al catalogo di Caravaggio.
Quest'opera è partita per Ottawa senza essere stata analizzata in Italia. Quindi, ben venga la discussione che si apre. Non studiare un quadro così solidamente documentato sarebbe la vera bufala. Ci permettiamo di invitare sin d'ora Vittorio Sgarbi, e altri eminenti studiosi di Caravaggio, a vedere di persona il dipinto a Ottawa, oppure di attendere con pazienza sino a novembre. La soprintendente Rossella Vodret - che ha esaminato a fondo il dipinto e ne condivide l'attribuzione - esporrà il quadro nella capitale nell'ambito della mostra su «Caravaggio e Roma», programmata a Palazzo Venezia. In quell'occasione verrà organizzato attorno al quadro in questione un convegno di due giorni, dove tutti gli studiosi più accreditati saranno chiamati a visionare il dipinto e a dare il loro parere.
Gli storici dell'arte potranno liberamente e costruttivamente confrontarsi, portando elementi di discussione sui primi anni romani di Caravaggio che – è bene sottolineare - nessuno conosce ancora in modo adeguato.
L'opinione espressa ieri da Vittorio Sgarbi - conoscitore stimato – stupisce perché ha il grave difetto di essere pronunciata in totale assenza dell'opera. Sgarbi parla senza aver visto il quadro, basandosi sulla foto riprodotta sul giornale: strano per un professionista come lui. Giustamente l'amico Vittorio cita Roberto Longhi, che riteneva l'opera d'arte il primo essenziale documento, e che, si badi bene, metteva in guardia i suoi giovani allievi dall'uso ottuso delle fotografie, in quanto la pittura va guardata sempre al vero, da vicino e da lontano, ma sull'originale.
La verità è che pochi sono oggi i veri conoscitori. Una personalità straordinaria, capace di trasmettere veri insegnamenti alle nuove generazioni è Mina Gregori. Ebbene, la professoressa Gregori, interpellata, ha risposto con pacata saggezza: «Ho visto il dipinto in fretta e non l'ho studiato abbastanza. Prima devo studiarlo. Certo è che le notizie documentarie emerse sono interessantissime e promettenti».
Ecco, abbiamo voluto offrire notizie «interessantissime e promettenti» che contengono dati incontrovertibili: le misure del quadro corrispondono perfettamente a quelle in palmi romani, gli inventari Giustiniani sono stati redatti personalmente da un grande conoscitore e collezionista quale era il marchese Vincenzo e possediamo il quadernetto con le annotazioni di suo pugno. Gli acquisti sono stati fatti da lui, e se scrive che il "Sant'Agostino" è di Caravaggio avrà avuto qualche buona ragione. Pensiamoci bene prima di smentirlo.
Questi sono fatti. Poi, abbiamo espresso anche l'opinione che il dipinto è splendido, con una chiave espressiva molto misurata, quasi in sottotono, ma con particolari estremamente legati alla prima fase di Caravaggio, quella che conosciamo meno ma che potremo finalmente comprendere e ricostruire alla luce anche dei molti nuovi dati emersi nella recente mostra dell'Archivio di Stato attorno ai documenti di Caravaggio.
Molti non sono d'accordo. Non è d'accordo, ad esempio, Maurizio Calvesi, che ha visto il dipinto al computer traendone un'impressione sfavorevole. Molti altri sono, invece, favorevoli. Citiamo solo Vincenzo Pacelli (lo scopritore del Martirio di S. Orsola di Caravaggio) e Anna Lo Bianco, direttrice di Palazzo Barberini, la quale ha apprezzato gli aspetti documentari. Poi, ci sono le analisi tecniche. Non solo lo Studio Hamilton Kerr di Cambridge, ma anche specialisti italiani della diagnostica artistica come Claudio Falcucci hanno riscontrato elementi molto significativi che fanno attribuire il dipinto a Caravaggio. In particolare, sarà rilevante il parere di Marco Cardinali e Maria Beatrice De Ruggieri perché sotto la direzione della soprintendente Vodret hanno da poco completato esami diagnostici molto approfonditi di ben 22 opere autografe di Caravaggio.
C'è molto rispetto delle opinioni diverse, e proprio per questo ci auguriamo che tutti possano parlare e discutere davanti al dipinto originale e alla luce dei dati (incontrovertibili) sinora emersi. Questo è un «quadro da stanza», le palpebre del santo sono abbassate per esprimere un'interiorità e una concentrazione ineffabili, i dettagli degli oggetti sul tavolo, l'uso della luce e delle ombre sono anch'essi elementi da valutare con attenzione. Il tipo di pentimenti, il risparmio della preparazione, il tipo di tela, vanno messi sulla bilancia. Non si può parlare così superficialmente di «bufala». Sgarbi può stare tranquillo: è solo una nuova proposta, ben documentata, che il Sole 24 Ore ha offerto tempestivamente. Tutto qui.
Un incredibile Caravaggio
Quell'opera potrebbe essere del Cavarozzi che realizzò un quadro analogo nel 1631
(Maurizio Marini - Il Tempo 16 giugno 2011)
La montagna ha partorito un altro topolino, a distanza di un anno dal 18 luglio 2010, che, nel giorno della ricorrenza del quarto centenario della morte del Caravaggio, in Porto Ercole, aveva visto il tentativo d'introdurre quale suo inedito capolavoro un "Martirio di san Lorenzo", rivelatosi un dipinto d'attribuzione incerta, tra Tommaso Salini e Juan Bautista Majno. A distanza di un anno, dicevo, abbiamo a che fare con un altro topolino. Un ennesimo Caravaggio, peraltro corredato da crismi filologici, universitari e scientifici. L'annuncio della "scoperta" della prof.ssa Silvia Danesi Squarzina (docente presso l'università di Roma) è stato dato trionfalisticamente dall'inserto "Domenica" del "Sole/24 Ore": "Guardate c'è un nuovo Caravaggio", "Scoperto in una collezione privata spagnola il Sant'Agostino che Michelangelo Merisi realizzò per il marchese Vincenzo Giustiniani. Sempre citato dalle fonti, il quadro era sparito nell'Ottocento". In queste poche righe ci sono già alcune inesattezze (al di là dell'attribuzione che già a uno sguardo superficiale risultava inverosimile): per quanto riguarda il dipinto in oggetto non ha una recente provenienza spagnola, bensì inglese; che sia stato commissionato direttamente al Caravaggio dal marchese Giustiniani non trova supporto in nessuna prova filologica, al pari della sua citazione nelle "fonti", certamente non in quelle biografiche canoniche (Mancini, Baglione, Bellori). Forse, ma non è certo che l'opera sia quella, negli inventari delle raccolte Giustiniani redatti da notai e relativi assistenti in occasione della morte dei relativi proprietari. Quindi, alquanto approssimativi, circa le attribuzioni, se non riportabili a date limitrofe all'esecuzione delle opere stesse (donde se ne era mantenuta in memoria), o della scomparsa dell'autore. Nel caso del Caravaggio si presumono utili gl'inventari databili all'incirca entro la metà del Seicento. Il 1638, data in cui apparirebbe il "Sant'Agostino" Giustiniani può essere considerata valida: "Nella stanza Grande de' Quadri Antichi", al n°4 "Un quadro di una mezza figura di S. Agostino dipinto in tela alto pal.5 larg.4 in circa di mano di Michelang.o da Caravaggio con sua cornice nera". La Danesi Squarzina, studiosa degl'inventari Giustiniani e, come detto, sostenitrice dell'autografia del "Sant'Agostino" in questione, ne riporta le misure pari a cm 120x99, alquanto vicine rispetto a quelle, in palmi romani (pari a cm 22,34) dell'inventario: vale a dire cm 122,87x100,53. Nondimeno, al di là di tutti i riferimenti filologici, l'ultimo e unico documento è l'opera stessa che, nel caso in esame, non è credibile quale originale del Caravaggio. L'opera è di buona qualità e presenta valenze stilistiche peculiari degli artisti, attivi a Roma, aderenti alla rivoluzione della "pittura secondo natura", chiaroscurata e drammatica, del Caravaggio. Il "manifesto" reca la data dell'anno giubilare 1600, col "ciclo di San Matteo" in San Luigi dei Francesi. La pretesa che vorrebbe tale commissione supportata dai fratelli Giustiniani, il cardinale Benedetto e il marchese Vincenzo, è un clamoroso falso storico. L'appoggio del primo, potente, patrocinatore del Caravaggio, il filofrancese cadinal Francesco Maria Bourbon del Monte, è indubbio, mentre inverosimile (oltreché indimostrabile) quello dei fratelli Giustiniani, accaniti filospagnoli(!). Il "Sant'Agostino" presenta molti caratteri tecnici affini a quelli del Caravaggio, ma la maggior parte gli è estranea: un eccesso d'elementi secondari (quali la libreria nello sfondo) invade la composizione, mentre la mitria vescovile esula dalla sua visione (Caravaggio esclude in prevalenza gli attributi), mentre la trama luministica non appare affatto determinante per la struttura dell'immagine della narrazione che orecchia originali come il "San Gerolamo scrivente", della romana Galleria Borghese, senza che se ne percepisca lo stacco acronico tra l'immanente presenza del protagonista e la dilatazione del suo gesto nello spazio illusorio. Come detto la fede politica filospagnola dei Giustiniani ne giustifica la dimestichezza con artisti di tale area: dal Caravaggio, suddito del feudo iberico di Lombardia, al Ribera nei suoi giorni romani (ma certamente non si tratta del pittore cui si è attribuita una vera è propria antologia di quadri eterogenei, a partire dal "Giudizio di Salomone" della Borghese agli "apostoli" di Casa Gavaotti). Anche l'autore del "Sant'Agostino" è legato ai filoiberici marchesi Crescenzi e rientra in questa categoria. Si tratta, a mio avviso, del viterbese Bartolomeo Cavarozzi (Viterbo, 1590 c / Roma, 1625), a lungo attivo in Spagna, al seguito del marchese Crescenzi che svolgeva incarichi d'architetto per re Filippo III. I riscontri tecnici col primo Caravaggio (specie se mediati dalla raffinata estetica di Orazio Gentileschi), sono inequivocabili e ciò coincide coi "pentimenti" e quant'altro evidenziato dalle indagini radiografiche. Il Cavarozzi dipinge, inoltre, per la corte granducale fiorentina. Ricordo il "San Gerolamo scrivente con due angeli" (Firenze, Depositi delle Gallerie) compresa la replica autografa, con minime varianti, in collezione privata, di Cesare Dandini, che realizza entrambe nel 1631, per Don Lorenzo de' Medici, il quale le destina alla Villa della Petraia.
Il walzer dei quasi Caravaggio
(Robe da chiodi)
«D’altro canto, in un’epoca di pensiero debole come quella che stiamo attraversando, la sfiducia nelle capacità umane è all’ordine del giorno in ogni campo, e non ci si può troppo stupire che la storia dell’arte, in quanto disciplina umanistica, non sia stata risparmiata». Così scrive Cristina Terzaghi, una delle più autorevoli conoscitrici di Caravaggio in un articolo recente, Caravaggio 2010, pubblicato su Studiolo (n. 8), la rivista dell’Académie de France di Roma. L’articolo è un utile riepilogo ragionato delle tante novità emerse in occasione della sarabanda di libri e mostre per il centenario.
Quel pensiero calza alla perfezione anche per l’ultima novità di cui si è tanto parlato in questi giorni dopo al pubblicazione molto gridata sull’ultimo domenicale del Sole. Il quadro, per i pochi che ancora non lo sapessero, è un Sant’Agostino di provenienza Giustiniani, e inventariato come Caravaggio nel 1638. A seguire i documenti sembra che davvero che tutto torni: spostamenti tracciabili, antica etichetta sul retro che riporta a un erede Giustiniani. Addirittura, nota l’autrice della scoperta Silvia Danesi Squarzina, il calamaio è dello stesso tipo di quello che appare nella Vocazione di Matteo. C’è solo un documento che non convince molto, ma a quanto pare non sembra così importante: il quadro. Così almeno hanno detto senza mezzi termini due studiosi su posizioni culturali opposte come Vittorio Sgarbi e Tomaso Montanari (rispettivamente sul Giornale e sul Fatto).
Sulla questione non ho voce in capitolo: ammetto di aver rinunciato a fare lo storico d’arte quando ho capito di non avere “occhio”: ho scelto altre strade di cui sono contento, tenendo la storia dell’arte come attività libera e molto liberante. Tuttavia anche il mio occhio balbettante, davanti a quel Sant’Agostino s’è bloccato. Specie quando è stata proposta l’idea che dovesse essere il pendant di un altro Caravaggio Giustiniani, il San Gerolamo oggi a Montserrat. D’istinto mi è apparso chiaro che quelle due immagini non potessero essere state pensate dallo stesso cervello: il San Gerolamo («quintessenzialmene caravaggesco», lo definisce Montanari) ha un’essenzialità e una drasticità che manca in modo assoluto nel Sant’Agostino, un po’ traballante e annacquato in una mess’in scena volonterosa ma affastellata. Due mondi che non hanno punti di contatto, aldilà di tutte le possibili affinità stilistiche. Questo dice il mio occhio “balbettante”.
Ma a parte questa osservazione istintiva ed estemporanea, resta il fatto che le opere sembrano non “parlare” più. Come scrive Cristina Terzaghi, «sembra serpeggiare una sorta di abdicazione della storia dell’arte alla “gaia” scienza».
Forse è un Caravaggio, forse era a Londra. Di certo è una bufala (di Andrea Dusio)
"Guardian" il Sant’Agostino attribuito al Merisi proviene dall’Inghilterra. Ma non si trovava in Spagna? Stranezza: per alcuni critici è così diversa dalle altre opere del maestro... che può essere vera
La vicenda del Sant’Agostino assegnato a Caravaggio da Silvia Danesi Squarzina la settimana scorsa (sul «Domenicale » del Sole 24Ore ) si arricchisce di un nuovo capitolo, scritto dal Guardian di ieri. Il dipinto che la storica dell’arte romana aveva dichiarato provenire da una collezione privata spagnola era in realtà, come aveva già spiegato Maurizio Marini, conservato in una quadreria britannica. In attesa di capire il perché di questa divergenza, registriamo che, primadegli articoli di Vittorio Sgarbi e del sottoscritto sul Giornale , mirati a smontare l’attribuzione rispettivamente sotto il profi-lostilisticoedocumentario, latela era stata scoperta (secondo quanto riporta il quotidiano londinese) di un celebre dealer di Mayfair, Clovis Whitfield, proprietario di una nota galleria d’arte in Dering Street.
Per chi ama le vicende degli antiquari dotati di un fiuto eccezionale, e capaci di intuizioni fulminanti, quali il fiorentino Corsini e le sue proverbiali attribuzioni a Tiziano, Clovis Whitfield rappresenta una sorta di pietra di paragone. C’è chi considera alcune sue idee geniali, altri invece le rubrica nel novero delle cantonate. Di certo Whitfield è uno dei più appassionati cacciatori di succulenti Caravaggio novelli. In questo caso Whitfield sembrerebbe essere il prime mover , avendo segnalato come possibile autografa l’opera già prima del restauro. E se in Italia il dipinto ha incassato soprattutto dei secchi no (tra gli altri, quelli del già citato Marini, di Tomaso Montanari, di Nicola Spinosa, Keith Sciberra e Ferdinando Bologna) all’estero sembra aver trovato più di un consenso. Per esempio quello di Sebastian Schütze,professore di storia dell’arte all’Università di Vienna. Il quale dichiara: «Non è mai stato pubblicato. Quello che sembrava il lavoro di un anonimo del XVII secolo ha rivelato le sue qualità artistiche dopo il restauro ». Il che comunque non è come dire «Si tratta di Caravaggio ».Né d’altronde alle nostre latitudini nessuno s’è sognato di liquidarlo come una crosta, visto che in molti hanno speso il nome del raffinato caravaggista di seconda generazione Bartolomeo Cavarozzi ( e su questa sorprendente concordia nell’attribuzione a un maestro così poco conosciuto ci sarebbe a sua volta da fare qualche congettura, visto che in giro ci sono almeno un paio di dipinti assegnati al Merisi che invece sono da ricondurre al pittore viterbese).
Anche David Franklin, direttore del Cleveland Museum of Art, ha offerto il suo parere, giudicando la scoperta importante perché totalmente inedita: «Anche la composizione non è registrata in altre copie. Spesso un originale perduto è conosciuto proprio attraverso le copie, ma non questo. Quel che è interessante è che si tratta di un immagine piuttosto tradizionale. Forse è per questo che non è stato riconosciuto sino a oggi. Ci mostra un Caravaggio non così brutale e controcorrente come suo solito, forse perché in questo caso può aver lavorato fianco a fianco col Giustiniani per creare un’immagine di santo più aderente all’iconografia ». È curioso questo ragionamento di Franklin. Il Sant’Agostino è insomma un Caravaggio tanto più interessante perché non sembra Caravaggio. È un po’ più bigotto, meno brillante nella composizione, e curiosamente non se ne conoscono copie antiche, al contrario della grandissima parte delle opere del maestro. Non ha quasi nulla insomma di Caravaggio, ma visto che con tanta evidenza lo è, è ancor più stupefacente. Il dipinto, che, stando sempre al Guardian , è rimasto nella Collezione Giustiniani sino alla metà del XIX secolo, verrà pubblicato a luglio in un testo dedicato a Caravaggio e i suoi seguaci romani, a cura dell’Università di Yale, in associazione con la National Gallery del Canada. E in effetti l’inedito è esposto a partire da questi giorni a Ottawa. Ancora Silvia Danesi Squarzina raccomanda caldamente di vederlo di persona, prima di pronunciarsi, come avrebbe fatto il grande Roberto Longhi.
Certo lo storico dell’arte albese avrebbefatto un po’ di fatica nel considerare una prova certa che si tratta di un Caravaggio autentico il fatto che sia citato nelle fonti, e in particolare nell’«Inventario Giustiniani del 1638», a dire della Squarzina il più preciso, perché mutuato degli appunti presi direttamente dal marchese Vincenzo, mecenate e collezionista sommo del Merisi. Che è un po’ come affermare che le reliquie dei santi sono autentiche perché corrispondono in linea di massima alla descrizione che ne viene fatta nelle Scritture. Quale sia il rapporto, evidentemente di natura mistica, che intercorre tra l’opera e il documento, non è dato capirlo. Forse un cartiglio, che rimanda alla collocazione in uno dei palazzi in cui era conservata la collezione Giustiniani, senza alcuna indicazione peraltro né dell’autore né dell’epoca. Dopo il presumibile bagno di folla in Nord America,l’opera figurerà nella mostra «Roma al tempo del Caravaggio», in programma a novembre a Palazzo Venezia. In attesa delle forche capitoline, potrà ballare almeno un’estate. Da parte nostra auspichiamo che in quella sede, e nel simposio di studi che seguirà, sia esposta unitamente a quello che dovremmo considerare il suo «pendant mancato» o il suo«gemello diverso».Una tela, questa sì al 99% di Caravaggio, raffigurante San Gerolamo, conservata nel monastero di Montserrat, e che compare nell’Inventario Giustiniani con le stesse dimensioni e caratteristiche del Sant’Agostino ( le due tele costituivano una coppia).
Ma chi ha visto le loro foto affiancate non ha potuto che esclamare, come Johnny Stecchino, «Non le somiglia per niente!». Il fatto è che anche in questo secondo caso l’associazione tra il dipinto e il documento è del tutto arbitraria, anche se più sensata.C’è insomma una questione di metodo, alla base di questo pasticcio. Ma come spiegarlo agli storici dell’arte?
Agostino, il Caravaggio ritrovato (Silvia Danesi Squarzina, Il Sole 24 ore del
12 giugno 2011)
Passeggiando nei giardini del Quirinale, in occasione della celebrazione della ricorrenza del 2 giugno, rievocavo con il consigliere di Stato Damiano Nocilla, già segretario generale del Senato, il successo della mostra «Caravaggio e i Giustiniani» che si inaugurò nel gennaio 2001 a Palazzo Giustiniani con una coda di folla che arrivava fino al Pantheon. Io stessa, che avevo dedicato alle ricerche necessarie alcuni anni della mia vita, ero incredula e, certo, felice. Il padrone di casa era il presidente del Senato di allora, Nicola Mancino. L'esposizione riportava nella sede originaria capolavori dell'antica collezione Giustiniani dispersi in vari musei del mondo. La qualità delle opere riunite – e non mancarono le scoperte, come una statua di Michelangelo inedita nota solo attraverso le fonti – rivelava il gusto raffinato e colto di Benedetto e Vincenzo Giustiniani. Cercai di lasciar parlare i due collezionisti, e di ricostruire quella magica commistione, evidente nella prima e nella seconda stanza dei quadri antichi (descritte dagli inventari), fra artisti del '400 e del '500, e pittori viventi, scelti con estremo rigore qualitativo.
Michelangelo Merisi detto Caravaggio era ammesso interamente nell'Olimpo voluto e pensato dal marchese Vincenzo. I suoi dipinti sono elencati in questo prestigioso contesto: per i Giustiniani il maestro aveva dipinto capolavori come L'amore vincitore (Berlino, Gemälde Galerie) o L'incredulità di S. Tommaso (Potsdam, Bildergalerie von Sanssouci). I Caravaggio dei Giustiniani erano ben quindici, ma ce ne sono pervenuti solo cinque. Altri tre (S. Matteo con l'angelo, Cristo nell'orto, Fillide) sono stati distrutti (oppure sono spariti) a Berlino alla fine della Seconda guerra mondiale, e li conosciamo solo in fotografia. I rimanenti quadri sono un autentico chiodo fisso per noi studiosi: non muore mai la speranza che improvvisamente riaffiorino da qualche parte.
Oltre un anno fa, nel maggio 2010, mi venne sottoposto un dipinto inedito, raffigurante S. Agostino, emerso da una collezione privata spagnola. Mi resi conto che si trattava dell'opera di Caravaggio descritta negli inventari redatti personalmente da Vincenzo Giustiniani e trascritti dal notaio nel 1638: «Un quadro d'una mezza figura di Sant'Agostino depinto in tela alta palmi 5. e 1/2 e larga 4. 1/2 incirca di mano di Michelangelo da Caravaggio con sua cornice negra» conservato nella prima stanza dei quadri antichi. Questo quadro rimase nella collezione Giustiniani per secoli, menzionato in tutti gli inventari successivi fino alla vendita, avvenuta fra il 1857 e il 1862.
Sovente vengono compiute attribuzioni e identificazioni attraverso il confronto con inventari di antiche collezioni. Ma il nesso è spesso molto aleatorio. Non in questo caso. Un'etichetta in pergamena posta sul retro del telaio costituisce una connessione inequivocabile. La scritta su di essa non era di immediata comprensione, ma per fortuna il secondo dei tre volumi da me pubblicati nel 2003 presso Einaudi, contenenti tutti gli inventari della collezione e redatti in varie epoche, mi ha offerto la spiegazione. Le parole scritte sull'etichetta forse dalla mano del collezionista spagnolo che acquistò il S. Agostino sono precisamente queste: «Procedencia del Marqués Recanelli en la calle del gobierno». Si tratta del marchese Pantaleo Vincenzo Giustiniani Recanelli, il quale nel 1857 era divenuto, dopo una lunga causa, l'erede legale dei resti della collezione Giustiniani (la parte maggiore era già stata venduta nel 1815 al re di Prussia) e si era insediato nell'antico palazzo. Il termine spagnolo «calle del gobierno» è la traduzione di Via del Governo, ossia l'indirizzo di allora (al n. 38) di Palazzo Giustiniani (la strada ha cambiato nome, e oggi si chiama via della Dogana vecchia). L'indirizzo «Via del Governo» compare nell'avviso a stampa della pubblica asta «di quadri antichi appartenenti alla Galleria dell'ecc.mo Patrimonio Giustiniani», datato 13 aprile 1859.
Dunque è fuor di dubbio che questo quadro provenga direttamente dall'antica collezione dei Giustiniani. Ma dopo aver descritto il percorso documentario, vorrei parlare del dipinto, quale esso ci appare, dopo una pulitura resa necessaria da ossidazioni e da una patina scura che velava la superficie. Questa velatura mi fece sospettare che ci fosse lo zampino di Margherita Bernini, una restauratrice che – presentata dal pittore Pietro Angeletti, autore dell'inventario della collezione Giustiniani del 1793 – attorno al 1788 aveva trattato molti quadri della collezione Giustiniani con quella che lei chiamava la «magica manteca», ossia un beverone a base di chiara d'uovo da spennellare sulla tela, che lasciava una traccia non priva di colature e che sarebbe assai ingiallita negli anni. Il 1788 era il momento della polemica condotta da Filippo Hackert sul «Giornale delle Belle Arti» contro l'uso della vernice sulle pitture, e in quell'occasione la Bernini fece i suoi esperimenti. Il suo "trattamento" l'avevo già rilevato, ad esempio, nella serie degli Apostoli di Francesco Albani, proveniente dalla collezione Giustiniani (che ritrovai nella Moritzkirche di Naumburg, lì esiliati da Wilhelm von Bode, direttore dei Musei di Berlino), e quindi mi saltò immediatamente agli occhi nell'atto di esaminare il S. Agostino prima della sua pulitura. Le radiografie e riflettografie, eseguite nel 2010 dallo Hamilton Kerr Institute di Cambridge, hanno altresì rivelato numerosi, piccoli pentimenti, fra cui uno assai tipico di Caravaggio, lo spostamento dell'orecchio di un centimetro più a sinistra. Si nota la tecnica di Caravaggio nel lasciar affiorare la preparazione bruna fra campiture di colore diverse, come scrive il Bellori: «Lasciò in mezze tinte l'imprimitura della tela». Il restauro ci ha restituito dei colori delicatissimi, caratteristici delle opere del Merisi anteriori al 1600, un'estrema precisione nelle masse e nei contorni e una sapiente orchestrazione dei piani spaziali e dei valori ottici.
Sant'Agostino processato
(Maria Cristina Terzaghi 26 febbraio 2012)
Rimandata a causa della neve che ha imbiancato Roma nelle scorse settimane, la giornata di studi dedicata al Sant'Agostino, si è finalmente celebrata sotto cieli più miti lunedì scorso, nella Sala Altoviti di Palazzo Venezia, a poca distanza dal dipinto. Ha promosso con grande fermezza l'evento il soprintendente al Polo Museale Romano, Rossella Vodret, ritenendo bene, dopo le accese polemiche scoppiate sui quotidiani a seguito dell'attribuzione dell'opera a Caravaggio, offrire alle parti in causa, e alla comunità scientifica tutta, l'occasione di ragionare più serenamente sulla tela. Un pubblico da stadio ha messo il Sant'Agostino al centro di un ring del quale vorrei qui ripercorrere le mosse, lasciando, se possibile, al lettore la valutazione dell'esito della gara.
Il primo colpo è stato sferrato da quella che risulta la pezza d'appoggio per l'attribuzione del Sant'Agostino a Caravaggio, vale a dire l'etichetta in pergamena che compare sul telaio dell'opera: «Procedencia del Marqués Recanelli en la calle del gobierno». Si tratta inequivocabilmente dell'attestazione della presenza della tela in Palazzo Giustiniani a Roma alla metà dell'Ottocento. In seguito a complesse vicende giudiziarie, il marchese Pantaleo Vincenzo Giustiniani Recanelli, fu infatti nominato erede della famiglia nel 1857. «Calle del gobierno», è in realtà l'antico nome di via della Dogana, dove si trova il palazzo e dove era collocata la celeberrima raccolta d'arte che Vincenzo Giustiniani mise insieme nei primi decenni del Seicento. Sul volantino di asta pubblica, indetta nel 1859 per alienare i beni della famiglia, si legge per l'appunto l'indirizzo «Via del Governo, n. 38». L'identificazione della collocazione ottocentesca della tela, del suo proprietario e del momento della sua dispersione, costituisce il notevole apporto offerto alla conoscenza dell'opera dalla più accreditata studiosa della raccolta romana, Silvia Danesi Squarzina. Sull'onda di questa intuizione, il 12 giugno 2011, su queste stesse colonne, la studiosa aveva espresso la convinzione che, risalendo a ritroso nella storia della collezione Giustiniani, la tela potesse essere identificata con la quarta opera collocata nella «stanza grande dei quadri antichi» del palazzo del marchese, registrata nel 1638 dall'inventario post mortem di Vincenzo: «4 Un quadro di una mezza figura di S. Agostino depinto in tela di imperatore alto palmi 5 ½ Larghezza 4 ½ in circa di mano di Michelangelo Caravaggio con sua Cornice negra». Le dimensioni della tela coincidevano infatti con quelle del Sant'Agostino ritrovato e, a giudizio della studiosa, l'inventario risulta pressoché infallibile nelle attribuzioni. L'opera appariva dunque alla Danesi Squarzina, uno dei quindici Caravaggio di proprietà del marchese Giustiniani, finalmente ritrovato in una collezione spagnola, da dove la tela passò a Londra, presso l'antiquario Clovis Whitfield, anch'egli relatore alla giornata di studi. La lettura storica proposta dalla studiosa ha in realtà incontrato un paio di obiezioni nel corso della giornata. La prima viene da un suggerimento di Alessandro Zuccari che, in assenza di un numero di inventario sull'etichetta ottocentesca, cifra che invece compariva nel 1638, ha ipotizzato che la tela potesse identificarsi con: «un santo in abito di nero pittura andante di autore incerto», registrato in un settecentesco inventario della famiglia Giustiniani. La seconda è stata sollevata da Kristina Hermann Fiore, che ha richiamato l'attenzione su un epigramma tardo seicentesco di Giovanni Michele Silos che descrive il Sant'Agostino menzionato nell'inventario del 1638 con parole che, tradotte in italiano, suonano: «Caravaggio, tu raddoppi l'energia del Santo: guerra minaccia con i suoi scritti, guerra spira ancora, pur raffigurato in un quadro», un'immagine bellicosa lontana dal placido santo in esame. Più conciliante pare invece la posizione della diagnostica, applicata alla tela per verificare la sua pertinenza al catalogo del Merisi. Il referto, unanimemente condiviso da Beatrice de Ruggeri, Marco Cardinali e Claudio Falcucci, è il seguente: la tecnica con cui è stato eseguito il Sant'Agostino è compatibile con quella delle opere realizzate da Caravaggio in un lasso di tempo molto ristretto, e cioè prima della cappella Contarelli (1599-1600). A ogni modo, i ricercatori hanno ripetutamente dichiarato che la campionatura delle opere seicentesche sottoposte a diagnosi è troppo ristretta per stabilire se questi parametri siano validi anche per tele dipinte a Roma da altri artisti seicenteschi. Di fatto si tratta di un semplice nulla osta all'attribuzione dell'opera al Merisi prima del 1600, una datazione che concorda peraltro con quella proposta dalla Danesi Squarzina. Sin qui poco male: la diagnostica non obietta, i documenti appaiono tutto sommato saldi, il Silos potrebbe essersi concesso qualche licenza poetica. Qualche ulteriore dubbio proviene però dal fronte iconografico. Il santo indossa infatti l'abito dell'Ordine eremitano, secondo una foggia che entrerà in voga solo a partire dal secondo decennio del Seicento, a causa delle controversie interne all'Ordine (lo hanno provato Alessandro Cosma e Gianni Pittiglio).
Ma la vera levata di scudi contro la tesi caravaggesca è però appannaggio dell'analisi stilistica. Il primo è stato Vittorio Sgarbi, già intervenuto sul tema in un articolo apparso su «Il Giornale» il giorno dopo l'attribuzione della tela da parte di Silvia Danesi Squarzina. Sgarbi ha sottolineato la scarsa pertinenza dell'ambientazione del dipinto, «una libreria mongiardinesca», alle opere caravaggesche, dove i santi si stagliano titanici, emergendo dall'ombra più fitta che inghiotte ogni cosa. Ha quindi obiettato che le mani del Sant'Agostino, «appena uscite dalla manicure», sono quanto di più lontano dalle callose mani dei personaggi di Caravaggio, quasi sempre corredate da unghie poco pulite. Nell'opera intera Sgarbi rileva poi un clima fiacco, molto distante dalla vitalità pulsante delle tele caravaggesche. La tela va insomma collocata ben più avanti nel tempo, intorno al quarto decennio del Seicento. Si è concentrata sulla pars construens Ursula Fischer Pace, proponendo una serrata serie di confronti con opere di Giacinto Gimignani, un artista originario di Pistoia e attivo a Roma a partire dal 1632, autore tra l'altro di un Sant'Ambrogio di dimensioni identiche al Sant'Agostino, che potrebbe aver costituito il secondo numero di una serie di quattro Dottori della Chiesa. A questo punto però il riferimento al numero 4 dell'inventario del 1638 sembrerebbe scricchiolare: come mai gli altri tre santi non erano registrati insieme a questo nella collezione del marchese? Si aprono piste per nuove ricerche.
Il falso Caravaggio che invece è vero: Nessun risarcimento all’erede della tela «I bari». Scambiata per una copia fu battuta all’asta per 55 mila euro da Sotheby’s: vale 13 milioni
(Fabio Cavalera)
 Vedersi sfilare dieci milioni di sterline, vale a dire quei 13 milioni di euro che vale l’olio su tela del Caravaggio dal titolo «I bari», è un brutto colpo. Ma il discendente di uno stimato chirurgo della Royal Navy, Lancelot William Thwaytes, un po’ se l’è andata a cercare. Quando hai in mano qualcosa che sospetti possa essere un tesoro sarebbe meglio ascoltare non dieci ma cento, e forse più, esperti prima di metterlo all’asta. Rientrarne poi in possesso è impossibile. Ed è pure impossibile, ciò hanno stabilito i giudici dell’Alta corte londinese, chiedere i danni a chi non è stato in grado di attribuire il capolavoro al suo grande, unico e vero maestro, Michelangelo Merisi.
Vedersi sfilare dieci milioni di sterline, vale a dire quei 13 milioni di euro che vale l’olio su tela del Caravaggio dal titolo «I bari», è un brutto colpo. Ma il discendente di uno stimato chirurgo della Royal Navy, Lancelot William Thwaytes, un po’ se l’è andata a cercare. Quando hai in mano qualcosa che sospetti possa essere un tesoro sarebbe meglio ascoltare non dieci ma cento, e forse più, esperti prima di metterlo all’asta. Rientrarne poi in possesso è impossibile. Ed è pure impossibile, ciò hanno stabilito i giudici dell’Alta corte londinese, chiedere i danni a chi non è stato in grado di attribuire il capolavoro al suo grande, unico e vero maestro, Michelangelo Merisi.
È un mezzo giallo. O una beffa catastrofica (per chi esce a pezzi dalla causa), con tanti protagonisti e con tanti critici ed esperti d’arte messi di mezzo. E ruota attorno al quadro di 94 centimetri per 131 che il Caravaggio dipinse nel 1594. Si pensava, fino a qualche tempo fa, che l’originale fosse in Texas al Kimbell Art Museum. Invece in Inghilterra al Museo dell’Ordine di San Giovanni, nella zona di Clerkenwell (gioiellino fuori dai circuiti turistici) ecco che compare, lasciatovi dal collezionista e storico Denis Mahon, lo splendido dipinto. E pensare che oltre mezzo secolo fa, nel 1962, la famiglia di Lancelot William Thwaytes l’aveva acquistato per 140 sterline: solo una crosta, bella ma uno scarto di magazzino. Come tale trattato fino al 2006 quando il suo legittimo proprietario, per l’appunto Mr. Lancelot, lo porta alla casa d’aste Sotheby’s. Che non sia proprio un’opera da buttare via è chiaro da subito. Sotheby’s chiede il conforto di stimati professori.
S’interpellano la biografa del Caravaggio, Helen Langdon, poi lo storico dell’arte americano Richard Spear. E il verdetto è che si tratta di una copia attribuibile alla scuola del Caravaggio ma non al Caravaggio stesso. Così la tela va all’asta. E con un risultato da non disprezzare visto che la si batte per 42 mila sterline (oggi 55 mila euro). Ma chi si aggiudica il quadro? Nominalmente è una signora, Orietta Adam. Dietro, però, il suggeritore e finanziatore è un uomo, Denis Mahon, che è fra i massimi collezionisti e storici dell’arte, specie del barocco. Ha collaborato con molti musei italiani. È proprietario di capolavori del Rinascimento. È lui che versa le 42 mila sterline e fa ripulire la tela. Ed è lui che toglie ogni dubbio: altro che copia, quelli sono «I bari» del Caravaggio. Valore dieci milioni di sterline, 13 milioni di euro.
Fulmine a ciel sereno per l’erede della «crosta», Mr. Lancelot William Thwaytes, che pensava di avere concluso un discreto affare con le 42 mila sterline. Che sia un Caravaggio non c’è dubbio (lo confermeranno anche Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani ed ex ministro dei Beni culturali, e Mina Gregori, accademica dei Lincei, la più importante studiosa del Caravaggio). Al povero e sprovveduto Lancelot non resta che una strada: la causa a Sotheby’s per «negligenza» nella valutazione dell’opera. Via impervia. Da capire, perché conservare un tesoro (senza comunque sapere di averlo) e svenderlo, è pur sempre un dispiacere. Ma la riparazione tardiva risulta impraticabile.
L’Alta corte di Londra dà ragione alla casa d’aste: era pressoché impossibile identificare l’autore. Il quadro, prima dell’acquisto, era in condizioni tali da nascondere i particolari per l’attribuzione. Merito del fiuto e della competenza di David Mahon che l’ha riportato agli antichi splendori consentendo dunque la scoperta. Peccato che David Mahon sia nel frattempo morto centenario. Ha lasciato la sua raccolta di 56 capolavori ai musei inglesi e «I bari» in esposizione all’Ordine di San Giovanni in Clerkenwell. A mister Lancelot non resta che una visita (che è gratuita) per andare ad ammirarlo. Meditando se proporre appello o darsi per sconfitto.
Caravaggio e quel liuto fatto in serie
(Fabio Isman)
Macché Suonatore di liuto: del «più bel quadro che fece mai», come scrive Giovanni Baglione nel 1642, Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571 – 1610) eseguì più copie. Di due si sa dalle fonti antiche; ma adesso ne spuntano altre: la più recente, è attualmente in mostra a Cremona. Forse, da quel cantore efebico che intona un Madrigale, suonando un cinquecentesco strumento a dodici corde (probabilmente, dei 28 castrati della Cappella Sistina, Pedro de Montoya), egli trasse un’intera orchestra. È una storia ingarbugliata, ma avvicente; e merita di essere raccontata per intero.
L’esemplare storicamente meglio accertato è all’Ermitage di San Pietroburgo: eseguito per i Giustiniani, e venduto nel 1808, a Parigi, allo zar Alessandro I Romanov, detto «il beato». I fratelli Giustiniani, il cardinale Benedetto e il banchiere e marchese Vincenzo, abitavano nell’omonimo palazzo, che ora è la residenza del presidente del Senato; il dipinto era uno dei suoi 15 che possedevano, e nessuno è rimasto in Italia. Di fronte, a palazzo Madama ora sede del Senato stesso, in affitto dai Medici, dimorava invece il cardinale Francesco Maria Bourbon Del Monte Santa Maria, potente capo della fazione filofrancese della curia, mai candidato al papato forse per l’omosessualità, il primo mecenate dell’artista. Vuole un esemplare del quadro; oltre a tutto, Montoya viveva da lui, dove Caravaggio avrà anche il suo primo studio: era uno tra i suoi «famigli».
Molte delle «querelle» vertono su questo esemplare. Se ne conosce l’esistenza ancora da Baglione: «Il giovane che sonava il lauto, che vivo e vero il tutto parea». Dice pure di «una caraffa di fiori piena d’acqua», in cui il riflesso «di una finestra eccellentemente si scorgeva, e sopra quei fiori eravi una viva rugiada».
UN GIALLO DOC
Nel 1990 l’aveva trovata sir Denis Mahon. Tutto tornava. Nella versione Giustiniani, il castrato intona un madrigale di Arcadelt, la prima lettera, miniata, è una V: iniziale di Vincenzo; per Del Monte, è un brano di Francesco de Layolle, e il porporato si chiamava così. Al posto della brocca con i fiori, dipinta per i Giustiniani, una rara spinetta di una sola ottava, che era nell’inventario di Del Monte. Il quadro apparteneva ai Wildenstein; all’epoca, per sdebitarsi, sir Daniel offre un assegno da mezzo milione di dollari, per restaurare, su richiesta di Mahon, i cartoni dei Carracci della National Gallery di Londra per gli affreschi a Palazzo Farnese. Poi, per anni è esposto al Metropolitan, finché i proprietari, editori della Gazette des beaux arts dal 1928, coinvolti in un processo per una frode fiscale di alcuni miliardi e 550 milioni di tasse non pagate (finito in nulla per motivi procedurali a gennaio), non l’hanno celato altrove, pare in Svizzera.
Il volto del liutista è anche in un altro capolavoro tra i primi della stagione romana di Caravaggio: il Concerto (o i Musici), pure dipinto per Del Monte, e passato ai Barberini grazie a un’asta pilotata, acquistato dal Metropolitan di New York nel 1952, l’anno dopo la famosa mostra di Milano, con cui Roberto Longhi rivalutò il suo autore. Caravaggio, del resto, scriveva a un amico: «Sappiate che io suono di chitarriglia et canto alla spagnola».
UN’ALTRA VERSIONE
Ora, però, di questo secondo «Liutista», su cui erano d’accordo tutti i massimi esperti, è saltata fuori una seconda versione: approvata da studiosi come Mina Gregori, Claudio Strinati, Martin Kemp e Clovis Whitfield; mentre Keith Kristiansen, per esempio, rimane fedele alla versione già trovata da Mahon.
È simile a quella dell’Ermitage: invece della spinetta mostra la caraffa con i fiori; ma stavolta l’edizione è più viva: si vede chiaramente il «riflesso di una finestra» di cui parlava Bellori, e perfino «la rugiada». Apparteneva a Henry Sommerset, duca di Beaufort: la compera in Italia nel 1726 da Antonio Vaini, Gran Priore dei Cavalieri di Malta, e la vende nel 1960. Era ritenuta una copia: soltanto un restauro ne ha mostrato le qualità; «dopo, anche sir Denis l’ha ritenuta autografa», spiega Mina Gregori. «È l’unica versione che risponda appieno a quanto scrivono le fonti più antiche», dice Strinati, e sembra di troppo pregevole fattura per essere una copia antica. La recente scoperta di Riccardo Gandolfi, la prima biografia italiana dell’autore, fa sapere che Caravaggio crea il quadro a casa di Prospero Orsi; ma quale è? Un musicologo, David Edwards, esamina lo strumento e propende per la nuova «edizione», esposta fino al 23 luglio a Cremona, nella mostra Monteverdi e Caravaggio. Meglio vederla: perché, forse, la «guerra dei liuti» non è ancora conclusa; e non finirà, probabilmente, mai più.
Il perduto San Matteo del Caravaggio? Forse non fu dipinto per la Cappella Contarelli
(Federico Giannini e Ilaria Baratta)
Il prossimo 3 maggio si terrà a Roma, a Villa Lante al Gianicolo, un seminario sul “San Matteo e l’angelo” del Caravaggio, durante il quale saranno discusse novità sull’opera. Vi diamo alcune anticipazioni circa una novità di cui si discuterà.
Era il maggio 1945 quando, in una Berlino a onor di cronaca ormai liberata, le truppe sovietiche appiccavano fuoco al Flakturm Friedrichshain, benché ancora oggi si racconti di una responsabilità imputabile ai bombardamenti degli Alleati. Era questo, paradossalmente, il deposito dove, durante il secondo conflitto mondiale, si era pensato di mettere in sicurezza decine e decine di opere d’arte dal Kaiser Friederich Museum.
Leggere ancora oggi l’elenco dei quadri distrutti (ma ci piacerebbe pensare più ottimisticamente che siano stati trafugati, e che un domani qualcuno possa tornare alla luce) fa quanto meno raggelare. Rubens, Goya, van Dyck, Andrea del Sarto: sono solo alcuni autori degli oltre quattrocento dipinti dispersi. Fra questi, spiccavano ben tre Caravaggio, provenienti dalla collezione Giustiniani, i cui eredi se ne disfecero nel 1815 pur di recuperare liquidità, vendendoli al re di Prussia: il poco studiato Cristo nell’Orto degli ulivi, il Ritratto della cortigiana Fillide (modella di cui si è pensato, forzatamente, fosse amante dello stesso Merisi e che avesse posato anche in altri quadri) e, certamente il più apprezzato e noto fra tutti, il San Matteo e l’angelo. Quest’ultimo, come racconta il biografo Giovan Pietro Bellori, era collocato sull’altare della cappella Contarelli in San Luigi dei francesi, e fu rifiutato per mancanza di “decoro” e in particolare per quei “piedi rozzamente esposti al popolo”, con il santo che sembra un povero analfabeta, guidato letteralmente nella scrittura del Vangelo dalla mano dell’angelo. Tanto da essere sostituito dal più composto dipinto che tutt’oggi ammiriamo in chiesa.
Ma davvero andò così? La leggenda del “pittore maledetto” è estremamente affascinante e dura da scalfire. Eppure sembra più plausibile che, dato anche il formato pressoché quadrato e poco adatto a una pala d’altare (e l’altezza sensibilmente minore rispetto alla seconda versione), assieme all’assenza di documenti relativi (altrimenti sempre reperiti per gli altri lavori di Caravaggio nella cappella Contarelli) il San Matteo mai mise “piede” sull’altare. Piuttosto, l’opera deve essere stata commissionata direttamente come quadro “da stanza” dal marchese Vincenzo Giustiniani. Quest’ultimo, da lì a qualche anno, vi affiancò nella sua ricca galleria raffigurazioni degli altri tre evangelisti, per mano di altri celebri artisti: Guido Reni (San Luca), Domenichino (San Giovanni) e Francesco Albani (San Marco). Dell’intero ciclo è sopravvissuto il solo San Giovanni, andato a finire, e tutt’ora visibile, alla National Gallery di Londra. Degli altri due si era persa ogni traccia, finché recentemente il rettore di San Luigi dei francesi, monsignor François Bousquet, ha segnalato la presenza di un ciclo di quattro evangelisti appesi nella controfacciata della chiesa di Saint-Martin presso il borgo francese di Pauillac, nome che finora nulla avrebbe detto ai più. Due di questi dipinti sono copie dei già noti Matteo e Luca di Merisi e Reni, da cui si può dedurre, anche dalla lettura stilistica, che i restanti siano anch’essi copie degli altri due quadri mancanti all’appello, la cui iconografia era completamente ignota.
Con questa bella scoperta devono ora fare i conti le ricostruzioni cromatiche del caravaggesco San Matteo, tutte diverse ed elaborate con vari mezzi a partire da una semplice foto in bianco in nero, fino all’ultima del pittore Antero Kahila, che rispetto all’originale comunque si discosta in sostanza per il solo colore del mantello (rosso anziché aranciato). Il copista, oltre ad aver approfondito la tecnica di Merisi, si era anche documentato sulle descrizioni letterarie primonovecentesche dei vari studiosi che, ognuno ricorrendo a modo suo alle sfumature della propria lingua, avevano descritto i colori del dipinto disperso: la storia dell’arte, si sa, non è una scienza esatta (e le scoperte portano talvolta a rivedere quanto più di acquisito si credeva già). Ad ogni modo la copia di Kahila, olio su tela a dimensioni naturali, resta un pezzo di forte impatto emotivo, al di là della storia struggente del prototipo, ed è attualmente in esposizione fino ai primi di maggio a Roma presso Villa Lante al Gianicolo, villino rinascimentale oggi sede dell’Accademia di Finlandia. Di tutti questi temi si parlerà in tale sede in un simposio ideato da Michele Cuppone che, il 3 maggio a partire dalle 18, vedrà dibattere studiosi di livello internazionale, da Alessandro Zuccari ad Altti Kuusamo.
Certo, fa dolore pensare a un Caravaggio che brucia o che comunque non c’è più. E, purtroppo, non è stata né la prima né l’ultima volta che è accaduto. Di nuovo, sono solo le fonti letterarie a ricordare una splendida Resurrezione dipinta a Napoli per tale Alfonso Fenaroli nella chiesa di Sant’Anna dei Lombardi, andata dispersa a seguito del crollo del 1798 che devastò l’edificio. Ancora, diverse ricerche si sono dedicate di recente a ricostruire, quanto meno, la genesi romana nell’anno 1600 della Natività con i santi Lorenzo e Francesco, ma del quadro non v’è più traccia da quando fu trafugato nel 1969 dall’oratorio di San Lorenzo a Palermo per cui fu dipinto. E non solo Caravaggio: è attualità dei nostri giorni il trafugamento della pala di Guercino nel 2014, e di diversi dipinti dal museo di Castelvecchio già l’anno seguente. Sono gli ultimi casi più clamorosi di una emorragia continua, ma almeno tutti questi ultimi fortunatamente recuperati (seppur in condizioni molto precarie nel caso del Guercino).
Il nostro paese vanta una ricchezza culturale inestimabile: occorre tuttavia ribadire che questo patrimonio non è adeguatamente valorizzato nel senso più nobile e meno commerciale del termine, e che non si fa abbastanza per mettere gli enti preposti nelle condizioni di conservarlo al meglio, pensando ai posteri ma anche a noi stessi. Il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, istituito fatalmente nello stesso 1969 dell’ultimo Caravaggio scomparso in ordine di tempo, da solo e con le risorse a disposizione non basta. Non vorremmo più aprire le pagine di cronaca ovvero culturali e leggere di un quadro, fosse anche soltanto uno in più e di valore incommensurabilmente minore a quelli prima considerati, sottratto alla collettività. Qualcosa veramente può cambiare?



a sinistra: Caravaggio, San Matteo e l’angelo (prima del 1602; olio su tela, 223 x 183 cm; già a Berlino, Kaiser Friedrich Museum; distrutto durante l’incendio del Flakturm Friedrichshain),
al centro Il dipinto individuato a Pauillac (fine XVIII secolo; olio su tela, 140 x 114 cm), a destra Antero Kahila, ricostruzione del San Matteo e l’angelo di Caravaggio (2008; olio su tela, 232 x 183 cm)
Hendrick ter Brugghen e Benedetto Giustiniani: una nuova traccia per gli sviluppi del 'caravaggismo' IL soggiorno dell'artista olandese in Italia e il ruolo decisivo del Cardinale Giustiniani: una rilettura completa di testi e documenti nell'esauriente ed accurato saggio di Clovis Whitfield
(tradotto da Consuelo Lollobrigida da
www.news-art.it )
Finora gli studi su Terbrugghen stati insoddisfacenti a causa dell’assenza di
qualsiasi evidenza concreta sulla sua permanenza in Italia. Questo ha
significato che la sua carriera, così come è rappresentata dalle sue opere note,
inizia molto dopo il suo rientro a Utrecht, e invero anche quelle poche opere
realizzate prima del 1620, anche quelle firmate e datate (dal 1616 in avanti)
sono state assegnate in maniera dubitativa a causa della loro poca assonanza con
quelle note. Ciò malgrado la considerazione della sua arte è universalmente
riconosciuta grazie alla sua esperienza maturata in Italia, tanto che è ritenuto
come uno degli artisti più rappresentativi del caravaggismo. Esiste un solo
documento riferibile al suo soggiorno italiano, datato 1614 mentre l’artista era
di ritorno in Olanda, e nessun cenno alla sua presenza altrove nel Paese,
neanche a Roma dove il suo stile sembra essersi consolidato, o a Napoli dove
Houbraken, uno dei suoi biografi, riferisce che vi fosse recato. Lo stesso
autore descrive Terbrugghen come un viaggiatore, e suggerisce anche un suo
secondo viaggio in Italia. Non esistono però evidenze di una sua permanenza
negli Stati delle Anime delle parrocchie romane. Questo dato potrebbe però
essere dovuto alla sua confessione protestante che gli faceva evitare il
censimento annuale delle anime realizzato principalmente per assicurarsi la
partecipazione alla messa domenicale. In qualche maniera Terbrugghen è stato
visto come il successore di Baburen, di cui era più giovane di sei anni, che
rientrò a Utrecth dopo di lui e la cui carriera fu interrotta da una morte
troppo precoce nel 1624. Sandrart, che pensava che avesse raggiunto l’Italia nel
1629 molto dopo che Terbrugghen era partito, era nella posizione di riconoscere
il suo talento anche nella collezione Giustiniani che aveva curato a Roma, non
lo aveva capito bene e gli dedicò una breve nota nella sua Teutsche
Akademie (1675), suggerendo a Richard, il figlio dell’artista di
provare a ridisegnare la biografia in maniera più precisa, che purtroppo è
andata perduta.
Sandrart per lo meno gli attribuisce il merito di aver seguito il movimento
caravaggesco, soprattutto nella sua tendenza a dipingere dal vero «in linea
con la sua inclinazione ad approdare a pensieri profondi e melanconici che
seguiva in natura e i suoi sgradevoli difetti molto bene nelle sue opere, ma sui
quali non si poteva essere d’accordo. Nello stesso modo un destino beffardo si
accanì contro di lui fino alla morte», ma non sembra si fosse reso conto
che la collezione di cui era il curatore comprendeva opere di Terbrugghen. Le
due opere nuove che possono essere confermate come sue dimostrano, in ogni modo,
il ruolo centrale che l’artista ricoprì nella fase iniziale del caravaggismo,
che iniziò intorno al 1612, e potrebbero anche mettere luce sul rapporto con
Saraceni. Inoltre nonché l’importante ruolo che un singolo mecenate giocò nel
perseguimento del nuovo naturalismo creato da Caravaggio, la cui genialità
dimostrò di apprezzare sin dall’inizio. Una è un’opera realizzata per il maggior
collezionista del caravaggismo italiano; l’altra è accompagnata dal primo
documento sulla presenza di Terbrugghen in Italia, che fu scoperto nel 1846.
Queste opere rappresentano i due lati del naturalismo e del colorismo dell’eroe
dei Giustiniani: la parte coloristica veniva continuata dall’unico amico
sopravvissuto, Carlo Saraceni, e l’altra da Terbrugghen.
Le difficoltà per Terbrugghen sono acuite dalla considerazione che alcuni dei
dipinti più caravaggeschi sono in effetti gli ultimi, ovvero quelli dipinti in
Olanda dove, insieme a Baburen, cercava di soddisfare la curiosità che molti
collezionisti nutrivano nei confronti del leggendario artista italiano. Secondo
Floris van Dijck, informatore di Van Mander, Terbrugghen fu il primo artista
nordico a rientrare da Roma con qualche impressione del leggendario illusionismo
caravaggesco di cui erano giunte voci.
Il documento che fornisce informazioni sul suo passaggio a Milano nel 1614,
mentre rientrava in patria, è stato probabilmente ricostruito in maniera errata.
Infatti, da un lato si è cercato di sostenere troppo l’idea che Terbrugghen
fosse in contatto con alcuni pittori del nord Italia, come Fetti e Bassano,
dall’altro si è evidenziato il suo rapporto con i pittori romani, città nella
quale sembra aver lasciato pochissime tracce documentarie. Secondo i suoi
biografi, Terbrugghen fu un viaggiatore. Rimane però ancora controverso sia un
viaggio a Napoli, sia un secondo viaggio a Roma, anche se la capitale dello
Stato Pontificio sembra rappresentare la città della sua formazione artistica. E
mentre Louis Finson fu più contento di provare a imitare (a Napoli) il suo amico
Caravaggio e di vendere le sue opere in veste di suo mercante, Terbrugghen
dovette competere con gli artisti locali e non limitarsi a fare le copie delle
opere che stavano diventando famose. Le due versioni della Vocazione di san
Matteo sono radicalmente differenti, e provengono chiaramente dal prototipo
caravaggesco di San Luigi dei Francesi.
All’interno della mostra Roma al tempo di Caravaggio,
svoltasi a Roma a Palazzo Venezia nel 2011, è stata pubblicata una Zingara,
firmata e datata <Enrico Ter<Brugg°<Flam°<… ADMDCXII>. Quest’opera apre una
finestra importante sull’attività dell’artista in Italia, dove arrivò
probabilmente nel 1608 e da dove ripartì nell’estate del 1614. È questa la prima
evidenza documentaria che viene alla luce della sua presenza nella penisola dal
1846 ed è di grande interesse perché apre un capitolo sulla prima metà della sua
carriera. Ma prima di tutto bisogna discutere di altri due incredibili dipinti
che realizzò nello stesso periodo.
La presenza, nell’inventario del marchese Vincenzo Giustinani stilato negli anni
’30 del Seicento, di due dipinti di ‘Enrico di Anversa’ portano
all’identificazione di Terbrugghen come l’autore delle due tele verticali
descritte nell’inventario del 1638 al numero 150 e 151 e che erano appesi nella
quinta Sala Grande del Palazzo romano. Uno, era ‘L’Historia di S. Pietro e
L’Ancilla che si scalda al fuoco di notte’ e l’altro ‘Christo ligato
alla Colonna, e diverse altre figure grandi al naturale dipinti in tela alto
palmi 13 largo 9 in circa senza cornice si crede di mano di d’Enrico d’Anversa’.
Uno di questi è stato esposto alla recente mostra fiorentina su
Gherardo delle Notti (Uffizi, febbraio-maggio 2015), benché
l’origine della Negazione di san Pietro (n. 5: una grande tela di cm
228x190, ora nella collezione Spier di Londra) non fu realizzato a quel tempo.
Il tema del dipinto è intrinsecamente caravaggesco e Gianni Papi lo mette
giustamente in relazione con la versione orizzontale dello stesso soggetto
eseguito da Terbrugghen, ora all’Art Institute di Chicago (cm 132,5x178). Le
dimensioni coincidono: 13 palmi romani sono circa 290 cm, e gli 8 palmi della
larghezza sono all’incirca compatibili con i 180 cm dell’unità di misura ora in
uso. In vendita da Tajan a Parigi nel 2007, è apparso con l’attribuzione a
Terbrugghen. Proveniva da una collezione nei pressi di Bordeaux, ma le origini
non erano documentate da alcuna storia utile, e l’attribuzione non era
supportata né da nessun esperto di arte olandese, né da Wayne Franits, autore
della recente monografia sull’artista che ha preso le mosse dal progetto di
Leonard Slatkes. In realtà il tema è proprio da associare a Terbrugghen, di cui
esistono altre versioni. Si tratta di un frammento con una serva al Stourhead
National Trust; e un’altra composizione, ma speculare, più fortemente dipendente
da Dürer alla Shipley Art Gallery di Gateshead (un’altra versione a Lubiana in
Polonia). Il dipinto di Chicago è ritenuto tardo a causa del disegno somigliante
alla Liberazione di san Pietro di Schwerin, un dipinto firmato e datato
1629. Ma l’esistenza del dipinto Giustiniani come uno dei primi tra le opere
note in Italia deve spingerci a riconsiderare anche la datazione basata su dati
stilistici, perché indica una flessibilità nella resa, per lo meno a giudicare
da un tale capolavoro eseguito all’inizio della carriera. I soggetti dei dipinti
di Terbrugghen resistono con coerenza a una datazione verso l’ultima decade
della sua attività, e l’esistenza delle due Negazioni potrebbero
dimostrare la sua abilità a lavorare in modi diversi in Italia e in Olanda.
Benedict Nicolson pubblicò il suo magistrale lavoro sull’artista nel 1958, prima
che Luigi Salerno pubblicasse gli inventari Giustiniani. Nel suo articolo uscito
su Barlington Magazine (The Picture Gallery of Vincenzo Giustiniani, II,
The Inventory, Part II, 1960, vol. 102, p. 101), Nicolson conclude affermando
che «the artist has not been identified». Gli inventari Giustiniani
sono stati successivamente pubblicati in maniera estensiva e puntuale da Silvia
Danesi Squarzina nei tre volumi La Collezione Giustiniani
(Einaudi, 2009), dove la storica suggerisce che il pittore chiamato Enrico
d’Anversa potrebbe essere invero proprio Hendrick Terbrugghen, anche se i
dipinti a lui attribuiti in quell’occasione non furono rintracciati. La
Squarzina annota che l’artista era nato a Utrecht, e non ad Anversa; ritenne il
formato verticale del primo soggetto un possibile errore ipotizzò
un’identificazione con la versione orizzontale della Negazione (cm
130x176) del Chicago Art Institute (L.J. Slatkes and W. Franitis, The
Paintings of Henrick Terbrugghen, 2007, n. A35, fig. 34, ma questa è
un’opera generalmente datata verso la fine della vita dell’artista). È vero che
la maggior parte delle altre rappresentazioni caravaggesche della Negazione
hanno un formato orizzontale, a parte quelle attribuite a Carlo Saraceni, così
che le dimensioni eccezionali, ripetute negli altri inventari, non sono degli
errori. La coppia fu descritta nell’inventario post-mortem del principe
Andrea Giustiniani nel 1667, dove vengono attribuite a ‘Errico d’Anversa’.
Nell’inventario Giustiniani del 1793, inv. 1, n. 100, la Negazione è
descritta come: «Altro di palmi 8.13 per alto rappresentante S. Pietro che
si scalda quando fu interrogato dalla Serva di Pilato. di Gherardo delle Notti,
con Cornice come sopra….» (Squarzina, II, p. 293). Allora il quadro era
appeso nella Galleria, mentre la Flagellazione si trovava nella Seconda
Camera: «216 Altro di palmi 9.14 per alto 9.14 per alto rappresentante la
Flagellazione di Gesù Cristo alla Colonna di Michel’Angelo da Caravaggio, con
Cornice come sopra dorata a vernice» (Squarzina II, p. 305).
Squarzina suggeriva (I, p. 329/30) che questo Enrico d’Anversa poteva essere
proprio Hendrick Terbrugghen.
Ma le due tele monumentali che Benedetto Giustiniani aveva commissionato persero
molto presto la loro associazione con ‘Enrico d’Anversa’, anche se, nell’Itinerario
istruttivo di Roma Antica e Moderna, Mariano Vasi (1804, Vol. II,
p. 347/348) le colloca dentro palazzo Giustiniani e le attribuisce a Caravaggio.
Gaspare Landi fece un ulteriore inventario dei pezzi che rimanevano in palazzo
Giustiniani nel 1812/16 (Squarzina II, p. 412) dove al n. 151 compare un San
Pietro che nega Cristo alla Serva di Pilato di Gherardo delle Notti,
seguito dalla Flagellazione. Sembrerebbe quindi che i due dipinti non
avessero fatto parte della selezione che era andata a Parigi, dove nel 1808
Vivant Denon avrebbe venduto il Suonatore di Liuto di Caravaggio allo
zar Alessandro I di Russia. La situazione della collezione (così come quella di
altre collezioni romane, come quella dei Mattei) divenne sempre problematica:
durante il corso del XVIII secolo e l’inizio del XIX le famiglie patrizie non
furono più in grado neanche di provvedere le doti per le loro figlie. L’ultimo
Giustiniani del ramo romano, Leonardo Benedetto Giustiniani del Negro morì senza
eredi il 21 novembre 1857. In base al Fedecommesso voluto da Vincenzo
Giustiniani nel 1631, fu designato successore dei beni romani, del Palazzo e dei
suoi arredi, Pantaleo Vincenzo Giustiniani Recanelli di Genova, che non perse
tempo a disperdere la collezione. Tra i 144 dipinti della proprietà romana
catalogati entro la fine del 1857 dal signor Luigi Carpentieri, un mercante di
arte antica che aveva curato la collezione per molti anni, compare per l’ultima
volta la Negazione (con un riferimento alla numerazione dell’inventario
di Gaspare Landi del 1812/16): [66] n. 174 = S. Pietro che nega Cristo alla
Serva di Pilato di Gherardo delle Notti cornice come sopra scudi Trecento. 300.
Quindi nel 1857 la Negazione era ancora a palazzo Giustiniani nel
Salone con la volta dipinta dai Fratelli Zuccari (in realtà realizzato da Ricci
e Lanzone alla fine del XVI secolo). N. 66 – n. 174 – S. Pietro che nega
cristo alla Serva di Pilato di Gherardo delle Notti cornice come sopra scudi
Trecento 300 (Squarzina II, p. 443), fu quindi valutato molto bene, anche
se nessuno dei dipinti nella vendita selvaggia sembra aver raggiunto la stima
iniziale. Nel 1859 ci fu un’ultima vendita: la Flagellazione al n. 170
dell’inventario di Landi, ma il n. 174 non compare, potrebbe essere stata
venduta dopo che fu stilato l’elenco nel 1859. Il dipinto (Squarzina V.II, p.
456) fu venduto, insieme ad altre opere, a Mazzoleni, mentre la Negazione
fu venduta privatamente dopo l’inventario di Carpentieri del 1857 e prima della
definitiva dispersione del 1859. In ogni caso l’autore di queste due opere, che
Vincenzo segna come di ‘Enrico d’Anversa’, era già perso entro la fine del XVII
secolo.
Come molti altri dipinti della collezione Giustiniani, in particolare quelli che
sono rimasti fino all’ultimo in palazzo Giustiniani, che sarebbe diventato una
delle sedi del Senato Italiano, la Negazione di san Pietro ha avuto un
percorso difficile. I Giustiniani, così come molte altre famiglie patrizie
romane, avevano sofferto un lungo declino delle loro fortune già dalla morte del
marchese Vincenzo nel 1638, e, malgrado il fedecommesso cui era stata legata la
collezione già nel 1631, antichità e opere d’arte erano svanite tra i muri come
nel nulla. Nel XVIII secolo, la moglie anglo-irlandese del principe Giustiniani
aveva deciso di pulire la collezione dei dipinti, affidandone la loro
conservazione alla restauratrice francese Margherita Bernini. Più che pulire, la
Bernini cercò di dar loro nuova vita, procedimento documentato nella
corrispondenza che iniziò nell’estate del 1788 con una lettera che Philip
Hackert inviò a Sir William Hamilton a Napoli, dove l’artista si dichiara
contrario all’uso delle vernici nel restauro dei dipinti (pubblicata nel
Giornale delle Belle Arti nell’ottobre e novembre del 1788).
La Bernini, per contrasto, usava una ‘manteca prodigiosa’ (in italiani
nel testo, ndt) per le opere dei Giustiniani (al tempo sotto la
curatela di Pietro Angeletti), una specie di bacchetta magica per l'aspetto dei
dipinti che stavano già mostrando i primi segni del tempo. Quello che in realtà
la restauratrice usava era un ravvivante, creato dalla chiara dell’uovo montata
a neve, che benché producesse un effetto traslucente, in realtà più che
verniciare nel tempo faceva svanire i colori. La Bernini ‘ripulì’ più di
duecento opere della collezione, il cui scopo, in retrospettiva, era quello di
rendere le opere più belle per una possibile vendita, più che un reale spirito
conservativo. In effetti, molti dipinti furono successivamente inviati a Parigi
sotto la cura del mercante d’arte Jean-Baptiste-Pierre Lebrun, marito della
pittrice Elisabeth Vigée-Lebrun. Se i Terbrugghen fossero stati in questa
spedizione non lo sappiamo, ma stando alle misure delle tele, queste furono
arrotolate con la pellicola pittorica rigirata verso l’interno, e nel caso della
Negazione questo procedimento sbagliato provocò dei danni alla
pellicola pittorica. Ciò detto, le condizioni e l'aspetto della tela, in
particolare nell’area delle figure e nella parte bassa della composizione,
possono costituire un indizio in tal senso.
In realtà Benedetto Giustiniani aveva già commissionato lo stesso soggetto a
Ludovico Carracci, per il quale l’artista impiegò un tempo considerevole nel
1607. Quest’opera si trovava nell’inventario stilato dopo la morte del cardinale
nel 1621: «un quadro di un san pietro quando fu interogato dall’ancilla nel
Cortile d’herode» (n. 140; Squarzina, I, p. 167). Il dipinto è
correttamente descritto nell’inventario del 1638 (n. 55), ancora in quello del
1667, e nella Pinacotheca, sive Romana Pictura et Scultura
di Giovanni Michele Silos nel 1673. Ciò significa che Benedetto aveva una
particolare passione per questo soggetto, che deve aver commissionato a Ludovico
subito dopo il suo arrivo a Bologna nel 1606. Potrebbe forse essere a causa di
quest’incarico che l’artista scrive a Ferrante Carlo il 5 gennaio 1608,
scusandosi per il ritardo nella consegna della grande tela per Piacenza, che
sarebbe dovuta essere pronta già dall’agosto precedente. Nella lettera Ludovico
spiega che il nuovo Legato di Bologna lo aveva incaricato di realizzare «una
certa opera, dove vi consumai molto tempo e lodato Dio è finita». Anche la
versione di Ludovico, ancora non rintracciata, aveva un formato verticale ed era
molto più piccola di quella commissionata a Terbrugghen. Si trattava però, da
quello che possiamo capire dalle descrizioni, di una scena notturna, con un
fuoco presso il quale Pietro si scaldava e con un ruolo centrale dato
all’ancella, che era la portiera che aveva aveva aperto le porte del tempio dove
Caifa era Sommo Sacerdote. La scena del fuoco è menzionata sia in Luca (22:55)
che in Giovanni (18:25) e farebbe pensare in maniera accattivante che dietro
alla scelta della Negazione ci fosse Benedetto Giustiniani che
probabilmente incoraggiò anche l’idea dell’uso degli effetti della luce che
molti artisti dopo Terbrugghen avrebbero seguito, da Baburen, Honthorst e Stomer
a Gerard Seghers e Jan van Bijlert.
Come abbiamo già visto, in Italia Terbrugghen si firmava ‘Flam°’, non deve
quindi sorprendere se Vincenzo Giustiniani, nell’inventario del 1638, si
riferisce a lui come a Enrico d’Anversa. Malgrado questa ipotesi non sia mai
stata confermata, stante l’alta ricorrenza di questo nome nella Roma del
Seicento, Vincenzo cita nuovamente l’artista nel suo Discorso supra
la pittura scritto negli anni ’30, quando riferendosi
all’undicesimo dipinto dice che «è di dipingere con avere gli oggetti
naturali d’avanti. S’avverta però che non basta fare il semplice ritratto, ma è
necessario che sia fatto il lavoro con buon disegno, e con buoni e proportionati
contorni, e vago colorito e proprio, che dipende dalla pratica di saper
maneggiare i colori, e quasi d’istinto di natura, e grazia a pochi conceduta; e
soprattutto von saper dare il lume conveniente al colore di ciascheduna parte, e
che i sudici non sieno crude, la fatti con dolcezza ed unione; distinti però le
parti oscure, e le illuminate in modo che l’occhio resti soddisfatto dell’unione
del chiaro e scuro senza alterazione del proprio colore, e senza pregiudicare
allo spirito che si deve alla pittura, come ai tempi nostri, lasciando gli
antichi, hanno dipinto il Rubens, Gris Spagnuolo, Gherardo, Enrico, Teodoro, ed
altri simili, la maggior parte Fiamminghi esercitati in Roma, che hanno saputo
ben colorire». Sembra che Vincenzo stia descrivendo proprio le qualità
stilistiche che aveva visto nella Negazione, e che questo tipo di
pittura dal vero era praticata particolarmente dagli artisti che menziona, e che
venivano prevalentemente dalle Fiandre. I nomi a cui si riferisce, a parte
Rubens che non è presente negli inventari Giustiniani, sono della generazione di
quelli sponsorizzati da suo fratello. Ribera (Lo Spagnoletto), nel suo soggiorno
romano dal 1612 al 1617, realizzò più di una dozzina di dipinti. Honthorst, a
Roma anche prima del 1615, dipinse Cristo davanti al Sommo Sacerdote,
ora alla National Gallery di Londra, una tela grande, che evidentemente deve
essere inserita nella stessa serie di quelle di Terbrugghen, e che Vincenzo
chiamava Cristo davanti a Caifa. Datato intorno al 1617, il dipinto è
un esempio specifico dell’impegno di inserire nel testo l’osservazione diretta
della realtà che caratterizzò questo particolare momento di revival caravaggesco,
evidentemente sostenuto da Benedetto Giustiniani. Per il cardinale, Honthorst
dipinse la Liberazione di san Pietro, ora a Berlino (una tela più
piccola, cm 130x181), mentre Teodoro, che è Dirck van Baburen, ma conosciuto in
Italia con quel nome, dipinse la grande sovrapporta raffigurante la Lavanda
dei piedi [Giovanni, 13: 1-17], ora a Berlino, cm 199x297. Quindi le due
tele di Terbrugghen costituirono le prime di una serie dalle dimensioni
eccezionali, circa tre metri per due, che Benedetto commissionò alla nuova
generazione di artisti che erano desiderosi di seguire le orme di Ciriaco
Mattei, per il quale Caravaggio realizzò alcuni dei soggetti principali della
fede cristiana: la Cattura di Cristo e la Cena in Emmaus. Un
altro dipinto della stessa serie potrebbe essere stato eseguito da Carlo
Saraceni che fece un Cristo e due Apostoli nella strada per Emmaus
(12x8 palmi, cm 270x180), come il soggetto di Caravaggio che molto presto
raggiunse la collezione di Carlo I a Londra. Anche Vouet, a Roma dal 1613,
dipinse un’Annunciazione (cm 290x193), perduta a Berlino nel 1945.
Domenico Fiasella fu chiamato a palazzo Giustiniani per dipingere due episodi
della vita di Cristo: Cristo che cura il figlio della vedova di Nain e
il Cristo che ridà la vista al cieco, ora al Ringling Museum di
Sarasota, dalle analoghe dimensioni (cm 275x178,5). Tutti questi dipinti sono
evidentemente da mettere in relazione alla passione che Benedetto nutriva
nell’illustrare episodi del Nuovo Testamento, utilizzando il ritrovato
linguaggio realistico, anche se guardava con lo stesso interesse ai pittori
bolognesi, specie dopo il suo soggiorno nella città emiliana.
Nell’’Anticamera dell’appartamento grande del Cardinale, Benedetto aveva la
Visitazione di Antonio Carracci, un altro grande dipinto verticale (cm
270x160, perduto), menzionato da Malvasia, anche se Vincenzo si sbaglia ancora
una volta attribuendolo ad Agostino ma spiegando che il dipinto non era stato
completato a causa della malattia dell’artista, che lo portò alla morte precoce
nel 1618. La grande serie degli Evangelisti fu invece commissionata a
Domenichino per sostituire il San Giovanni, già presente nel suo
inventario del 1621 al n. 86. Gli altri tre – San Matteo di Nicolas
Regnier, San Marco di Francesco Albani e San Luca di Guido
Reni – tutti perduti, sono presenti nell’inventario del 1638, e passarono sotto
il patronage di Vincenzo dopo la morte del fratello.
Vincenzo, che ereditò il palazzo in Campo Marzio e la collezione quando morì suo
fratello nel 1621, non era molto sicuro delle attribuzioni quando stilò
l’inventario, ecco perché la sua cautela nello scrivere «si crede di»
quando nomina gli autori. Ma Vincenzo seguì l’esempio di suo fratello
nell’appoggiare artisti come Regnier e Valentin. La sua passione per il
collezionismo era più portata però verso gli oggetti antichi, che avrebbe
celebrato nell’elegante edizione della Galleria Giustiniani
pubblicata nel 1634. Ad ereditare il palazzo di città era stato suo fratello,
quando nel 1600 morì il padre Giuseppe, mentre Vincenzo ebbe la tenuta e il
titolo di marchese di Bassano Romano. Malgrado si trovasse spesso a Roma, le sue
direzioni artistiche erano indirizzate nella decorazione del Palazzo, dei
giardini e della tenuta di caccia ai Castelli, così come nel desiderio di far
crescere la sua giovane famiglia, i cui membri morirono tutti prima di lui. A
Benedetto andò anche la Villa Giustiniani fuori Porta del Popolo, che all’inizio
del XIX secolo fu incorporata in Villa Borghese. Il prelato aveva quindi spazio
a sufficienza per appendere queste enormi tele di arte moderna, che potrebbero
sembrare pale d’altare, ma in realtà furono commissionato per uso privato visto
che le autorità ecclesiastiche, come fu per Caravaggio, erano spesso troppo
conservative per accettare queste nuove tendenze iconografiche. Tra l’altro
Benedetto aveva ereditato anche le risorse finanziarie per poter proseguire
questo patronage, tanto che si diceva che avesse speso una fortuna per
comprare arte. Questa è la ragione del cauto approccio di Vincenzo
nell’attribuire i nomi degli autori alle opere commissionate da suo fratello,
quali Saraceni, Vouet, i due Terbrugghen e due Honthorst che sono indicati come
«si crede di». Mentre le opere di Regnier, Valentin e
Spadarino, che erano stati presenti a Palazzo Giustiniani durante la sua
reggenze sono, con chiara intento distintivo, furono attribuite senza dubbi o
tentennamenti. Sandrart riferisce che l’Amore Vincitore di Caravaggio
era appeso insieme a altri 120 dipinti in una sola stanza di Palazzo
Giustiniani, aperta al pubblico, con l’idea sia di mostrare i veri fatti del
Nuovo Testamento così come realmente accaduti sia di provocare un incredibile
impatto emotivo agli occhi di tutti i visitatori. Non tutte le acquisizioni di
Benedetto sono elencate nel suo inventario del 1621, che comprendeva 280
dipinti, e che la Squarzina riteneva si trovassero nella «stanza dei
quadri antichi» o nella Galleria.
I due quadri fatti per il cardinal Benedetto da ‘Enrico d’Anversa’, dei quali la
Negazione di san Pietro è ora tornato alla luce, furono dipinti in un
periodo abbastanza breve, certamente prima del suo documentato passaggio a
Milano nel 1614, durante il viaggio di rientro in Olanda dove si sarebbe sposato
entro più o meno un anno. Il figlio Richard riteneva che il padre avesse speso
dieci anni in Italia, e certamente fu in questo Paese che l’artista ebbe la sua
formazione.
L’aver ora compreso che il gusto per l’arte moderna del cardinale, così come la
sua volontà di far continuare il nuovo realismo nella rappresentazione delle
scene bibliche, è un importante passo in avanti nel riconoscere il suo ruolo
nello sponsorizzare il caravaggismo nella seconda decade del Seicento. Ciò va
contro l’idea prevalente della generazione di Vincenzo, che comprende il suo
curatore Sandrart e Bellori, Malvasia e Baldinucci, Passeri e Pio, che indica
nel marchese il principale responsabile di tutte le importanti acquisizioni
della collezione Giustiani. Tutti questi personaggi del resto erano molto più
ossequiosi verso il marchese che verso il fratello, con il quale non avevano
familiarità anche perché morì molto prima che questi salissero sulla scena.
Queste evidenze inducono ad affermare che ad avere una relazione con Caravaggio
fu piuttosto Benedetto: era suo il ritratto, suoi i Padri della Chiesa (Girolamo
e Agostino), e sue le opere rifiutate all’artista, come la prima versione del
San Matteo e probabilmente l’Amore Vincitore.
Benedetto rientrò a Roma dalla legatura a Bologna nell’autunno del 1611. Da
questo momento si apre un nuovo capitolo nel suo patronage, chiamando a
sé artisti che erano in grado di seguire il suo entusiasmo per il nuovo
naturalismo del quale era un acceso ammiratore sin dai tempi in cui incontrò
Caravaggio. L’artista morto, ma altri pittori potevano essere in grado di
rispondere alla sua chiamata: e furono dei giovani che venivano dall’estero a
farlo. Fu proprio allora che arrivarono a Roma, Ribera (1612 ?), Baburen (1612
?), Vouet (1613), Vignon, Honthorst (1615 ?), seguiti da Valentin, e Jean
Ducamps, nel 1620 all’incirca, e quindi Stomer. Cecco, che sembra essere stato
il giovane assistente di Caravaggio, probabilmente iniziò a dipingere proprio in
questo periodo, e sappiamo che Bartolomeo Manfredi realizzò la sua versione
dello Sdegno di Marte, ora a Chicago, nel 1613 perché, come riferisce
Mancini, non gli era stato concesso di copiare la celebre versione che
Caravaggio aveva dipinto per il cardinal del Monte. Sembrerebbe che questo
rinnovato interesse per il caravaggismo fosse spinto da qualche fattore esterno,
e probabilmente il rientro a Roma del potente mecenate di Caravaggio sembrerebbe
la spiegazione. In realtà, la Negazione di san Pietro fu forse
inspirata in parte da un dipinto di Caravaggio giunto a Roma nel 1612. Questo
grande dipinto, finora conosciuto da una replica al Metropolitan Museum, fu una
vivace ispirazione che evidentemente spinse Terbrugghen a reinterpretare il
soggetto per far capire quanto di Caravaggio avesse assorbito, senza però
ripetere o copiare l’opera che aveva visto. Nello sfondo del dipinto c’è anche
un’eco della Cattura di Cristo, l’altro celebre dipinto che Caravaggio
aveva realizzato per Ciriaco Mattei. I due dipinti di Caravaggio includono anche
delle fonti di luce artificiale: una lanterna nella Cattura di Cristo e
la luce del fuoco scoppiettante nella Negazione. Questi elementi
parlano del coinvolgimento del committente, che non soltanto si preoccupava
della corretta interpretazione del passaggio biblico, ma anche degli effetti
della luce e del colore, che suo fratello avrebbe più tardi spiegato nel
Discorso sulla Pittura. Era dopo tutto non soltanto
problematico rifare una copia precisa dell’opera ma anche un affrontare il
disegno, comprendere le gradazioni di luci e ombre, le ombre corrette – come
quando descrive i sudici (in italiano nel testo,
ndt) - o le gradazioni di profondità delle ombre e la differente percezione
dei colori al variazione delle luci. Benedetto era stato evidentemente
conquistato dall’idea della luce artificiale nei dipinti, che divennero più
familiari a Roma da quando pittori veneziani come Tintoretto e Bassano divennero
più popolari, e naturalmente anche da quando in collezione apparvero le opere di
Luca Cambiaso, maestro genovese della ‘luce di candela’. Scene realizzate al
lume di candele erano la caratteristica della collezione a partire perlomeno dal
1601. In realtà Caravaggio stesso aveva raramente utilizzato una fonte di luce
che non fosse quella del giorno, eccezion fatta nelle Sette Opere della
Misericordia. Certamente, non si può dire che in quest’opera l’interesse
per la luce artificiale sia predominante, come lo è invece nelle opere di
Honthorst, Baburen, Trophime Bigot, Spadarino, Gerard Seghers, e solo per
citarne alcuni. Questa scelta linguistica ebbe particolare successo tra i
pittori francesi e olandesi, da Valentin de Boulogne (si veda il suo esempio al
Puskin di Mosca) a Gherard Seghers che ne fece una delle caratteristiche
principali della sua produzione.
Terbrugghen deve aver dipinto le due tele tra il 1612 e l’inizio del 1614, e
così succede che l’opera scoperta e mostrata per la prima volta alla mostra
Roma al tempo di Caravaggio nel 2011, sia nondimeno
firmata e datata al 1612, e rappresenti l’unico documento scritto della sua
presenza in Italia. Uno dei misteri della sua carriera è che, benché la sua arte
sia un chiaro riflesso della sua esperienza italiana, non ci sono documenti che
ne attestino la sua reale presenza. Nella stessa mostra fu anche esposta una
Buona Ventura che è un ulteriore prova dell’interesse di Terbrugghen per i
temi secolari di Caravaggio. Giulio Mancini, scrivendo a suo fratello Deifebo il
7 giugno 1613, definisce questo soggetto come «la più bella cosa che habbia
fatto Michelangelo da Caravaggio […] una Zinghara» e in un certo modo il
ritorno di interesse per l’artista si concentrò questa volta nel colorato
realismo dei suoi primi dipinti, ovvero di quella fase antecedente l’uso delle «ombre
finissime» come le definì Bellori. In questo periodo anche Scipione
Borghese iniziò a collezionare antiche rappresentazioni di zingare - anche nelle
loro fantasiose ricostruzioni dello scultore francese Nicolas Cordier - per
decorare la stanza che aveva dedicato a questo soggetto della sua Villa al
Pincio. Questa potrebbe essere l’altra eredità del naturalismo caravaggesco
recepito da Terbrugghen, che avrebbe avuto anche maggior successo una volta
rientrato in Olanda, dove la pratica di singoli musicisti e bevitori, nei quali
si era specializzato Baburen, avrebbe per sempre contraddistinto l’eco di questo
nuovo naturalismo adottato dalle nuove generazioni di artisti. Sembra che già ci
fosse una consapevolezza delle due linee del caravaggismo: una, finalizzata alla
resa di ombre scure per enfatizzare il dramma della azzione
(in italiano nel testo, ndt); l’altra, luminosa, colorata e
anche caricaturale. Ambedue richiedevano però la sensibilità alla luce e al
colore cui si riferiva Vincenzo Giustiniani e, per allargare la prospettiva, a
cui rimandava il dibattito portato avanti tra il fratello Benedetto e molti di
questi artisti fiamminghi.
Il dipinto ha un’iscrizione in lettere maiuscole proprio al centro della tela
originale: aegiptia credul° divx enrico ter (in ligature)
brugg° flam° pinxit ad mdcxii. Un rintelo dell’inizio del 1800 aveva nascosto
l’iscrizione, tanto che non fu neanche vista quando il dipinto fece il suo
ingresso al North Caroline Museum of Art di Raleigh, al quale era stato donato
nel 1956. La scritta è venuta alla luce quando, durante un trasferimento
dell’opera, un incidente rese necessario cambiare il supporto. Un caso analogo è
successo alla Buona Ventura di Simon Vouet, di Palazzo Barberini.
Durante il restauro dell’opera è venuta alla luce un’iscrizione con la data
1617, e rappresenterebbe il primo dipinto documentato dell’artista a Roma.
Questa iscrizione è simile a un’altra che si trova nel retro di una tela già
appartenuta a Cassiano dal Pozzo, in cui è scritto che l’opera fu ad vivum
depicta, offrendo quindi un’idea precisa del sistema di lavoro di questi artisti
che gravitavano intorno ai Giustiniani. Così come ricorda, qualche anno dopo
Federico Borromeo: «nei miei dì conobbi un dipintore in Rona, il quale era
di sozzi costumi, et andava sempre co’ panni stracciati, e lordi a meraviglia, e
si vivea del continuo frà i garzoni delle cucine dei signori della Corte. Questo
dipintore non fece mai altro, che buono fosse nella sua arte, salvo di
rappresentare i tavernieri et i giocatori, ovvero le zingare che guardano la
mano, ovvero i baronci, et i facchini, e gli sgratiati, che si dormivano la
notte per le piazze, et era il più contento uomo del mondo, quando aveva dipinto
un’osteria, e cola entro chi mangiasse e bevesse, Questi procedeva dai suoi
costumi, i quali erano somiglianti a suoi lavori». benché le vesti
rattoppate dello scugnizzo (in italiano nel testo,
ndt) nella Buona Ventura potrebbero ricordare questo passaggio, in
realtà questa descrizione si adatta molto di più ai mendicanti e ai filosofi di
Ribera, dove a dare lustro a questi soggetti è la luce brillante delle pieghe e
l’incredibile sofisticatezza dei colori. Il fuoco sotto il calderone è una
caratteristica che lega il dipinto alla Negazione, dove la fiamma che
scalda Pietro manda una luce che selettivamente descrive gli abiti dei
protagonisti. Per contrasto è usata la luce del giorno, con un’articolazione più
forte, più fiamminga, così come il viso della cortigiana è molto vicino alle
facce dipinte da Baburen. Del resto questi era appena arrivato a Roma e i due
probabilmente furono più a stretto contatto in quell’occasione di quanto non lo
sarebbero stati quando condivisero lo studio una volta rientrato a Utrecht nel
1620. Ma il paesaggio sullo sfondo, che ha anche caratteristiche fiamminghe, è
vicino anche a quelli dipinti da Saraceni, altro elemento che conferma la
formazione italiana di Terbrugghen.
La composizione non è affatto dipendente dall’originale di Caravaggio. La figura
singola del musicista è solo superficialmente vicina all’esempio originale del
Suonatore di Liuto e ai Musici del Metropolitan. Questo
dimostra che Caravaggio introdusse degli esempi che potevano essere liberamente
interpretati dagli artisti, permettendo loro di staccarsi dalla consuetudine dei
metodi di lavoro presenti negli atelier contemporanei. D’altro canto, la
Buona Ventura riecheggia una stampa dell’inizio del XVII secolo (così come
una versione dipinta alla Galleria Pallavicini), in cui sono presenti gli stessi
quattro personaggi, e che era dedicata al Cavalier d’Arpino, visto la dedica che
menziona la sua carica di Cavaliere, ricevuta da Clemente VIII nel 1600. Non c’è
nessuna ragione di credere che non poteva essere stata usata più tardi, come
dimostra una lettura superficiale dell’opera di Terbrugghen. Il monogramma che
appare due volte non è stato identificato, ma a me sembra non ci siano dubbi che
si tratti di Francesco Villamena (Assisi, 1584 - Roma, 1624), che eseguì sia
stampe con scene della vita popolare romana, sia dipinti con lo stesso soggetto.
Lo sfondo grafico del dipinto è simile a quello della stampa, e i raggi a
infrarosso hanno mostrato che l’artista insistette a lungo sulla realizzazione
delle figure, come dimostra il cavaliere che prima doveva essere sulla destra e
un’altra figura che guarda dalla parte opposta del centro (il piede è un ovvio
pentimento vicino al piede destro del cavaliere). La caratteristica
olandese è certamente sua, così come si vede in un’incisione ricavata da un
presunto autoritratto che Bodart incise nel 1608 per Richard Terbrugghen. Il
cadente cappello piumato deriva dall’esempio dei Giocatori di carte –
che allora ancora apparteneva al cardinal Del Monte – ed è un elemento tipico
della cultura italiana. Esiste un certo gruppo di figure come il Cavaliere, e
per esempio il carnefice nella Decollazione di santa Caterina del
Chrysler Museum, e il frammento della Decollazione del Battista della
National Gallery di Edimburgo. Queste opere sono difficili da datare, benché
siano siano state inserite nel suo catalogo tra quelle degli anni ’20, anche se
potrebbero essere state eseguite in precedenza. Benché siano più sofisticate
della Buona ventura, è un comune denominatore l’abilità di
rappresentare i panneggi in veri e propri raffinati passaggi di pieghe. Il
cavaliere sulla destra in Muzio Scevola di fronte a Porsenna è uno dei
confronti più vicini e, in un’opera che ha molto del chiaroscuro (in
italiano nel testo, ndt) della Negazione, dimostra che questa
potrebbe proprio essere un’opera italiana. Il profondo scorcio del segretario
morto di Porsenna è un luogo comune tra molti artisti di questo periodo, da
Antonio Carracci a Louis Finson.
La recente mostra su Saraceni a Roma ha chiarito quanto l’artista maturò in
questa cultura intorno alle maggiori committenze che Benedetto Giustiniani diede
agli artisti del circolo fiammingo, che avevano fatto parte del suo studio o
accademia. Se lo stile più staccato (in italiano nel testo, ndt),
questo stile caratterizzato da un colorismo frizzante di alcuni dipinti di
narrazione di Terbrugghen, sembra provenire da questo retroterra culturale.
Varrà veramente la pena rincorrere questa idea su come Terbrugghen abbia gestito
le singole caratteristiche della pittura italiana, che ora conosciamo, per
vedere se il ricco colorito e i profili del Il corpo di santo
Stefano compianto dai santi Nicodemo e san Gamaliele (Boston, Museum of
Fine Art; mostra di Saraceni, n. 59) non siano usciti dalla sua mano.
C’è poi il mistero del ‘Pensionante’: la sottigliezza della risposta di
Terbrugghen alla Negazione alla richiesta dei Giustiniani
dell’intuitiva abilità dei pittori (fiamminghi) di catturare la realtà degli
oggetti posti di fronte a loro, della luce appropriata e del colore che cambia a
secondo del variare del chiaroscuro (in italiano nel testo, ndt), fu
certamente all’altezza del compito.
Sarebbe certamente interessante se trovassimo che fu un eccellente colorista in
Italia e che avesse cambiato direzione una volta rientrato in Olanda. Ma sarà da
avere chiaro che fu l’entusiasmo di Benedetto Giustiniani per la pittura ‘dal
vero’ che diede a questi artisti l’incentivo a lavorare con questo nuovo stile.
Esiste quindi una continuità tra uno dei primissimi committenti di Caravaggio e
la successiva generazione dei suoi seguaci.
“Saper ritrarre fiori, et altre cose minute”. Giustiniani, Caravaggio e la Natura Morta: una questione complessa.(di Francesca Saraceno da
www.aboutartonline.com )
[…] et il Caravaggio disse che tanta manifattura gl’era à far un quadro buono di fiori, come di figure.”
Sono le parole con cui Vincenzo Giustiniani riporta uno dei pochissimi pensieri “autografi” del Caravaggio sull’arte della pittura che egli aveva scelto come mestiere. Una frase su cui tanti studiosi di tutto il mondo si sono confrontati dandone ciascuno la propria spiegazione e che ai ‘non addetti ai lavori’ potrebbe sembrare, ad una prima lettura, anche piuttosto semplice da interpretare.
Invece la questione è piuttosto complessa e sarà forse utile ragionarci.
Innanzitutto bisogna dire che la frase in oggetto è stata estratta da un passaggio preciso di una lettera, comunemente conosciuta come il “Discorso sopra la pittura”, che il marchese Vincenzo Giustiniani inviò all’avvocato olandese Theodore van Amayden tra il 1617 e il 1618. Per la natura stessa della lettera e per le argomentazioni che vi si trovano, essa è stata considerata come una sorta di “trattato” in cui il marchese delineava quelli che a suo parere, da collezionista e conoisseur, erano i diversi livelli della pittura in ordine crescente, dal meno nobile al più nobile. Una gerarchia in dodici punti che parte dallo “spolvero”, passando per la “copia”, la “ritrattistica”, fino all’ultimo punto, il più importante, in cui si fondono la pittura “di maniera” e quella “dal naturale”.
La frase sopra citata e riferita a quello che Giustiniani dice essere il pensiero del Caravaggio, si trova al punto 5 della classifica: “saper ritrarre fiori, et altre cose minute”. E non è di poco conto il fatto che il marchese usi il termine “ritrarre” in riferimento ai fiori, perché in effetti il Caravaggio trattò sempre le sue “nature morte” esattamente alla stessa stregua delle figure umane. Giustiniani annovera tra i pittori migliori da inserire al punto 12, come summa maxima dell’abilità pittorica, Annibale Carracci, Gudo Reni e, per l’appunto, il Caravaggio. Proprio perché essi erano in grado, ciascuno con il proprio stile, di dipingere integrando la pittura di “maniera” con la resa naturalistica attraverso l’uso del colore.
Ora, per comprendere meglio il significato di quel pensiero del Caravaggio per il quale “tanta manifattura gl’era à far un quadro buono di fiori come di figure” è necessario considerare innanzitutto che il genere dei naturalia le cosiddette “nature morte”, benché a quel tempo diffusamente usate nei dipinti, non esistevano ancora come “genere pittorico” a sè stante, benché una forte tendenza in questo senso fosse già in atto, grazie alle influenze nordeuropee e fiamminghe in particolare. Si trattava piuttosto di soggetti di contorno, a corredo di un quadro di figure o di storia ma sempre con una valenza secondaria. Questo accadeva perché, fino a quel momento, l’ideale artistico era stato quello rinascimentale che vedeva l’uomo (e dunque la figura) al centro della scena pittorica, protagonista indiscusso, esaltato ancor di più dalla storia e, segnatamente, dalla storia sacra. Tutto ciò che era di contorno alla figura era considerato di minore importanza.
Dal punto di vista tecnico l’assunto era che la figura umana ponesse per l’artista un maggiore livello di difficoltà nell’essere ritratta, in quanto soggetto “animato” sottoposto inevitabilmente al movimento. E questo, soprattutto nella pittura “dal vero” con i modelli in presenza, costituiva per il pittore un evidente disagio. Al contrario le “nature morte”, ovvero oggetti, fiori, frutti, in quanto soggetti “statici”, fermi, che permettevano all’artista di ritrarli dal vero molto più agevolmente, per diverso tempo senza mai avere il problema di doverli “immaginare” o rimettere in posa, venivano eseguiti con estrema precisione e per questo riuscivano sempre maggiormente simili al vero.
Ritrarre naturalia era dunque considerato piuttosto “facile”, laddove la facilità non risiedeva tanto nella tecnica pittorica quanto nella comodità di esecuzione. Per tale ragione le nature morte, solitamente di dimensioni ridotte, avevano anche un valore di mercato notevolmente inferiore rispetto ai quadri con figure. Il più delle volte nella loro esecuzione venivano applicati apprendisti di bottega (come lo stesso Caravaggio appena arrivato a Roma) e pittori meno quotati o comunque “specializzati” in quel tipo di raffigurazioni. Tutti artisti la cui carriera difficilmente sarebbe mai decollata, anche perché le nature morte come soggetto commerciale avevano una destinazione esclusivamente privata e dunque senza alcuna eco esterna. Mentre i quadri di storia (soprattutto sacra) con figure, godevano delle committenze più prestigiose e spesso destinate alla visione pubblica.
In quest’ottica, per molti studiosi quella frase che Giustiniani attribuisce al Caravaggio vorrebbe significare l’intenzione del pittore di porre la “natura morta” sullo stesso livello della pittura di storia, religiosa o mitologica, in ogni caso ove fossero presenti figure, sovvertendo in tal modo quell’ideale rinascimentale che aveva sempre messo l’uomo al centro della scena e contribuendo così alla nascita della “natura morta” come genere pittorico vero e proprio.
In realtà tutto questo, più che “intenzione”, per lo stile di Caravaggio fu probabilmente “conseguenza”. Tant’è vero che Bellori, scrivendo parecchi anni dopo la morte del pittore, affermò che quei suoi fiori e frutti erano
“sì bene contraffatti che da lui vennero a frequentarsi a quella maggior vaghezza che tanto oggi diletta”,
dando ad intendere che da quel momento in poi le nature morte cominciarono ad andare di moda anche come soggetto unico.
Altri studiosi hanno voluto interpretare quella frase del Caravaggio come una sua volontà di valorizzare maggiormente l’aspetto pratico della pittura nell’esecuzione di un soggetto fino a quel momento considerato di scarso valore in quanto statico, rispetto al momento creativo e concettuale tipico invece della pittura di storia, che necessita di una composizione complessa e spesso di scene “in movimento”. In tal modo Caravaggio avrebbe azzerato quella gerarchia dei generi che vedeva da sempre la pittura con figure al primo posto.
Ma ad avvalorare queste tesi, come giustamente fa notare Giacomo Berra, dovrebbero essere noti nella produzione artistica del Caravaggio, molti più quadri di “natura morta” come soggetto “unico”. E invece i soli di cui abbiamo certezza sono la celeberrima “Canestra di frutta” della Pinacoteca Ambrosiana e una “Caraffa di mano del Caravaggio di palmi dua” citata nell’inventario del 21 febbraio 1627 del cardinale Francesco Maria del Monte, che però non conosciamo. Tutte le altre nature morte del Caravaggio sono inserite in dipinti con figure. Se davvero l’artista avesse voluto, con quella frase, significare la propria volontà di valorizzare questo tipo di soggetti ne avrebbe probabilmente dipinti molti di più “in solitaria”.
Invece sappiamo dai suoi biografi, e dal Bellori in particolare, che egli sembrava avere pure una certa reticenza nel dipingere fiori e frutti, soprattutto nel periodo in cui, appena arrivato a Roma, fu “dalla necessità costretto” a lavorare a bottega presso diversi pittori, dove evidentemente veniva impiegato per lo più proprio nell’esecuzione di “quadri di devozione” e appunto naturalia. Gli apprendisti o collaboratori, come già accennato, erano spesso impiegati in queste attività considerate “minori”, sia per produrre quadretti di facile commercializzazione, sia su pitture più importanti dove però le figure erano prerogativa esclusiva del “maestro”.
Pare che lo stesso Raffaello nella sua bottega avesse dei collaboratori specializzati a cui delegava la pittura di naturalia per dedicarsi, invece, personalmente alle figure. E stando a quanto dice Bellori, il Cavalier D’Arpino presso cui lavorò il Caravaggio, lo aveva proprio “applicato a dipinger fiori e frutti” con suo “gran rammarico di vedersi tolto alle figure”.
È chiaro che questo per un artista rivoluzionario come il Merisi rappresentava oggettivamente un “limite” alla sua ambizione. Non tanto per un fatto di “preferenza” di un genere pittorico piuttosto che un altro, quanto per una questione più strettamente opportunistica. Ed è forse in questo senso che va inquadrata la frase riportata dal marchese Giustiniani. Caravaggio era consapevole della sua grandezza e il timore di essere relegato ad una attività ed un ruolo secondari, lo indussero forse a chiarire il suo pensiero circa il valore da attribuire ai due generi di pittura. Se i pittori di naturalia erano considerati di “serie B” lui non voleva certo essere annoverato tra questi. Egli giustamente ambiva a più alti onori, alle commissioni pubbliche che gli avrebbero assicurato fama, gloria e lauti guadagni. E come notava qualcuno tra gli studiosi, forse non è un caso che non appena Caravaggio iniziò dipingere opere “pubbliche”, i soggetti naturalistici nei suoi dipinti diminuirono drasticamente.
Dunque con quel suo dire che “tanta manifattura gl’era à far un quadro buono di fiori, come di figure” probabilmente egli volle affermare che occorreva la stessa abilità pittorica, la stessa cura, lo stesso ingegno da parte dell’artista per ottenere un poderoso effetto “realistico” anche nell’esecuzione delle figure umane come delle nature morte.
Volendo forse “sponsorizzare” sé stesso, con quella frase ci tenne a puntualizzare che egli profondeva lo stesso impegno, lo stesso talento in entrambi i generi. Perché se è vero che i naturalia venivano sempre ritratti in maniera meticolosa, precisa, perfettamente aderenti al vero nella resa finale anche dal punto di vista coloristico, è vero pure che altrettanta “manifattura” – leggasi ‘perizia’ – era necessaria per riuscire nello stesso intento con le figure. E invece spesso nei quadri in cui erano presenti entrambi i soggetti (figure e naturalia) la differenza di esecuzione e di resa risultava evidente, con gli elementi naturali sempre molto più realistici rispetto alle figure che rimanevano invece maggiormente idealizzate. Proprio perché il pittore non vi applicava la stessa “attenzione”, sicuro che il soggetto fosse già “vincente” in quanto concettualmente protagonista.
Caravaggio invece si proponeva come artista “completo”, egualmente capace di rendere la figura umana, o comunque animata, con la stessa precisa naturalezza di un soggetto inanimato. L’artista ne diede puntuale e poderosa dimostrazione fin dai suoi primi lavori romani, ad esempio con il “Ragazzo con canestra di frutta” oggi alla Galleria Borghese, o con il “Bacco” degli Uffizi
e successivamente proprio al marchese Giustiniani con quelle due meraviglie che furono “Amore vincitore” e il “Suonatore di liuto”
dove, accanto ai soggetti “statici” e per questo perfetti, splendono di assoluto “dinamico” realismo e di altrettanta mirabile perfezione, le straordinarie figure umane del Caravaggio, ritratte dall’artista attraverso un uso sapiente e rivoluzionario del colore e della luce.
E chissà, forse in quella sua frase “ad effetto” c’era anche un’implicita punta
di sarcasmo nei confronti del divino Raffaello che si faceva dipingere fiori e
frutti dai garzoni… Mentre lui, il “genio” lombardo, faceva tutto da solo e lo
faceva incredibilmente bene.
BIBLIOGRAFIA
Giacomo Berra, E il Caravaggio disse che “tanta manifattura gl’era à fare un quadro buono di fiori, come di figure” su P. di Loreto (a cura di), L’Arte di vivere l’Arte, “Scritti in onore di Claudio Strinati” etgraphie, Roma 2018 pp. 113 – 129
Hendrick ter Brugghen e Benedetto Giustiniani: una nuova traccia per gli sviluppi del 'caravaggismo' (testo completo inglese/italiano)
«Dai
Medici ai Rothschild. Mecenati, collezionisti, filantropi». Viaggio tra
i «forzieri» di undici banchieri che nelle committenze fecero a gara anche con
il Papa. Le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Milano propongono una mostra
che indaga il ruolo di committenti, collezionisti e filantropi che molti grandi
banchieri - o famiglie di banchieri – ebbero a partire dal Rinascimento e per
tutta l’età moderna. Molti di essi furono tra i maggiori mecenati di ogni tempo;
la loro attività collezionistica e, più in generale, l’impegno a sostegno
dell’arte e della cultura, furono uno strumento strategico di rappresentazione e
di affermazione sociale che appare tuttora un esempio eloquente della sapiente
trasformazione di capitale economico in capitale culturale e simbolico. Cosimo e
Lorenzo de’ Medici, le famiglie Giustiniani e Torlonia, Enrico Mylius,
Moritz von Fries, Johann Heinrich Wilhelm Wagener, Nathaniel Mayer Rothschild,
John Pierpont Morgan: numerose opere d’arte appartenute alle loro raccolte ne
rievocano le figure, le vicende biografiche, spesso segnate da importanti
iniziative a favore della collettività, l’attività mecenatizia, le scelte
collezionistiche. Il percorso espositivo si articola in undici sezioni, ciascuna
dedicata ad una figura di banchiere. La sezione finale ricorda la luminosa
figura del banchiere “umanista” Raffaele Mattioli, protagonista della rinascita
economica e culturale nell’Italia del difficile dopoguerra.-
Milano, Gallerie d’Italia, piazza Scala 6, fino al 26 marzo 2023.
Arte e denaro: il ruolo dei banchieri nella storia dell’arte in mostra alle
Gallerie d’Italia
di Jacopo Suggi (Finestre sull'arte.info
del 26/11/2022)

 Il
trittico di Dresda di Jan Van Eych... uno stemma Giustiniani nascosto di
Noëlle L. W. Streeton
Il
trittico di Dresda di Jan Van Eych... uno stemma Giustiniani nascosto di
Noëlle L. W. Streeton
Il libro mastro di Bruges, datato 1438, offre informazioni sulle attività
finanziarie della famiglia Giustiniani di Genova e nomina Raffaello Giustiniani
come membro della famiglia con sede a Bruges. Questo articolo esplora il contesto di questa nuova prova, che offre una nuova prospettiva sulla potenziale connessione tra questa famiglia genovese e il laboratorio di Bruges di Jan van Eyck.
La Vergine col Bambino con i santi Caterina e Michele è l'unico trittico sopravvissuto identificato con Jan van Eyck (ca. 1390–1441).
La pala misura 33 x 27,5 x 5 cm. La cornice centrale reca la firma del pittore, il suo stemma, ALC IXH XAN ("così come posso"), e l'anno di completamento, 1437. Le cornici delle ali sono contraddistinte da due stemmi, uno dei quali è associato con la famiglia Giustiniani di Genova.
Dalla metà dell'Ottocento gli studiosi tedeschi hanno costantemente cercato di
chiarire il rapporto tra gli stemmi e l'immagine del donatore nel pannello di
sinistra, il ritratto in un elegante "houppelande" con cappuccio rosso,
inginocchiato direttamente davanti all'Arcangelo Michele. Ad oggi, i ricercatori
continuano a ricercare prove che possano collegare la commissione con le
attività mercantili dei Giustiniani. Lo studioso Ludwig Kaemmerer fu il primo ad affermare, alla fine del diciannovesimo secolo, che il donatore era "un
tal Michele Giustiniani, figlio di Marco, [che] visse dal 1400" identificato nel personaggio rappresento
in abiti alla moda fiamminga (come gli Arnolfini) con il cappello rosso. La recente trascrizione di un libro mastro di Bruges per la banca milanese
di Filippo Borromei ha offerto nuove promettenti informazioni. Il libro datato
1438 registra una serie di transazioni che si riferiscono direttamente alla
famiglia Giustiniani di Genova ed in particolare di un suo membro: una voce del
25 agosto 1438 si riferisce direttamente a Raffaello Giustiniani “di Bruges.
E' un tema comunque da approfondire in quanto "Raffaello" non è un nome che ricorre tra i Giustiniani di del XV secolo, piuttosto abbiamo diversi "Raffaele" impegnati in traffici internazionali.
Un decreto del governo genovese datato all’11 maggio 1517 testimonia l’impegnoi
di Nicolò e Urbano Giustiniani che esponevano al governatore Ottaviano de Campofregoso e al Consiglio degli Anziani come Benedetto Giustiniani, fratello di Urbano, avesse inviato da Chio a Battista Grillo e Costantino Cicala, mercanti genovesi operati in Bruges, due partite di denaro, una di 507 ducati e un quarto di altro ducato d’oro da grossi 75 per ducato, l’altra di 25 ducati d’oro dello stesso peso e come ora non si trovassero più nella città fiamminga né i detti Grillo e Cicala, né loro rappresentanti, che potessero riconsegnare i capitali a Urbano, incaricato della riscossione dal fratello.
Ottenevano quindi che le somme fossero consegnate agli egregi Bartolomeo Da Passano e Baliano De Fornari, mercanti genovesi residenti e negozianti a Bruges, i quali le avrebbero poi inviate a Genova all’Ufficio dei Banchi, che le avrebbe poi consegnate agli aventi diritto.
E' stata fondata a Roma il 13 settembre 2022 in occasione del 458esimo anniversario della nascita del marchese Vincenzo Giustiniani
(13 settembre 1564) un'accademia di studi a lui dedicata: l'Accademia internazionale di
lettere arti e scienze Vincenzo Giustiniani , un'associazione
culturale senza fini di lucro - Ente di Promozione Sociale (iscritta al RUNTS), nata con lo scopo statutario di ricordare la memoria dell’eclettico pensiero del
marchese Vincenzo. L’Accademia persegue esclusivamente finalità di interesse sociale:
formazione educativa, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale e bibliotecario, ricerca scientifica, organizzazione e gestione di attività culturali,
turistiche, artistiche e ricreative. Il suo scopo è quello di proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi artistico, letterari, scientifici, storici e culturali in generale, promuovendo ed incrementando gli studi e le ricerche di ogni genere, tipo e grado, con particolare riguardo a quelle sulla figura del marchese Vincenzo Giustiniani
e delle altre più rilevanti della stessa famiglia. Per informazioni e riferimenti: accademia.giustiniani@gmail.com.
 L'Accademia
internazionale di lettere arti e scienze Vincenzo Giustiniani
ha promosso il “1° Concorso Letterario Vincenzo Giustiniani 2023” con l’obiettivo di premiare romanzi brevi e poesie inedite e saggi scientifici, storici e/o artistici inediti o con alcuni contenuti inediti,
in lingua italiana riferibili: alla vita del marchese Vincenzo Giustiniani (1564-1637), ai suoi scritti (“discorsi”), alla sua collezione artistica, ai luoghi dove ha vissuto ed al contesto storico e culturale della sua epoca, oppure che facciano riferimento a questo mondo, quali ambientazioni prevalenti dell’opera, lasciando ai concorrenti la più ampia interpretazione.
L'iscrizione è gratuita, il termine per la presentazione delle opere 31 luglio 2023.
L'Accademia
internazionale di lettere arti e scienze Vincenzo Giustiniani
ha promosso il “1° Concorso Letterario Vincenzo Giustiniani 2023” con l’obiettivo di premiare romanzi brevi e poesie inedite e saggi scientifici, storici e/o artistici inediti o con alcuni contenuti inediti,
in lingua italiana riferibili: alla vita del marchese Vincenzo Giustiniani (1564-1637), ai suoi scritti (“discorsi”), alla sua collezione artistica, ai luoghi dove ha vissuto ed al contesto storico e culturale della sua epoca, oppure che facciano riferimento a questo mondo, quali ambientazioni prevalenti dell’opera, lasciando ai concorrenti la più ampia interpretazione.
L'iscrizione è gratuita, il termine per la presentazione delle opere 31 luglio 2023.
Regolamento 1° Concorso Letterario Vincenzo Giustiniani (formato PDF)
Modulo di partecipazione al 1° Concorso Letterario Vincenzo Giustiniani (formato word)
Modulo di partecipazione al 1° Concorso Letterario Vincenzo Giustiniani (formato PDF)
 Facebook - Concorso Vincenzo Giustiniani
Facebook - Concorso Vincenzo Giustiniani
Instagram - Concorso Vincenzo Giustiniani
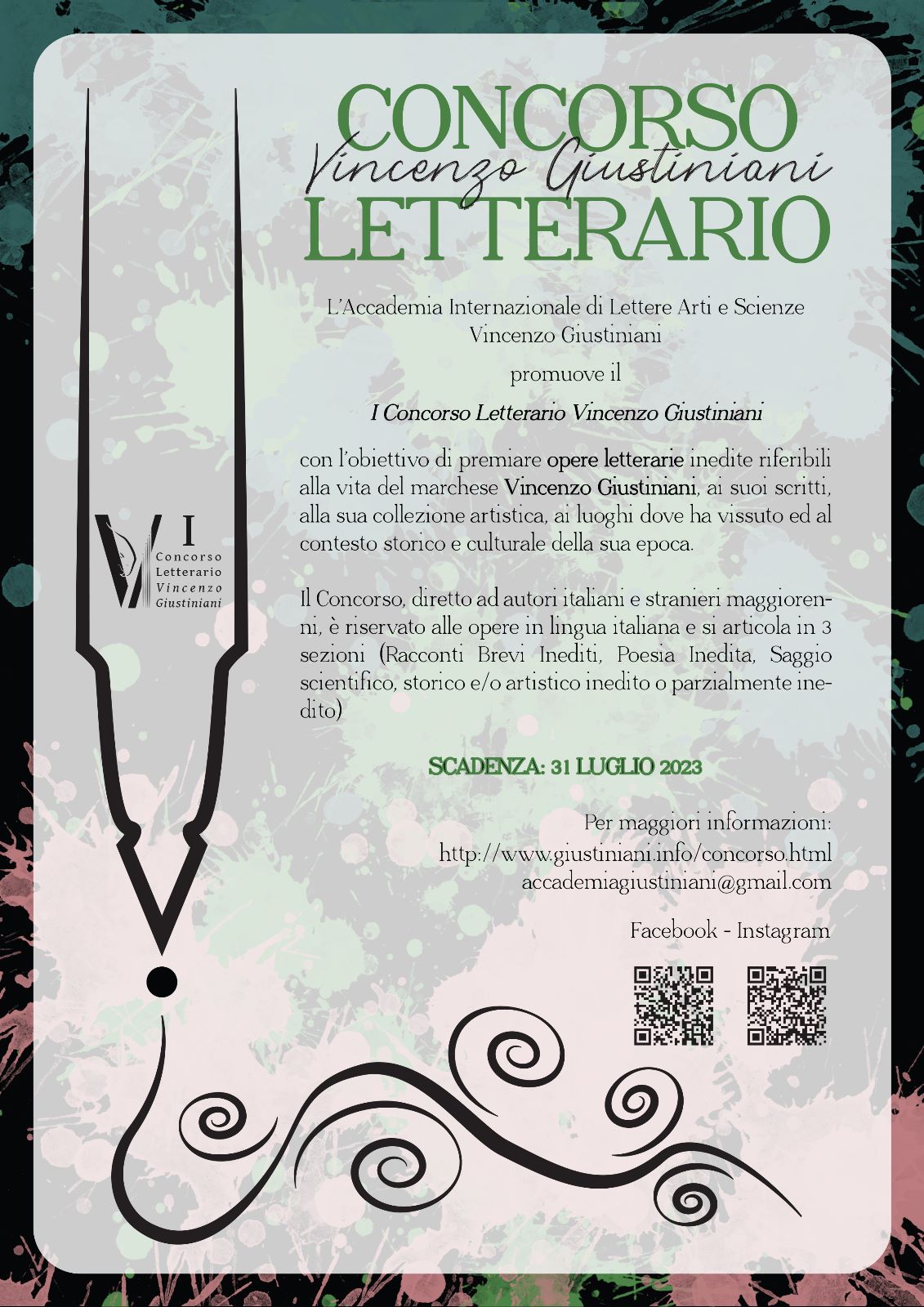

Torna alla pagina iniziale dei
Giustiniani di Genova
 Caravaggio e i Genovesi. Committenti, collezionisti, pittori
Caravaggio e i Genovesi. Committenti, collezionisti, pittori

 Alessandro, ma senza trovare nessuna soluzione soddisfacente per tutti.
Alessandro, ma senza trovare nessuna soluzione soddisfacente per tutti.
 Nella raccolta di antichità Giustiniani
ora confluita nella Collezione Torlonia anche il "Ritratto maschile, detto
Eutidemo di Battriana". Questo ritratto raffigurante un uomo dall’espressione severa, segnato da un fervido realismo, compariva come “servo pileato”, ovvero recante il pileo, berretto comunemente indossato da individui di umile estrazione. Prediligendo una diversa lettura del copricapo, simile alla kausia macedone, considerata con il diadema insegna regale e simbolo di potere a partire da Alessandro Magno, la figura
Nella raccolta di antichità Giustiniani
ora confluita nella Collezione Torlonia anche il "Ritratto maschile, detto
Eutidemo di Battriana". Questo ritratto raffigurante un uomo dall’espressione severa, segnato da un fervido realismo, compariva come “servo pileato”, ovvero recante il pileo, berretto comunemente indossato da individui di umile estrazione. Prediligendo una diversa lettura del copricapo, simile alla kausia macedone, considerata con il diadema insegna regale e simbolo di potere a partire da Alessandro Magno, la figura
 virile ritratta è stata tradizionalmente identificata con Eutidemo I, dinasta ellenistico che ha regnato sulla Battriana, terra anticamente parte dell’impero di Alessandro Magno.
virile ritratta è stata tradizionalmente identificata con Eutidemo I, dinasta ellenistico che ha regnato sulla Battriana, terra anticamente parte dell’impero di Alessandro Magno.
 Presso le sale del Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova è
stata allestita la mostra “L’antico come modello”, a cura di Giulio Sommariva e Mariangela Bruno, proposta al pubblico nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, in collaborazione con la Biblioteca Universitaria di Genova. Sono
stati esposti marmi, gessi, matrici in rame e preziose stampe conservati nel patrimonio dell’Accademia Ligustica, in sostanza gli antichi strumenti di riproduzione di opere d’arte agli albori della riproducibilità tecnica.
I calchi in gesso, insieme con incisioni di riproduzione, costituivano infatti modelli e repertori indispensabili per una didattica improntata allo studio del “bello antico” e al confronto con le opere dei grandi maestri attraverso la pratica della copia
Al centro della mostra le 42 stampe e alcune matrici in rame della “Galleria Giustiniana”:
un vero e proprio catalogo illustrato in due tomi che rappresentò il primo
esempio di un preciso programma editoriale indirizzato, da un lato, a illustrare
sculture antiche, dall’altro a magnificare la cultura e la ricchezza del
collezionista-committente.
Presso le sale del Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova è
stata allestita la mostra “L’antico come modello”, a cura di Giulio Sommariva e Mariangela Bruno, proposta al pubblico nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, in collaborazione con la Biblioteca Universitaria di Genova. Sono
stati esposti marmi, gessi, matrici in rame e preziose stampe conservati nel patrimonio dell’Accademia Ligustica, in sostanza gli antichi strumenti di riproduzione di opere d’arte agli albori della riproducibilità tecnica.
I calchi in gesso, insieme con incisioni di riproduzione, costituivano infatti modelli e repertori indispensabili per una didattica improntata allo studio del “bello antico” e al confronto con le opere dei grandi maestri attraverso la pratica della copia
Al centro della mostra le 42 stampe e alcune matrici in rame della “Galleria Giustiniana”:
un vero e proprio catalogo illustrato in due tomi che rappresentò il primo
esempio di un preciso programma editoriale indirizzato, da un lato, a illustrare
sculture antiche, dall’altro a magnificare la cultura e la ricchezza del
collezionista-committente.

 La tela, che raffigura il monaco autore della Vulgata in atteggiamento penitenziale, dal 2012 è entrata in una collezione privata vicina al nostro Paese, ed è stata restaurata da Valeria Merlini e Daniela Storti, sino a venir pubblicato nelle prossime settimane in un volume a più mani di Skira: Caravaggio.
Si trovava precedentemente a Londra, dove tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento figurava tra le proprietà dell'incisore, gioielliere, tipografo e libraio Garnet Terry, come si desume dalla scritta «Mr. G. Terry by 20», riportata a matita sul verso della tela. Calvinista, Garnet Terry è noto soprattutto per la pubblicazione di mappe geografiche e stradali. Vicino alle posizioni millenariste espresse nelle immagini di William Blake, non era un collezionista d'arte, ma la tolleranza religiosa di San Girolamo può averlo spinto ad acquistare un dipinto raffigurante il presbitero, la cui immagine all'epoca in Inghilterra era molto conosciuta anche in ragione della circolazione di una stampa di Hamilton che riproduce un dipinto di Guido Reni ora alla National Gallery.
Il dipinto ora attribuito a Caravaggio raffigura il santo in piedi, visibile dalle ginocchia in su, mentre si appoggia con la mano sinistra a un libro, su di un altare improvvisato. Un altro libro, forse la stessa Vulgata, è poggiato a fianco, e un terzo fa da supporto a un crocifisso, su cui Girolamo è piegato in atto di contrizione, mentre si percuote il petto con una pietra. Di fronte al mistero della morte di Cristo per lo studioso anche l'esercizio intellettuale non è altro che Vanitas: libro e crocifisso sono appoggiati a un teschio. È una sorta di estrema raffinazione dell'iconografia gerominiana in chiave ascetica. Non siamo ancora sul terreno dei Girolamo visionari e allampanati di Ribera: il tono è infatti quello delle cupe meditazioni a cui Caravaggio si abbandona nell'estate del 1606, dopo la fuga da Roma per l'assassinio in duello di Ranuccio Tommasoni. Spiega Mario Marubbi, che firma l'attribuzione: «La stesura veloce lascia supporre una datazione quanto meno successiva all'abbandono di Roma. Le stesure di colore mi ricordano il San Francesco in Meditazione della Pinacoteca Ala Ponzone di Cremona. Ci sono affinità sia con il periodo napoletano che con l'attività a Malta e addirittura si colgono elementi di continuità con l'opera estrema. Tuttavia la pastosità della materia cromatica e il colore ancora squillante fanno propendere per una datazione leggermente precedente. Occorre ricordare che siamo soliti suddividere l'attività del Merisi a seconda delle sue dislocazioni, ma in realtà tra una fase e l'altra dal punto di vista cronologico intercorrono pochi mesi. Per esempio ci sono rapporti molto stretti tra questo San Girolamo e La negazione di Pietro, che è ritenuta del 1609, con l'Adorazione dei Pastori di Messina, ma anche con il primo periodo napoletano».
Le evidenze tecniche sono numerosissime: dalle incisioni a definire la collocazione del braccio sinistro, simili a quelle del San Giovannino Corsini, alla resa dei panneggi a fitte pieghe che virano dal bianco luminoso al bianco cenere, come nella già citata Negazione di Pietro, sino all'uso di una preparazione rosso-brunastra funzionale alla pittura a risparmio e a sorprendenti pentimenti, come sottolineato nel contributo di Claudio Falcucci. Sul piano stilistico, il particolare più sorprendente è forse la modalità esecutiva del chiodo infisso nel palmo della mano del crocifisso, che è dotato di una larga testa piramidale, esattamente come nel San Girolamo dipinto a Malta per Ippolito Malaspina.
Il primo effetto di quest'inedito è di far finalmente giustizia dell'identificazione del San Girolamo segnalato negli inventari Giustiniani con il dipinto presente nel Museo di Montserrat. Sulla scorta dell'attribuzione fatta a suo tempo da Maurizio Marini del 1973, che lo collegò alla collezione della famiglia romana, il quadro del monastero spagnolo è stato introdotto anche nel catalogo ristretto degli autografi certi alla mostra milanese Dentro Caravaggio del 2017. Gli stessi studiosi che avevano lavorato a quella monografica ammisero che la tela presentava diversi problemi (non ultimo che il santo fosse in meditazione e non in preghiera), ora conclamati dalla emersione di un dipinto che si adatta per iconografia in maniera molto più stringente alla descrizione che l'abate Silos ci ha lasciato nel 1673 del dipinto Giustiniani: «Sua prima occupazione è quella di estinguere l'ira divina/ con la penitenza, battendosi il petto con una pesante pietra». Marini riportava le misure del dipinto spagnolo in 110x81, mentre esse sono in realtà 140x101,5 cm (ben eccedenti quelle segnalate nell'inventario). Trenta centimetri di differenza che hanno prodotto un errore di 46 anni: il nuovo San Girolamo è giudicato incompatibile (per uno scarto di misure assai minore) con quello Giustiniani, ma ci riporta sulla strada giusta, perché è probabilmente una seconda versione di quello, dipinta a Napoli per la famiglia Mastrillo dei duchi di San Marzano. Abbiamo infatti un documento di pagamento del figlio del marchese, Gerolamo Juniore, che il 28 aprile 1607 versa al Caravaggio 30 ducati del Banco dello Spirito Santo «a compimento di un quadro con l'Imagine di San Geronimo che li ha fatto e consegnato atteso il remanente con(tanti) e per lui a Gio. Battista Caracciolo».
Com'è arrivato poi questo dipinto a Londra? La collezione Mastrillo confluì in quella dei Ceva Grimaldi, in cui il pittore Giuseppe Bonito ci segnala la presenza di ben tre San Girolamo, due inediti e uno di Ludovico Carracci. È lui stesso a rilevare il quadro, per 25 ducati, la stessa cifra pagata per una Historia del Buon Samaritano ritenuta del Caravaggio. Bonito deve poi aver ceduto l'opera sul mercato, in tempi vicini al suo passaggio in Inghilterra, e di qui nella raccolta dell'incisore Terry
La tela, che raffigura il monaco autore della Vulgata in atteggiamento penitenziale, dal 2012 è entrata in una collezione privata vicina al nostro Paese, ed è stata restaurata da Valeria Merlini e Daniela Storti, sino a venir pubblicato nelle prossime settimane in un volume a più mani di Skira: Caravaggio.
Si trovava precedentemente a Londra, dove tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento figurava tra le proprietà dell'incisore, gioielliere, tipografo e libraio Garnet Terry, come si desume dalla scritta «Mr. G. Terry by 20», riportata a matita sul verso della tela. Calvinista, Garnet Terry è noto soprattutto per la pubblicazione di mappe geografiche e stradali. Vicino alle posizioni millenariste espresse nelle immagini di William Blake, non era un collezionista d'arte, ma la tolleranza religiosa di San Girolamo può averlo spinto ad acquistare un dipinto raffigurante il presbitero, la cui immagine all'epoca in Inghilterra era molto conosciuta anche in ragione della circolazione di una stampa di Hamilton che riproduce un dipinto di Guido Reni ora alla National Gallery.
Il dipinto ora attribuito a Caravaggio raffigura il santo in piedi, visibile dalle ginocchia in su, mentre si appoggia con la mano sinistra a un libro, su di un altare improvvisato. Un altro libro, forse la stessa Vulgata, è poggiato a fianco, e un terzo fa da supporto a un crocifisso, su cui Girolamo è piegato in atto di contrizione, mentre si percuote il petto con una pietra. Di fronte al mistero della morte di Cristo per lo studioso anche l'esercizio intellettuale non è altro che Vanitas: libro e crocifisso sono appoggiati a un teschio. È una sorta di estrema raffinazione dell'iconografia gerominiana in chiave ascetica. Non siamo ancora sul terreno dei Girolamo visionari e allampanati di Ribera: il tono è infatti quello delle cupe meditazioni a cui Caravaggio si abbandona nell'estate del 1606, dopo la fuga da Roma per l'assassinio in duello di Ranuccio Tommasoni. Spiega Mario Marubbi, che firma l'attribuzione: «La stesura veloce lascia supporre una datazione quanto meno successiva all'abbandono di Roma. Le stesure di colore mi ricordano il San Francesco in Meditazione della Pinacoteca Ala Ponzone di Cremona. Ci sono affinità sia con il periodo napoletano che con l'attività a Malta e addirittura si colgono elementi di continuità con l'opera estrema. Tuttavia la pastosità della materia cromatica e il colore ancora squillante fanno propendere per una datazione leggermente precedente. Occorre ricordare che siamo soliti suddividere l'attività del Merisi a seconda delle sue dislocazioni, ma in realtà tra una fase e l'altra dal punto di vista cronologico intercorrono pochi mesi. Per esempio ci sono rapporti molto stretti tra questo San Girolamo e La negazione di Pietro, che è ritenuta del 1609, con l'Adorazione dei Pastori di Messina, ma anche con il primo periodo napoletano».
Le evidenze tecniche sono numerosissime: dalle incisioni a definire la collocazione del braccio sinistro, simili a quelle del San Giovannino Corsini, alla resa dei panneggi a fitte pieghe che virano dal bianco luminoso al bianco cenere, come nella già citata Negazione di Pietro, sino all'uso di una preparazione rosso-brunastra funzionale alla pittura a risparmio e a sorprendenti pentimenti, come sottolineato nel contributo di Claudio Falcucci. Sul piano stilistico, il particolare più sorprendente è forse la modalità esecutiva del chiodo infisso nel palmo della mano del crocifisso, che è dotato di una larga testa piramidale, esattamente come nel San Girolamo dipinto a Malta per Ippolito Malaspina.
Il primo effetto di quest'inedito è di far finalmente giustizia dell'identificazione del San Girolamo segnalato negli inventari Giustiniani con il dipinto presente nel Museo di Montserrat. Sulla scorta dell'attribuzione fatta a suo tempo da Maurizio Marini del 1973, che lo collegò alla collezione della famiglia romana, il quadro del monastero spagnolo è stato introdotto anche nel catalogo ristretto degli autografi certi alla mostra milanese Dentro Caravaggio del 2017. Gli stessi studiosi che avevano lavorato a quella monografica ammisero che la tela presentava diversi problemi (non ultimo che il santo fosse in meditazione e non in preghiera), ora conclamati dalla emersione di un dipinto che si adatta per iconografia in maniera molto più stringente alla descrizione che l'abate Silos ci ha lasciato nel 1673 del dipinto Giustiniani: «Sua prima occupazione è quella di estinguere l'ira divina/ con la penitenza, battendosi il petto con una pesante pietra». Marini riportava le misure del dipinto spagnolo in 110x81, mentre esse sono in realtà 140x101,5 cm (ben eccedenti quelle segnalate nell'inventario). Trenta centimetri di differenza che hanno prodotto un errore di 46 anni: il nuovo San Girolamo è giudicato incompatibile (per uno scarto di misure assai minore) con quello Giustiniani, ma ci riporta sulla strada giusta, perché è probabilmente una seconda versione di quello, dipinta a Napoli per la famiglia Mastrillo dei duchi di San Marzano. Abbiamo infatti un documento di pagamento del figlio del marchese, Gerolamo Juniore, che il 28 aprile 1607 versa al Caravaggio 30 ducati del Banco dello Spirito Santo «a compimento di un quadro con l'Imagine di San Geronimo che li ha fatto e consegnato atteso il remanente con(tanti) e per lui a Gio. Battista Caracciolo».
Com'è arrivato poi questo dipinto a Londra? La collezione Mastrillo confluì in quella dei Ceva Grimaldi, in cui il pittore Giuseppe Bonito ci segnala la presenza di ben tre San Girolamo, due inediti e uno di Ludovico Carracci. È lui stesso a rilevare il quadro, per 25 ducati, la stessa cifra pagata per una Historia del Buon Samaritano ritenuta del Caravaggio. Bonito deve poi aver ceduto l'opera sul mercato, in tempi vicini al suo passaggio in Inghilterra, e di qui nella raccolta dell'incisore Terry
 Passeggiando nei giardini del Quirinale, in occasione della celebrazione della ricorrenza del 2 giugno, rievocavo con il consigliere di Stato Damiano Nocilla, già segretario generale del Senato, il successo della mostra «Caravaggio e i Giustiniani» che si inaugurò nel gennaio 2001 a Palazzo Giustiniani con una coda di folla che arrivava fino al Pantheon. Io stessa, che avevo dedicato alle ricerche necessarie alcuni anni della mia vita, ero incredula e, certo, felice. Il padrone di casa era il presidente del Senato di allora, Nicola Mancino. L'esposizione riportava nella sede originaria capolavori dell'antica collezione Giustiniani dispersi in vari musei del mondo. La qualità delle opere riunite – e non mancarono le scoperte, come una statua di Michelangelo inedita nota solo attraverso le fonti – rivelava il gusto raffinato e colto di Benedetto e Vincenzo Giustiniani. Cercai di lasciar parlare i due collezionisti, e di ricostruire quella magica commistione, evidente nella prima e nella seconda stanza dei quadri antichi (descritte dagli inventari), fra artisti del '400 e del '500, e pittori viventi, scelti con estremo rigore qualitativo.
Michelangelo Merisi detto Caravaggio era ammesso interamente nell'Olimpo voluto e pensato dal marchese Vincenzo. I suoi dipinti sono elencati in questo prestigioso contesto: per i Giustiniani il maestro aveva dipinto capolavori come L'amore vincitore (Berlino, Gemälde Galerie) o L'incredulità di S. Tommaso (Potsdam, Bildergalerie von Sanssouci). I Caravaggio dei Giustiniani erano ben quindici, ma ce ne sono pervenuti solo cinque. Altri tre (S. Matteo con l'angelo, Cristo nell'orto, Fillide) sono stati distrutti (oppure sono spariti) a Berlino alla fine della Seconda guerra mondiale, e li conosciamo solo in fotografia. I rimanenti quadri sono un autentico chiodo fisso per noi studiosi: non muore mai la speranza che improvvisamente riaffiorino da qualche parte.
Oltre un anno fa, nel maggio 2010, mi venne sottoposto un dipinto inedito, raffigurante S. Agostino, emerso da una collezione privata spagnola. Mi resi conto che si trattava dell'opera di Caravaggio descritta negli inventari redatti personalmente da Vincenzo Giustiniani e trascritti dal notaio nel 1638: «Un quadro d'una mezza figura di Sant'Agostino depinto in tela alta palmi 5. e 1/2 e larga 4. 1/2 incirca di mano di Michelangelo da Caravaggio con sua cornice negra» conservato nella prima stanza dei quadri antichi. Questo quadro rimase nella collezione Giustiniani per secoli, menzionato in tutti gli inventari successivi fino alla vendita, avvenuta fra il 1857 e il 1862.
Sovente vengono compiute attribuzioni e identificazioni attraverso il confronto con inventari di antiche collezioni. Ma il nesso è spesso molto aleatorio. Non in questo caso. Un'etichetta in pergamena posta sul retro del telaio costituisce una connessione inequivocabile. La scritta su di essa non era di immediata comprensione, ma per fortuna il secondo dei tre volumi da me pubblicati nel 2003 presso Einaudi, contenenti tutti gli inventari della collezione e redatti in varie epoche, mi ha offerto la spiegazione. Le parole scritte sull'etichetta forse dalla mano del collezionista spagnolo che acquistò il S. Agostino sono precisamente queste: «Procedencia del Marqués Recanelli en la calle del gobierno». Si tratta del marchese Pantaleo Vincenzo Giustiniani Recanelli, il quale nel 1857 era divenuto, dopo una lunga causa, l'erede legale dei resti della collezione Giustiniani (la parte maggiore era già stata venduta nel 1815 al re di Prussia) e si era insediato nell'antico palazzo. Il termine spagnolo «calle del gobierno» è la traduzione di Via del Governo, ossia l'indirizzo di allora (al n. 38) di Palazzo Giustiniani (la strada ha cambiato nome, e oggi si chiama via della Dogana vecchia). L'indirizzo «Via del Governo» compare nell'avviso a stampa della pubblica asta «di quadri antichi appartenenti alla Galleria dell'ecc.mo Patrimonio Giustiniani», datato 13 aprile 1859.
Dunque è fuor di dubbio che questo quadro provenga direttamente dall'antica collezione dei Giustiniani. Ma dopo aver descritto il percorso documentario, vorrei parlare del dipinto, quale esso ci appare, dopo una pulitura resa necessaria da ossidazioni e da una patina scura che velava la superficie. Questa velatura mi fece sospettare che ci fosse lo zampino di Margherita Bernini, una restauratrice che – presentata dal pittore Pietro Angeletti, autore dell'inventario della collezione Giustiniani del 1793 – attorno al 1788 aveva trattato molti quadri della collezione Giustiniani con quella che lei chiamava la «magica manteca», ossia un beverone a base di chiara d'uovo da spennellare sulla tela, che lasciava una traccia non priva di colature e che sarebbe assai ingiallita negli anni. Il 1788 era il momento della polemica condotta da Filippo Hackert sul «Giornale delle Belle Arti» contro l'uso della vernice sulle pitture, e in quell'occasione la Bernini fece i suoi esperimenti. Il suo "trattamento" l'avevo già rilevato, ad esempio, nella serie degli Apostoli di Francesco Albani, proveniente dalla collezione Giustiniani (che ritrovai nella Moritzkirche di Naumburg, lì esiliati da Wilhelm von Bode, direttore dei Musei di Berlino), e quindi mi saltò immediatamente agli occhi nell'atto di esaminare il S. Agostino prima della sua pulitura. Le radiografie e riflettografie, eseguite nel 2010 dallo Hamilton Kerr Institute di Cambridge, hanno altresì rivelato numerosi, piccoli pentimenti, fra cui uno assai tipico di Caravaggio, lo spostamento dell'orecchio di un centimetro più a sinistra. Si nota la tecnica di Caravaggio nel lasciar affiorare la preparazione bruna fra campiture di colore diverse, come scrive il Bellori: «Lasciò in mezze tinte l'imprimitura della tela». Il restauro ci ha restituito dei colori delicatissimi, caratteristici delle opere del Merisi anteriori al 1600, un'estrema precisione nelle masse e nei contorni e una sapiente orchestrazione dei piani spaziali e dei valori ottici.
Passeggiando nei giardini del Quirinale, in occasione della celebrazione della ricorrenza del 2 giugno, rievocavo con il consigliere di Stato Damiano Nocilla, già segretario generale del Senato, il successo della mostra «Caravaggio e i Giustiniani» che si inaugurò nel gennaio 2001 a Palazzo Giustiniani con una coda di folla che arrivava fino al Pantheon. Io stessa, che avevo dedicato alle ricerche necessarie alcuni anni della mia vita, ero incredula e, certo, felice. Il padrone di casa era il presidente del Senato di allora, Nicola Mancino. L'esposizione riportava nella sede originaria capolavori dell'antica collezione Giustiniani dispersi in vari musei del mondo. La qualità delle opere riunite – e non mancarono le scoperte, come una statua di Michelangelo inedita nota solo attraverso le fonti – rivelava il gusto raffinato e colto di Benedetto e Vincenzo Giustiniani. Cercai di lasciar parlare i due collezionisti, e di ricostruire quella magica commistione, evidente nella prima e nella seconda stanza dei quadri antichi (descritte dagli inventari), fra artisti del '400 e del '500, e pittori viventi, scelti con estremo rigore qualitativo.
Michelangelo Merisi detto Caravaggio era ammesso interamente nell'Olimpo voluto e pensato dal marchese Vincenzo. I suoi dipinti sono elencati in questo prestigioso contesto: per i Giustiniani il maestro aveva dipinto capolavori come L'amore vincitore (Berlino, Gemälde Galerie) o L'incredulità di S. Tommaso (Potsdam, Bildergalerie von Sanssouci). I Caravaggio dei Giustiniani erano ben quindici, ma ce ne sono pervenuti solo cinque. Altri tre (S. Matteo con l'angelo, Cristo nell'orto, Fillide) sono stati distrutti (oppure sono spariti) a Berlino alla fine della Seconda guerra mondiale, e li conosciamo solo in fotografia. I rimanenti quadri sono un autentico chiodo fisso per noi studiosi: non muore mai la speranza che improvvisamente riaffiorino da qualche parte.
Oltre un anno fa, nel maggio 2010, mi venne sottoposto un dipinto inedito, raffigurante S. Agostino, emerso da una collezione privata spagnola. Mi resi conto che si trattava dell'opera di Caravaggio descritta negli inventari redatti personalmente da Vincenzo Giustiniani e trascritti dal notaio nel 1638: «Un quadro d'una mezza figura di Sant'Agostino depinto in tela alta palmi 5. e 1/2 e larga 4. 1/2 incirca di mano di Michelangelo da Caravaggio con sua cornice negra» conservato nella prima stanza dei quadri antichi. Questo quadro rimase nella collezione Giustiniani per secoli, menzionato in tutti gli inventari successivi fino alla vendita, avvenuta fra il 1857 e il 1862.
Sovente vengono compiute attribuzioni e identificazioni attraverso il confronto con inventari di antiche collezioni. Ma il nesso è spesso molto aleatorio. Non in questo caso. Un'etichetta in pergamena posta sul retro del telaio costituisce una connessione inequivocabile. La scritta su di essa non era di immediata comprensione, ma per fortuna il secondo dei tre volumi da me pubblicati nel 2003 presso Einaudi, contenenti tutti gli inventari della collezione e redatti in varie epoche, mi ha offerto la spiegazione. Le parole scritte sull'etichetta forse dalla mano del collezionista spagnolo che acquistò il S. Agostino sono precisamente queste: «Procedencia del Marqués Recanelli en la calle del gobierno». Si tratta del marchese Pantaleo Vincenzo Giustiniani Recanelli, il quale nel 1857 era divenuto, dopo una lunga causa, l'erede legale dei resti della collezione Giustiniani (la parte maggiore era già stata venduta nel 1815 al re di Prussia) e si era insediato nell'antico palazzo. Il termine spagnolo «calle del gobierno» è la traduzione di Via del Governo, ossia l'indirizzo di allora (al n. 38) di Palazzo Giustiniani (la strada ha cambiato nome, e oggi si chiama via della Dogana vecchia). L'indirizzo «Via del Governo» compare nell'avviso a stampa della pubblica asta «di quadri antichi appartenenti alla Galleria dell'ecc.mo Patrimonio Giustiniani», datato 13 aprile 1859.
Dunque è fuor di dubbio che questo quadro provenga direttamente dall'antica collezione dei Giustiniani. Ma dopo aver descritto il percorso documentario, vorrei parlare del dipinto, quale esso ci appare, dopo una pulitura resa necessaria da ossidazioni e da una patina scura che velava la superficie. Questa velatura mi fece sospettare che ci fosse lo zampino di Margherita Bernini, una restauratrice che – presentata dal pittore Pietro Angeletti, autore dell'inventario della collezione Giustiniani del 1793 – attorno al 1788 aveva trattato molti quadri della collezione Giustiniani con quella che lei chiamava la «magica manteca», ossia un beverone a base di chiara d'uovo da spennellare sulla tela, che lasciava una traccia non priva di colature e che sarebbe assai ingiallita negli anni. Il 1788 era il momento della polemica condotta da Filippo Hackert sul «Giornale delle Belle Arti» contro l'uso della vernice sulle pitture, e in quell'occasione la Bernini fece i suoi esperimenti. Il suo "trattamento" l'avevo già rilevato, ad esempio, nella serie degli Apostoli di Francesco Albani, proveniente dalla collezione Giustiniani (che ritrovai nella Moritzkirche di Naumburg, lì esiliati da Wilhelm von Bode, direttore dei Musei di Berlino), e quindi mi saltò immediatamente agli occhi nell'atto di esaminare il S. Agostino prima della sua pulitura. Le radiografie e riflettografie, eseguite nel 2010 dallo Hamilton Kerr Institute di Cambridge, hanno altresì rivelato numerosi, piccoli pentimenti, fra cui uno assai tipico di Caravaggio, lo spostamento dell'orecchio di un centimetro più a sinistra. Si nota la tecnica di Caravaggio nel lasciar affiorare la preparazione bruna fra campiture di colore diverse, come scrive il Bellori: «Lasciò in mezze tinte l'imprimitura della tela». Il restauro ci ha restituito dei colori delicatissimi, caratteristici delle opere del Merisi anteriori al 1600, un'estrema precisione nelle masse e nei contorni e una sapiente orchestrazione dei piani spaziali e dei valori ottici.
 Vedersi sfilare dieci milioni di sterline, vale a dire quei 13 milioni di euro che vale l’olio su tela del Caravaggio dal titolo «I bari», è un brutto colpo. Ma il discendente di uno stimato chirurgo della Royal Navy, Lancelot William Thwaytes, un po’ se l’è andata a cercare. Quando hai in mano qualcosa che sospetti possa essere un tesoro sarebbe meglio ascoltare non dieci ma cento, e forse più, esperti prima di metterlo all’asta. Rientrarne poi in possesso è impossibile. Ed è pure impossibile, ciò hanno stabilito i giudici dell’Alta corte londinese, chiedere i danni a chi non è stato in grado di attribuire il capolavoro al suo grande, unico e vero maestro, Michelangelo Merisi.
Vedersi sfilare dieci milioni di sterline, vale a dire quei 13 milioni di euro che vale l’olio su tela del Caravaggio dal titolo «I bari», è un brutto colpo. Ma il discendente di uno stimato chirurgo della Royal Navy, Lancelot William Thwaytes, un po’ se l’è andata a cercare. Quando hai in mano qualcosa che sospetti possa essere un tesoro sarebbe meglio ascoltare non dieci ma cento, e forse più, esperti prima di metterlo all’asta. Rientrarne poi in possesso è impossibile. Ed è pure impossibile, ciò hanno stabilito i giudici dell’Alta corte londinese, chiedere i danni a chi non è stato in grado di attribuire il capolavoro al suo grande, unico e vero maestro, Michelangelo Merisi.





 L'Accademia
internazionale di lettere arti e scienze Vincenzo Giustiniani
ha promosso il “1° Concorso Letterario Vincenzo Giustiniani 2023” con l’obiettivo di premiare romanzi brevi e poesie inedite e saggi scientifici, storici e/o artistici inediti o con alcuni contenuti inediti,
in lingua italiana riferibili: alla vita del marchese Vincenzo Giustiniani (1564-1637), ai suoi scritti (“discorsi”), alla sua collezione artistica, ai luoghi dove ha vissuto ed al contesto storico e culturale della sua epoca, oppure che facciano riferimento a questo mondo, quali ambientazioni prevalenti dell’opera, lasciando ai concorrenti la più ampia interpretazione.
L'iscrizione è gratuita, il termine per la presentazione delle opere 31 luglio 2023.
L'Accademia
internazionale di lettere arti e scienze Vincenzo Giustiniani
ha promosso il “1° Concorso Letterario Vincenzo Giustiniani 2023” con l’obiettivo di premiare romanzi brevi e poesie inedite e saggi scientifici, storici e/o artistici inediti o con alcuni contenuti inediti,
in lingua italiana riferibili: alla vita del marchese Vincenzo Giustiniani (1564-1637), ai suoi scritti (“discorsi”), alla sua collezione artistica, ai luoghi dove ha vissuto ed al contesto storico e culturale della sua epoca, oppure che facciano riferimento a questo mondo, quali ambientazioni prevalenti dell’opera, lasciando ai concorrenti la più ampia interpretazione.
L'iscrizione è gratuita, il termine per la presentazione delle opere 31 luglio 2023. Facebook - Concorso Vincenzo Giustiniani
Facebook - Concorso Vincenzo Giustiniani