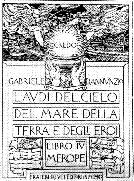
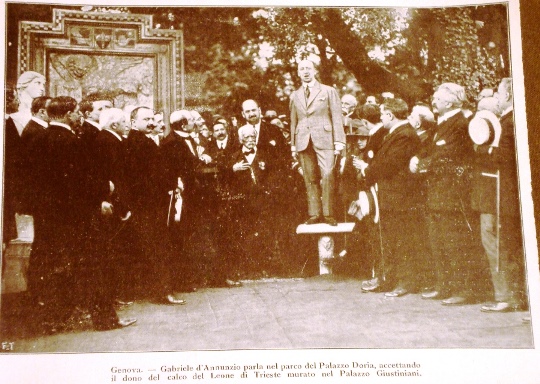
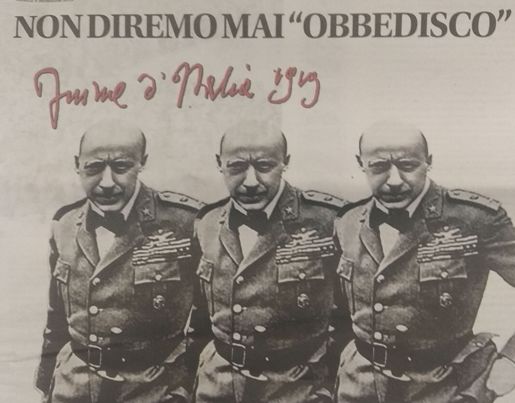
Il celebre Gabriele D’Annunzio cita i Giustiniani in due sue opere: Merope ed il
Piacere
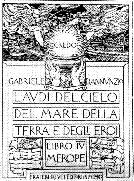
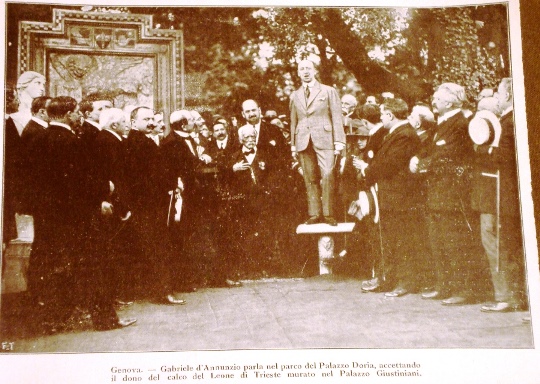
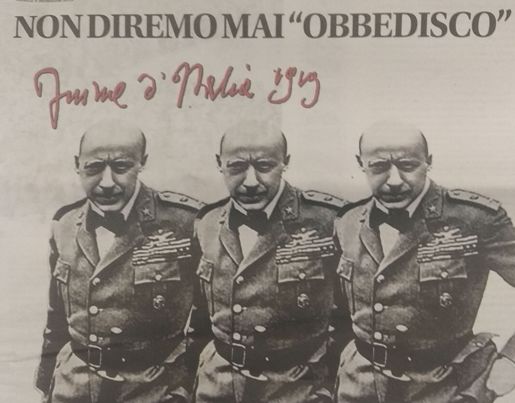
Le Laudi costituiscono l'opera poetica più notevole e più famosa di
D'Annunzio; doveva essere costituita da 7 libri, quante sono le Pleiadi; consta invece di
soli 4 libri (o di 5, se si include il libro di Asterope). Il primo libro, Maia (Canto
amèbeo della guerra), fu composto nel 1903 e pubblicato nello stesso anno; il
sottotitolo, Laus Vitae, ne chiarisce i motivi ispiratori: una vitalistica celebrazione
dell'energia vitale; un naturalismo pagano impreziosito dai riferimenti classici e
mitologici. Il secondo libro, Elettra, composto tra il 1899 e il 1902 e pubblicato nel
1903, celebra gli eroi della patria (Notte di Caprera) e dell'arte (Per la morte di
Giuseppe Verdi); nella terza parte sono cantate 25 "Città del silenzio"
(Ferrara, Ravenna ecc.); nella quarta è il famoso Canto augurale per la Nazione eletta,
che infiammò; di entusiasmo i nazionalisti. Il terzo libro, Alcyone, fu pubblicato
assieme al secondo e contiene per acquisito giudizio il meglio del D'Annunzio poeta ( La
pioggia nel pineto, La sera fiesolana,Stabat nuda Aestas). Il quarto libro, Merope,
raccoglie i canti celebrativi della conquista della Libia composti ad Arcachon, pubblicati
dapprima sul "Corriere della Sera" e poi in volume nel 1912. Vengono considerati
una continuazione di questi quattro libri i Canti della guerra latina, composti e
pubblicati tra il 1914 ed il 1918 (costituiranno, in seguito, il volume intitolato
Asterope, La canzone del Quarnaro).
MEROPE Così veda tu un giorno il mare latino coprirsi di strage alla tua guerra e per le
tue corone piegarsi i tuoi lauri e i tuoi mirti, o Semprerinascente, o fiore di tutte le
stirpi, aroma di tutta la terra, Italia, Italia, sacra alla nuova Aurora con l'aratro e la
prora! Canto augurale per la nazione eletta [1901] ….. Ecco, o Mediterraneo, su tutte
l'isole, ecco i tuoi dèspoti. Rischiaro col mio cuore le impronte non distrutte. Ecco un
Sagredo principe di Paro, a Sèrifo un Michiel, ad Andro un Dandolo, a Candia un Tiepolo.
Ogni nome è un faro. Presso Blacherne publica il suo bando Ranieri Zeno, e quasi
Imperatore ha tutta Romania nel suo comando. Il genovese Enrico Pescatore conte di Malta
usurpa il fio di Creta. In regia potestà l'Asia Minore ha Martin Zaccaria, batte moneta,
leva milizie e navi, si travaglia a Focea per allume, a Chio per seta, a traffico
imperversa e a rappresaglia, stermina Catalani e Musulmani, tutt'armato da re muore in
battaglia.
O dura schiatta dei Giustiniani, nova sovranità della Maona libera, dinastia di
popolani magnifici, di re senza corona, che profuman di mastice la bianca scìa o la
segnan d'una rossa zona, quando nell'isola Andriolo Banca orna templi, deduce carmi,
venera Omero, èduca lauri, schiavi affranca! Navi d'Italia, ecco l'Egeo. Chi viene da
Lesbo? chi da Coo? Navi d'Italia, l'Ombre cantano come le sirene.
La canzone dei Dardanelli
Questa Canzone fu composta quando gli informatori descrivevano la ragunata delle navi nel
porto di Taranto. «Sin da ieri è un continuo passaggio di torpediniere nel Canale
navigabile. Hanno tutte all'albero maestro la fiamma di guerra. Il Mar Piccolo sembra un
immenso lago dove galleggiano in gran numero navi di battaglia, torpediniere e
cacciatorpediniere. Ve ne sono ormeggiate lungo tutte le banchine, e nell'arsenale e nello
specchio d'acqua del primo bacino, ch'è nel Mar Piccolo il più vasto, riparo sicurissimo
ed inespugnabile, unico in tutto il mondo (17 novembre).» Questa notizia era
immediatamente seguita da quest'altra, in vistosi caratteri: «La flotta non è ai
Dardanelli».
L'episodio della battaglia sostenuta dai quattro legni cristiani contro l'intera armata di
Maometto II, sotto le mura di Costantinopoli, è narrato nelle Croniche di Giorgio Dolfino
e di Niccolò Barbaro che ne fu testimonio, e nella Cronica di Costantinopoli del greco
Giorgio Phranzes, il quale anche assistette alla fazione. I quattro legni, venendo dal Mar
di Marinara, portavano viveri e munizioni all'imperatore assediato. Pei contrarii vènti,
avevan cappeggiato a lungo nei paraggi di Chio; cosicché, favoriti alfine dall'Ostro,
entravano nell'Ellesponto e s'appressavano al Bosforo quando già tutta la città era
stretta. Come l'armata turca li avvistò, il sultano diede ordine all'ammiraglio di
assalirli con tutte le forze e di catturarli o di colarli a picco. Suleyman bey salpò con
circa duecento vascelli (a centoquarantacinque li riduce uno dei cronisti); innanzi l'ora
di nona incontrò i quattro legni sotto le mura, propriamente fra le Sette-Torri e i
giardini di Blanca. In quel punto il vento cadde, cosicché i Cristiani perdettero il
vantaggio. Tuttavia si prepararono a combattere. Combattimento ineguale e portentoso, d'un
naviglio sottilissimo contro il grosso dell'armata ottomana. Allo spettacolo accorse su le
mura, dalla parte della Propontide, la moltitudine degli assediati, e lo stesso
Costantino. Su la riva, fuor della cerchia, presso il promontorio di Zeitun, a breve
distanza dalle Sette-Torri, accorsero i Turchi, e lo stesso sultano a cavallo per godere
della prima vittoria. Il cielo era sereno su tutto il Bosforo. Prima parlarono i mortai e
le bombarde; poi un de' legni cristiani e la galeazza di Suleyman vennero all'arrembaggio
per prua e rimasero conficcati per prua l'uno nell'altra. Intorno s'accalcarono le navi
turche. E le tre genovesi nell'investimento persero l'uso dei remi. Allora i ponti
accostati furono il campo d'una mischia feroce. Con le pietre pugnerecce e coi fuochi
lavorati i nostri opposero una così fiera difesa che, dopo tre ore di combattimento, le
sorti parvero volgere in lor favore. Gran numero di navi turche ardeva già; cresceva la
strage. I nostri, eccitati dai clamori che ventavano dalle mura, parevano moltiplicarsi
mentre su l'armata nemica già soffiava il panico. Allora Maometto, furibondo, imprecando
alla viltà de' suoi come per minacciarli e ricacciarli avanti, si lanciò a cavallo nel
mare e spinse la bestia sul bassofondo, con l'acqua sino al pettorale. Atterriti tornarono
all'assalto coloro che l'atroce conquistatore soleva, nei momenti disperati, spingere con
le spranghe di ferro e coi nerbi di bue; ma non poterono superare la resistenza dei
Cristiani. Furono costretti a ritrarsi. Le navi superstiti ripresero l'ancoraggio di
Bessikhtach.
Verso sera, Gabriele Trevisano e Zaccaria Grioni con due galèe rimorchiarono in trionfo i
quattro legni, tra squilli di trombe e canti di vittoria; poi richiusero il porto con la
catena.
Dopo la terza delle Cinque Giornate, quando cominciava a determinarsi la disfatta degli
occupatori, i soldati del Radetzky si abbandonarono ad atrocità che non cedono nel
paragone a quelle arabe e turche di Rebab. Dalla strage di Casa Fortis ai lattanti infissi
su le baionette, giova non enumerarle. La terzina della mano mozza allude a quella mano
feminile, carica d'anelli, che fu rinvenuta nella tasca d'un Croato ucciso.
Costantino Paleologo, il fratello di Giovanni, avendo accettata la corona di Bisanzio,
vera corona di spine, condusse con molta intrepidezza la difesa contro il secondo Maometto
che l'assaliva con uno sterminato esercito. I difensori non sorpassavano il numero di
settemila. Un Giustiniani, un Cattaneo, un Minoto, un Contarini, un Mocenigo, un Corner,
altri nobili veneziani e genovesi, erano alla guardia delle torri e delle porte. Quando
tutto fu perduto e l'esercito del sultano implacabile irruppe nella città per dare il
sacco di tre giorni promessogli, Costantino spronò il cavallo, nei pressi della Porta
Càrsia, contro il folto dei nemici, volendo morire con l'Impero. «Il sangue gli colava
dai piedi e dalle mani» dice Giorgio Phranres. Secondo Michele Ducas, lo storico
dell'Impero d'Oriente, l'imperatore gridò: «Non un cristiano v'ha, che prenda il mio
capo?» Secondo Michele Critopulo, gridò: «La città è presa, e io vivo ancóra!». In
quel punto un Turco gli tagliò la faccia. Come Costantino rispondeva al colpo, un altro
gli trapassò le reni. Cadde nel mucchio, non conosciuto. Più tardi, avendo Maometto
ordinato di ricercarlo, riconobbero i cercatori il cadavere ai calzati di porpora che
recavano trapunte in oro le aquile imperiali. I sovrani e i principi della Chiesa in
Occidente, dopo che con sì trista incuranza avevan lasciato abbattere l'ultimo segno
dell'Impero bisantino, alla notizia della vittoria turca rimasero atterriti; e temettero
che i giannizzeri non venissero a distruggere le imagini di Cristo nelle cappelle unghere
ed alemanne e che le basiliche romane non fossero mutate in moschee come quella Santa
Sofia dove Maometto aveva fatto pel primo il suo namaz su l'altar maggiore! Il marinaio
barese Vito de Tullio fu ferito a Tripoli nella battaglia del 26 ottobre. Era disceso
dalla nave Sicilia con la compagnia di sbarco. Quando giunse la notizia, tutto il popolo
della città vecchia passò in pellegrinaggio per la casa della madre; che si chiama
Serafina Daddario. Ferito a Bengasi fu il marinaio Luigi Carmineo, tra i primi a sbarcare
sotto il fuoco, in una barca gettata dalla nave Amalfi. Nella parte occidentale della
città vecchia, nella Piazza Mercantile, sta su quattro gradini il Leone veneziano, con
incise nel collare le parole «Custos iustitiae». Dopo la spartizione di Costantinopoli,
Venezia per assicurarsi il possesso delle Cicladi concesse che cittadini armatori di
galèe ne tentassero l'acquisto a lor rischio e pericolo. Fu allora composta per accordo
una compagnia di patrizii, la quale armò una squadra di corsa e la diede in comando a
Marco Sanuto. Il Sanuto non soltanto s'impadronì delle Cicladi, ma anche delle Sporadi e
delle isole sparse lungo la costa dell'Asia Minore. Egli fu investito della signoria
feudale di Nasso e d'Amorgo; poi, per decreto dell'Imperatore latino di Costantinopoli,
ebbe il titolo di duca dell'Egeo, con autorità su tutte le isole distribuite in feudo ai
suoi compagni d'armi, insuperabili marinai. Martino Zaccaria, figlio di Niccolò, per la
sua prodezza e per i suoi ardimenti si guadagnò il favore di Filippo di Taranto,
imperator titolare di Costantinopoli e principe d'Acaia, a tal punto che costui lo nominò
con diploma in data del 26 maggio 1315 re e despoto dell'Asia Minore e gli diede inoltre
Marmara, le Enusse, Tenedo, Lesbo, Chio, Samo, Icaria e Coo, con tutti i diritti regali e
con tutte le insegne della regalità. In compenso, Martino s'assumeva il carico
d'aiutarlo, con cinquecento uomini, a riconquistare il trono di Costantinopoli. Questo
Zaccaria con imperterrito zelo proseguì l'alleanza disegnata contro i Turchi da Marin
Sanudo nel 1329. Le sue spedizioni contro gli infedeli furon quasi sempre vittoriose.
Sembra che, durante i quindici anni di suo governo in Chio, egli ne uccidesse più di
diecimila. Come re dell'Asia Minore, aveva diritto di battere moneta. Esistono ancóra
monete d'argento del suo conio, con l'imagine di Santo Isidoro patrono di Chio. Dopo
avventure ammirabili, liete e tristi, nel 1343 si congiunse ai Crociati che facevano oste
contro Omar principe d'Aidin per impadronirsi delle Smirne; e cadde nella sanguinosissima
battaglia del 15 gennaio 1345. Egli può esser considerato come un vero eroe nazionale
ligure, stupendo rampollo di quella cavalleria greco-franca che aveva già sfolgorato di
gloria sul Mediterraneo. Converrebbe rinnovellare le lodi che gli inalza Uberto Foglietta
nei suoi Elogia clarorum Ligurum. Erano nel XIII secolo gli Zaccaria di Castro tra le più
opulenti e possenti famiglie di Genova. Traevano essi gran parte della lor ricchezza dalle
miniere di allume esercitate nel territorio di Focea. Quando il capitano popolano Simon
Vignoso, partitosi di Genova col naviglio nella primavera del 1346, ebbe riconquistata
Scio, il Comune dovette ben tenere il patto di rifondere agli armatori e conduttori della
guerra tutte le spese rilasciando alcuna parte di certe rendite dello Stato. Ma, essendo
assai smunto l'erario, il Governo stipulò con i capi della spedizione, il 26 febbraio
1347, un accordo che lor conferiva per anni ventinove il dominio utile e l'amministrazione
di Scio e di Focea Vecchia e Nuova, riserbando alla Republica la ragion della spada e del
sangue ed il mero e misto imperio (merum et mixtum imperium). Ogni padron di nave per tale
accordo aveva facoltà di partecipare al guadagno prodotto dal commercio del mastice e
dell'allume e dalle gabelle nei paesi conquistati. Così fu tra i conquistatori di Scio
costituita la società chiamata Maona, la cui storia gloriosissima è da ricordareagli
Italiani tutta quanta, dalla romana severità di Simon Vignoso ai diciotto giovini martiri
Giustiniani. Il nome di Giustiniani presero poi i Maonesi, come per congiungersi in una
vasta famiglia e dinastia, rinunciando ciascuno al nome suo proprio. E la Maona fu detta
allora dei Giustiniani di Scio. I primi dodici socii della corporazione, che fecero la
rinunzia e assunsero il nuovo nome, furono: Nicolò Caneto, Giovanni Campi, Nicolò di San
Teodoro, Gabriele Adorno, Paolo Banca, Tommaso Longo, Andriolo Campi, Raffaello di
Fornetto, Luchino Negro, Pietro Oliverio e Francesco Garibaldo. Il commercio più
importante e più remunerativo per la Maona era quel del mastice, prodotto nei quattro
distretti meridionali di Chio e raccolto da speciali agenti «officiales super
recollectionem masticis». I dinasti di Scio furono anch'essi tocchi dall'Umanesimo.
Ornatissimo fra gli altri fu quell'Andriolo Banca che, in grazia al suo sapere, divenne
amico di Eugenio IV. Cantò in versi italiani la guerra del 1431 contro Venezia. Le
lettere di Ciriaco d'Ancona a lui dirette hanno molti curiosi particolari su le rovine del
Tempio d'Apollo in Cardamyla e sul monumento d'Omero; presso il quale Andriolo aveva
costrutto all'ombra dei pini e al murmure d'un fonte una casa «omerica», procul
negotiis. Nella evocazione del sublime marinaio greco Costantino Canaris, si allude alla
impresa da lui compiuta contro il naviglio di Kara Alì ancorato in Cesmè, la notte del
18 giugno 1822. Egli aveva per compagno Pepinos nativo di quell'ammirabile Hydra «sì
nuda che in qualche luogo manca la terra per seppellire i morti», di quell'Hydra che fu
diletta ad Andrea Miaulis, all'audacissimo navarca sepolto nel Pireo presso la tomba di
Temistocle. I giovani palermitani dovrebbero in giorno di vittoria sospendere una corona
votiva al monumento del Canaris nella loro Villa Giulia. Lazaro Mocenigo, se bene
inimitabile anche nel peccare, meriterebbe d'esser canonizzato e proposto al culto di
tutti i marinai italiani. Forse neppure il Miaulis può essergli paragonato in audacia. Se
l'arte lunga e la vita breve concedessero all'autore di questa Canzone il poter compiere
tutto quel che disegna, egli vorrebbe scrivere la biografia di tanto eroe per metterla
nelle mani d'ogni guardiamarina della razza di Mario Bianco. Su la stupenda battaglia dei
Dardanelli convien rileggere le pagine del cronista testimonio riferite da Gerolamo
Brusoni nella sua Istoria dell'ultima guerra fra i Veneziani e i Turchi. Implacabile e
infaticabile il vittorioso «volle la sera stessa fare l'ultima prova; e così, seguitato
da quattro o cinque altre delle sue galere più rinforzate, intraprese di nuovo come la
mattina la caccia delle nemiche; dovendo intanto gli altri due generali col resto delle
galere scostarsi col favor della notte a danneggiare quelle che erano fermate in terra, e
se non fosse loro riuscito di tirarle fuori, incendiarle almeno. E però stavano già
formando d'una tartana un brulotto per condurvelo sopra. Ma dopo un difficoltoso
proveggio, arrivato il Mocenigo sotto le batterie de' Barbieri, che non meno furiose della
mattina offendevano gravemente le sue galere (avendo ammazzato sopra la Reale quindici o
sedici uomini, ed altri sopra la Provveditora, atterrato l'antenna sopra alla Capitana di
Golfo, e rotto il timone e parte della ruota alla Commissaria) quando già stava per
abbordare i legni fuggitivi, fu da una palla fatale colpito in Santa Barbara: onde preso
fuoco la munizione fece subito volare in aria la sua galera, non essendo restato intiero
che l'arsile con la poppa dove stando egli a Vigilare il comando non si abbrucciò: ma
cadendogli su la testa l'asta dello stendardo del calcese, lo fece cadere subito morto».
Il Mocenigo aveva perduto un occhio, il destro, alla battaglia del 26 di giugno 1656 nelle
acque di Scio, ove Lorenzo Marcello perse la vita. Venti navi del bassà Kenaan caddero in
mano dei Veneziani, preda fra le più insigni del mare. La prima edizione delle Canzoni
della Gesta d'Oltremare fu sequestrata il 24 gennaio 1912, a motivo di alcune terzine
della Canzone dei Dardanelli, che, a detta dell'Autorità politica, suonavano «ingiuriose
verso una potenza alleata e verso il suo Sovrano». Nella seconda edizione, che fu la
prima per il pubblico, le suddette terzine furono soppresse, e surrogate da puntini con la
seguente postilla: «Questa Canzone della Patria delusa fu mutilata da mano poliziesca,
per ordine del cavaliere Giovanni Giolitti capo del Governo d'Italia, il dì 24 gennaio
1912. G. d'A.». la terza edizione uscita nel luglio 1915, e questa definitiva, cambiati i
tempi e gli uomini, sono integrali; comprendono cioè anche le terzine che furono allora
soppresse.
L’intero Libro Quarto delle
LAUDI DEL CIELO DEL MARE DELLA TERRA E DEGLI EROI della Merope di D’Annunzio
IL PIACERE "Per noi Il Piacere" ha scritto Alfredo Gargiulo
"è il più riuscito romanzo del D'Annunzio. Di questo parere furono, se io non
m'inganno, il Verga, il Capuana e il De Roberto, buoni intenditori. È soprattutto un
romanzo 'ingenuo'. vale a dire che l'autore ritrae in esso, più o meno bene, un mondo
psicologico da lui in gran parte realmente vissuto nella fantasia... Conservò nelle parti
buone un tocco fresco e vivace, non inaridito mai dalla pretesa di arrivare a una
catastrofe estrinsecamente prestabilita". D' Annunzio stesso, nella dedica al pittore
Michetti della edizione dell'89, aveva scritto: "...Questo libro, nel quale io
studio, non senza tristezza, tanta corruzione e tanta sottilità e falsità e crudeltà
vane...". Ma lo studio, la tristezza "non portano mai realmente i segni di un
tal ardore morale contro le cose raccontate. Si lascia vedere bene, nel romanzo, una
fantasia innamorata del mondo singolarissimo che inventa o trasfigura. Ma non vi mancano
certo i chiaroscuri, le tinte aspre in modi, anche, profondi, e ironie molto fini. Nei
capitoli più disposti a valersene la mescolanza dei sapori dolci e agri con qualche
iperbolica droga sciolta, o meno, nella coppa del piacere, qui è grandemene te
suggestiva" (Giansiro Ferrata). Primo della trilogia dei "Romanzi della
Rosa", ispirati cioè al fiore che simboleggia la voluttà, Il Piacere rimase a lungo
il più famoso dei romanzi dannunziani, esercitando un'attrazione intensa su un gran
numero di lettori. Luoghi e personaggi, descritti con gusto pittorico, appartengono alla
Roma aristocratica della fine del XIX secolo. Il protagonista, il raffinato conte Andrea
Sperelli poeta e acquafortista, è la personificazione di D'Annunzio e persegue il suo
stesso ideale di vita, nutrito da sensazioni squisite e decadenti. La cornice del racconto
è un paesaggio che costituisce in un certo senso la vera anima del romanzo, e la storia
appare come un estremo omaggio ai morenti temi del romanticismo ottocentesco. Per
l'edonista Andrea Sperelli la morale, come ragione delle azioni umane, è ridotta a puro
valore formale. Libertino senza generosità e in perpetua contemplazione di se stesso,
Andrea è il tipo ideale di "amatore". Tuttavia egli è consapevole che la vita
sfrenata che conduce è solo un modo di sfuggire alla realtà e vorrebbe ritrarsene se
appena ne avesse la forza. Quando Elena lo abbandona, il nuovo amore per Maria Ferres
sembra poterlo salvare; ma, tornato a Roma, egli viene riafferrato dall'antica passione e
cade nuovamente nell'esistenza di prima. Il Piacere, col suo esplicito messaggio di vita
vissuta come disinvolta e insieme perfetta opera d'arte, si presenta quale sorta di
autobiografia spirituale di D'Annunzio, quale forse più compiuta trasposizione artistica
del suo ideale di estetismo e intellettualismo. È anche, come bene ha scritto L. Russo,
"il romanzo migliore, il romanzo più sincero, in cui l'estetismo del protagonista è
ancora una fede sicura di sé e, nella sua stessa teoricità, ha qualcosa di energico e di
operativo, che riscatta Andrea Sperelli da quelle ambizioni a vuoto che costituiranno
l'ingombro opaco dei posteriori romanzi".
….Appena smontò, fu accerchiato da amiche e da amici che si congratulavano. Miching
Mallecho, sfinito, tutto fumante e spumante, sbuffava protendendo il collo e scotendo le
briglie. I suoi fianchi s'abbassavano e si sollevavano con un moto continuo, così forte
che pareva scoppiare; i suoi muscoli sotto la pelle tremavano come le corde degli archi
dopo lo scocco; i suoi occhi iniettati di sangue e dilatati avevano ora l'atrocità di
quelli d'una fiera; il suo pelo, ora interrotto da larghe chiazze più oscure, si apriva
qua e là a spiga sotto i rivoli del sudore; la vibrazione incessante di tutto il suo
corpo faceva pena e tenerezza, come la sofferenza d'una creatura umana. - Poor fellow! -
mormorò Lilian Theed. Andrea gli esaminò i ginocchi per veder se la caduta li avesse
offesi. Erano intatti. Allora, battendolo pianamente in sul collo, gli disse con un
accento indefinibile di dolcezza: - Va, Mallecho, va. E lo riguardò allontanarsi. Poi,
avendo lasciato l'abito di corsa, cercò di Ludovico Barbarisi e del barone di Santa
Margherita. Ambedue accettarono l'incarico di assisterlo nella questione col marchese
Rùtolo. Egli li pregò di sollecitare. - Stabilite, dentro questa sera, ogni cosa.
Domani, all'una dopo mezzogiorno, io debbo essere già libero. Ma domattina lasciatemi
dormire almeno fino alle nove. Io pranzo dalla Ferentino; e passerò poi in casa Giustiniani;
e poi, a ora tarda, al Circolo. Sapete dove trovarmi. Grazie, e a rivederci, amici…..
….Nel ritorno, dal mail-coach del principe di Ferentino vide fuggire verso Roma
Giannetto Rùtolo con un piccolo legno a due ruote, al trotto fitto d'un gran roano
ch'egli guidava chinato avanti, tenendo la testa bassa e il sigaro tra i denti, senza
curarsi delle guardie che gli intimavano di mettersi nella fila. Roma, in fondo, si
disegnava oscura sopra una zona di luce gialla come zolfo; e le statue in sommo della
basilica di San Giovanni entro un ciel viola, fuor della zona, grandeggiavano. Allora ebbe
Andrea la conscienza intera del male ch'egli faceva soffrire a quell'anima. La sera, in
casa Giustiniani, disse all'Albónico: - Riman dunque fermo che domani, dalle due
alle cinque, io vi aspetterò. Ella voleva chiedergli: - Come? non vi battete, domani? Ma
non osò. Rispose: - Ho promesso…..
…Chi sono gli altri due? - Roberto Casteldieri e Carlo de Souza. Ci siamo sbrigati
sùbito, evitando le formalità. Giannetto aveva già pronti i suoi. Abbiamo steso il
verbale di scontro, al Circolo, senza discussione. Cerca di non andare a letto troppo
tardi; mi raccomando. Tu devi essere stanco. Per millanteria, uscendo di casa Giustiniani,
Andrea andò al Circolo delle Cacce; e si mise a giocare cogli sportsmen napoletani. Verso
le due il Santa Margherita lo sorprese, lo forzò ad abbandonare il tavolo, e volle
ricondurlo a piedi fino al palazzo Zuccari. Mio caro, - ammoniva, in cammino - tu sei
troppo temerario. In questi casi, un'imprudenza può esser fatale. Per conservarsi intatta
la vigoria, un buono spadaccino deve avere a sé medesimo le cure che ha un buon tenore
per conservarsi la voce. Il polso è delicato quanto la laringe; le articolazioni delle
gambe sono delicate quanto le corde vocali. Intendi? Il meccanismo si risente d'ogni
minimo disordine; lo strumento si guasta, non obedisce più. Dopo una notte d'amore o di
giuoco o di crapula, anche le stoccate di Camillo Agrippa non potrebbero andar diritte e
la parate non potrebbero essere né esatte né veloci. Ora, basta sbagliare d'un
millimetro per prendersi tre pollici di ferro in corpo….
Il Piacere di D’Annunzio: libro
primo - 5 -
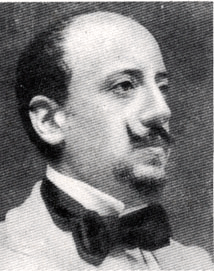

Nato a Pescara nel 1863, pubblicò a 16 anni una raccolta di liriche,
"Primo vere", cui fece seguito nel 1882 "Canto novo", di evidente
filiazione carducciana. A Roma, dove s’iscrisse alla facoltà di lettere,
D’Annunzio assimilò i fermenti del decadentismo europeo, dando vita ad alcuni
celebri romanzi quali "Il piacere" (1889), "Giovanni Episcopo" (1891)
e "L’innocente" (1892): dalla medesima ispirazione prendono corpo i versi
del "Poema paradisiaco" (1893), in qualche modo anticipatori di modi e stilemi
che caratterizzeranno, in seguito, la poesia crepuscolare. Successivamente, alla luce
delle teorie nicciane del "superuomo" tuttavia rielaborate in chiave
estetizzante, vengono forgiati romanzi ("Il trionfo della morte", 1894; "Le
vergini delle rocce", 1895; "Il fuoco", 1900) e drammi ("La città
morta", 1899; "La Gioconda", 1899) di sicuro valore; dipoi il Nostro,
ritiratosi nella villa La Capponcina a Settignano, si dà ad una intensa attività di
scrittura. Nascono così i primi tre libri ("Maya", "Elettra" e "
Alcyone") delle "Laudi del cielo, del mare, della terra, degli eroi", editi
nel 1903; le tragedie "Francesca da Rimini" (1902), "La figlia di
Iorio" (1904), "La fiaccola sotto il moggio" (1905), "La nave"
(1908), "Fedra" (1909), oltre al romanzo "Forse che sì forse che no"
(1910). Riparato in Francia in volontario esilio, dopo aver perduto la propria abitazione
per debiti, egli scrive nella lingua del paese che l’ospita "Le martyre de Saint
Sébastien" (1911), musicato da Debussy, ed il quarto libro delle "Laudi"
("Merope", 1912). Tornato in patria all’esplodere del primo conflitto
mondiale, si proclama da subito interventista e si distingue per le sue imprese belliche
(celebre la "beffa di Buccari" del 10 febbraio 1918): ferito ad un occhio, verga
le pagine del "Notturno", opera sua tra le più perfette e compiute. Ideatore,
terminata la guerra, della marcia da Ronchi a Fiume, si ritira infine nella definitiva
residenza di Gardone, da lui denominata il " Vittoriale degli Italiani ": ivi si
spegne, dopo un lungo periodo d’isolamento, nel 1938.
Le Opere di Gabriele
D’Annunzio scaricabili gratis da internet sul sito www.liberliber.it

Torna alla homepage di Enrico Giustiniani